Territori
Capitolo 3
Si trattava d’un tanfo che in poco riusciva a infettare e a corrompere tutta l’aria. Così la fiamma che dalle finestre più alte del Fabbricone si vedeva brillare verso nord, diventava il segnale di un fuoco nauseante e malefico che si ripeteva ogni sera.
Giovanni Testori
Il Fabbricone
Milano, Feltrinelli, 1961
Il progresso industriale trasforma in maniera spesso irreversibile i territori. Mutano innanzitutto le città, dove si concentrano le grandi fabbriche, a causa dell’arrivo di migliaia di uomini e di donne che si trasferiscono dalle campagne (in Italia in particolare dalle regioni del Mezzogiorno) con la speranza di avere un posto di lavoro nei siti industriali. Questo processo di inurbamento favorisce uno sviluppo dell’edilizia e apre nelle grandi città il problema della regolazione delle periferie, dello sviluppo dei trasporti e dei servizi (come asili, scuole, ospedali, negozi).
Deindustrializzazione
Il processo di deindustrializzazione avvenuto nei paesi occidentali a partire dalla metà degli anni Settanta ha posto il tema di vasti spazi da bonificare, ridisegnare e reinventare. Così alle fabbriche si sostituiscono i grattacieli, gli uffici, le residenze di lusso, i centri commerciali. Questa trasformazione ha cambiato radicalmente il tessuto sociale e l’identità di interi territori.
Riqualificazione
Alcune realtà hanno saputo rispondere alla sfida del cambiamento imboccando percorsi di riqualificazione e innovazione. Altri hanno subito dinamiche di declino e decadenza e devono ancora trovare una strategia di sviluppo capace di cogliere nuove opportunità. Su questi scenari impattano i flussi migratori, formati da lavoratori che provengono da paesi lontani anche migliaia di chilometri, ponendo con forza la questione della convivenza, dell’integrazione e della ricerca di nuove forme di cittadinanza.
Guarda la photogallery
L’articolo di Negri consente di riflettere sull’impatto dello sviluppo industriale nel tessuto urbano da due angoli visuali differenti: alla grande “esplosione” dell’universo industriale di inizio Novecento – con l’affermazione dei primi grandi impianti – corrisponde l’”implosione” degli anni Ottanta, periodo in cui – a causa della deindustrializzazione – si registra un progressivo smantellamento delle fabbriche.
1. Antonello Negri, I luoghi del lavoro, in “Archeologia industriale”, a. I, n° 1, Luigi Micheletti editore, Brescia, giugno 1983, p. 9.
“Esistono numerose vedute di officine meccaniche, non databili con precisione ma risalenti al primo decennio del XX secolo, che mostrano il nuovo rapporto tra la città e l’industria, definitosi nei decenni a cavallo del 1900 in termini sempre più chiari. Ai primi grandi insediamenti a sviluppo orizzontale degli anni ‘70 e ‘80 (dalla De Angeli alla Breda e alla Pirelli) che potevano ancora costruire episodi relativamente marginali – non dal punto di vista delle dimensioni – rispetto al tessuto e alla forma della città, si aggiungono numerosi impianti estesi su grandi aree che, pur trovandosi al loro sorgere alla periferia della città, in aperta campagna, appaiono destinati a divenire presenze caratterizzanti il tessuto costruito della nuova città novecentesca”.[…] “Delle 77 fabbriche individuate sulla pianta del 1884 rimane oggi molto poco. Della cartiera Binda la ricostruzione successiva a un incendio; della prima Richard alcuni capannoni in mattoni di difficile datazione, anche perché evidentemente ristrutturati e modificati a più riprese; della Società lombarda di prodotti chimici un fronte lungo via Tortona, certamente più tardo rispetto alla data di inizio di attività di questa industria; della De Angeli frammenti del muro di cinta dell’enorme stabilimento; il molino Mosca, abbandonato, è invece pressoché integro e costituisce forse il più significativo reperto industriale ottocentesco della città”.
2. Archivio Duccio Bigazzi, Planimetria Stabilimento al Portello, copia fotostatica
Approfondimento
Vulnerabilità \ Dal disastro al cambiamento
Acqua: risorsa comune, sociale e collettiva
AAA pianificatori cercasi. Periferie, immigrazione e rigenerazione urbana
Acqua e resilienza: per una governance locale dei beni comuni
Vulnerabilità \ Dal disastro al cambiamento

I terremoti, le alluvioni e le epidemie possono provocare disastri. Talvolta ci si riferisce a questi accadimenti come se fossero eventi “naturali” mettendo l’accento sui fenomeni che li provocano come il rilascio di energia nel sottosuolo, le precipitazioni atmosferiche o la diffusione di un virus. I disastri, tuttavia, non sono affatto “naturali”. Essi dipendono dalla capacità o dall’incapacità di un sistema sociale di dominare la variabilità del suo ambiente; dipendono, cioè, dalla sua vulnerabilità sociale. Il concetto di vulnerabilità sociale – introdotto negli anni ’80 del secolo scorso per studiare i disastri – si basa su due principi. Da un lato, quello secondo cui è l’organizzazione sociale a generare le precondizioni di ogni evento che viene poi definito come disastro. Dall’altro, quello secondo cui esiste uno stretto legame tra le dinamiche sociali che seguono il disastro e lo stato di un sistema sociale prima del suo verificarsi.
Ci sono tre tipi di vulnerabilità sociale. Il primo tipo di vulnerabilità – la micro vulnerabilità – include i fattori che determinano la probabilità di evitare o di minimizzare gli effetti di specifici eventi potenzialmente nocivi. Nel caso di un terremoto, per esempio, il grado di distruzione dipende dalla capacità delle strutture fisiche di assorbire un forte rilascio di energia. Tale capacità dipende a sua volta dalle tecniche costruttive impiegate in una comunità locale o in una regione, dai materiali utilizzati, dalle scelte urbanistiche compiute prima dell’impatto. Nel caso di un’epidemia, l’impatto in termini di contagi o di decessi dipende dalla disponibilità di un vaccino, di terapie efficaci, di strutture ospedaliere adeguate e di un efficace presidio medico sul territorio. La micro vulnerabilità, quindi, determina direttamente la dimensione del danno provocato dall’impatto dell’evento disastroso.
Il secondo tipo di vulnerabilità – la meso vulnerabilità – si riferisce, invece, alla distribuzione delle risorse economiche, organizzative e culturali tra gli individui, le famiglie e le organizzazioni che compongono la comunità o la regione colpite e riguarda, quindi, il livello del loro sviluppo economico e il grado della loro stabilità culturale e politica. La meso vulnerabilità influenza direttamente sia il livello della micro vulnerabilità nel periodo che precede il verificarsi del disastro sia la capacità di rispondervi.
L’ultimo tipo di vulnerabilità, infine, riguarda il grado di sviluppo socioeconomico, organizzativo e tecnologico della società alla quale appartengono la comunità o la regione colpite. La macro vulnerabilità dipende dalla disponibilità di risorse economiche, organizzative e culturali, dal grado di connessione tra comunità locale e stato nazionale, e dal grado di connessione tra stato nazionale e comunità internazionale. Il grado di macro vulnerabilità di una società influenza direttamente il livello di vulnerabilità micro e meso e l’efficacia della riabilitazione dopo l’impatto. Sono, dunque, le caratteristiche della comunità o della regione colpite prima dell’impatto, quelle del mondo che le circonda e le relazioni tra comunità o regione e mondo circostante a determinare congiuntamente la portata del disastro e la possibilità di reagire efficacemente a esso.
Lo schema interpretativo basato sulla vulnerabilità sociale si adatta al caso della pandemia Covid-19. La diffusione del virus SARS-CoV-2 è stata globale, tuttavia, le conseguenze della sua diffusione sono state territorialmente differenziate. Covid-19 ha colpito comunità locali, città, regioni, paesi o interi continenti in modo differente. Per studiare questo disastro, quindi, si può ricorrere a uno strumento consolidato delle scienze sociali come la comparazione. Confrontando gli stati di uno o più oggetti sulla medesima proprietà in uno o più momenti nel tempo, si possono stabilire somiglianze e differenze significative nella vulnerabilità di unità sociali distinte. Si possono, innanzitutto, confrontare singole organizzazioni. In alcune residenze per anziani della città di Milano, per esempio, non si sono registrati contagi né decessi, in altre, invece, sì. Confrontando due distinte residenze in base a proprietà comuni – come le dotazioni strumentali, le caratteristiche del personale, le scelte organizzative operate nell’emergenza, il rapporto con soggetti esterni – si possono raccogliere informazioni cruciali sulla loro vulnerabilità. Lo stesso può essere fatto confrontando due comunità locali della stessa regione come, per esempio, Codogno e Alzano in Lombardia, o due regioni italiane come la Lombardia e il Veneto, o due stati europei come l’Italia e la Germania.
In passato, le ricerche sui disastri e, in particolare, sui terremoti hanno mostrato come un disastro non possa essere considerato come un evento indipendente dalla struttura sociale della società o della comunità in cui si verifica ma come un evento dipendente da essa. Ciò vale anche nel caso della pandemia Covid-19. Essa, con le sue gravissime conseguenze per la popolazione e l’economia, si presenta a noi come una cartina di tornasole di alcuni tratti caratteristici della struttura sociale delle società e delle comunità colpite e del loro livello di organizzazione sociale. Accesso diseguale alle cure e al sistema sanitario, diseguaglianze nel mercato del lavoro, disparità di istruzione, effetti dell’invecchiamento e condizione di svantaggio delle persone anziane, digital divide, sono solo alcuni dei fenomeni sociali preesistenti alla diffusione del virus la cui portata e rilevanza sono state accentuate dalla pandemia (Anzivino, Ceravolo e Rostan 2020).
Il concetto di vulnerabilità sociale, tuttavia, non aiuta soltanto a prestare attenzione a ciò che c’era “prima” del disastro ma anche a ciò che avviene “dopo”. Secondo questa prospettiva, la capacità di risposta a un disastro, l’andamento e l’esito del processo di riabilitazione, ripresa e ricostruzione, dipendono dalla disponibilità di risorse economiche, organizzative e culturali all’interno e all’esterno delle comunità colpite e dalle relazioni tra queste comunità e il mondo circostante. Ciò che avviene “dopo” si presenta, quindi, come il risultato di un complesso gioco di relazioni interne ed esterne alla comunità colpita che hanno come oggetto la richiesta, l’ottenimento, l’uso, il controllo di risorse di vario tipo. Nel caso dei terremoti, i processi di ricostruzione hanno visto il coinvolgimento di almeno due parti. Da un lato, la comunità colpita e la sua élite; dall’altro, le autorità centrali o periferiche responsabili degli aiuti. All’élite locale sono state attribuite le decisioni rilevanti in materia di ricostruzione a livello della comunità, mentre alle autorità centrali o periferiche sono state attribuite le decisioni rilevanti prese al di fuori della comunità. I terremoti sono stati spesso interpretati come un’occasione per realizzare un mutamento sociale. È possibile che anche la pandemia Covid-19 offra questa opportunità ma, nel caso dei terremoti come in quello della pandemia, il fatto che un disastro possa indurre un cambiamento non significa che esso si realizzi effettivamente. In entrambi i casi, il futuro sta in gran parte nelle mani delle comunità colpite e delle loro élite.
Acqua: risorsa comune, sociale e collettiva

Di seguito, un estratto dall’ebook, Paesaggi d’acqua. Milano e dintorni, a cura di Bianca Dendena, pubblicato da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
L’ampiamente adottata definizione di oro blu in riferimento all’acqua evidenzia come una risorsa basilare e prioritaria, bene comune dell’umanità, rappresenti, in maniera sempre più evidente e marcata, un interesse economico tale da essere paragonato a un bene di consumo e di mercato. Interrogarsi circa le implicazioni sociali e le responsabilità collettive connesse all’accesso e all’uso dell’acqua è materia di speculazioni tutt’altro che recenti, come dimostra la riflessione articolata da Gian Domenico Romagnosi che, già nel 1829, pose in luce alcuni aspetti sociali della sua governance in ambito rurale.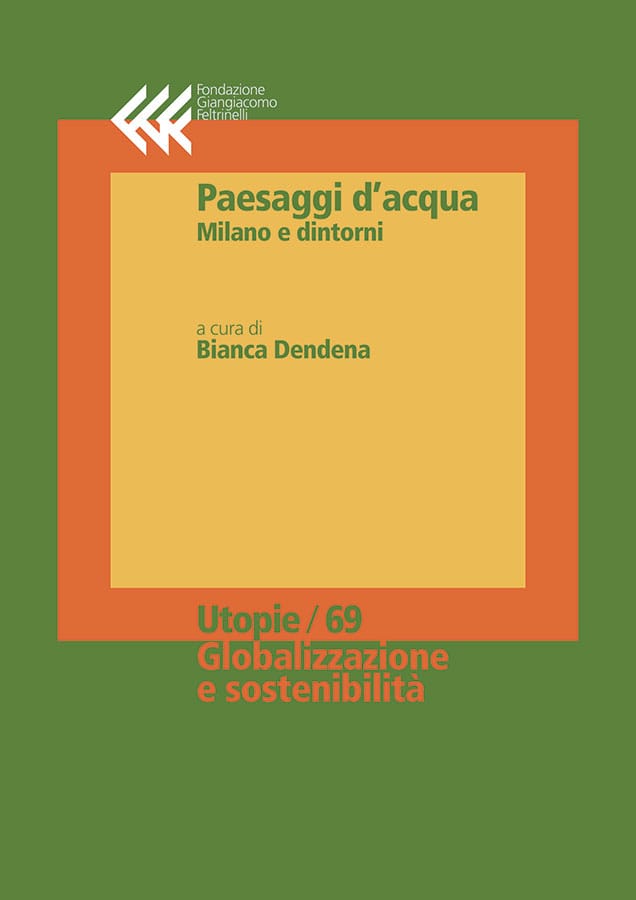
L’acqua, in quanto bene senza forma non suscettibile di proprietà esclusiva come altre cose materiali, è stata a lungo considerata, in termini di diritto, una risorsa illimitata soggetta al massimo sfruttamento. Tuttavia è diventata, in anni recenti, un tema di dibattito e di rivendicazione di rilievo globale da parte di movimenti e associazioni di diversa natura che ne hanno proposto varie formulazioni normative.
Ampiamente diffusa è, a questo proposito, l’idea dell’acqua come “bene comune universale”, che, in virtù di tale definizione, non può essere oggetto di un diritto patrimoniale da parte di soggetti privati votati al suo impiego commerciale con finalità di profitto. Secondo tale interpretazione, l’acqua è un dono della natura e può, quindi, essere oggetto solo di un “diritto naturale” del quale sono titolari tutti i membri dell’umanità. Questa interpretazione, che si inquadra in una sorta di giusnaturalismo idrologico, si caratterizza, spesso, per particolarismi spiritual-religiosi di grande suggestione permeati di una forte ideologia globalistica ed ecologica.
A latere di questa visione del diritto all’acqua che la inquadra quale bene che la natura ha messo a disposizione di tutti, si delinea una posizione che ne propone una caratterizzazione di tipo sociale. Tale possibile interpretazione mutua l’approccio analitico che è stato applicato, in altra sede, al diritto alla vita. Il paradigma del diritto alla vita quale fu teorizzato alle origini della civiltà giuridica moderna – come “diritto a non essere ucciso” e cioè come immunità o “libertà negativa” – ha subito profonde modifiche nel tempo fino ad assumere l’accezione di “diritto alla sussistenza”. In quest’ottica, contrariamente all’ideologia liberale classica per la quale la sopravvivenza è un fenomeno naturale, affidato al rapporto dell’uomo con la natura, oggi sopravvivere non è più considerato un fatto naturale, bensì un fatto sociale, affidato alle possibilità di lavoro, di consumo e di sussistenza offerte, mediate, amplificate dall’integrazione sociale. Pertanto, trasponendo tale riflessione al diritto all’acqua come diritto alla sopravvivenza, questo diventa un diritto alla solidarietà sociale, analogamente al diritto alla salute, all’istruzione, alla casa, e lo colloca entro le questioni di cui deve occuparsi la collettività politica. Si tratta di un “nuovo” diritto sociale, perché nuovo è il bisogno ad esso sottostante, generato dalla crescente scarsità del bene necessario nella congiuntura attuale di una popolazione mondiale che cresce, diversifica ed incrementa i suoi bisogni alla luce di un clima che cambia ed esercita sulle risorse idriche una pressione senza precedenti.
[…] presso molte comunità sociali il diritto all’acqua assurge a tutti gli effetti a diritto d’identità di un gruppo che va ben oltre la condizione della sua mera sopravvivenza. La negazione del diritto all’acqua, così come ad altre risorse, e l’erosione della governance sociale su quelle che ne garantiscono non solo il sussistere, ma anche l’espletamento di una serie di funzioni sociali e culturali, ledono l’identità culturale di un gruppo, di una collettività: di una comunanza. Se l’identità collettiva non viene più elaborata e sostanziata attraverso l’esperienza socializzata della coltivazione dei campi, della modulazione del territorio, dello sfruttamento sostenibile di questo attraverso l’integrazione delle attività produttive con quelle artigianali, della trasmissione degli usi e dei miti, così come di quelle arti e quei mestieri propri di una civiltà in un dato luogo in un dato spazio, la cultura di un popolo si riduce a un contenitore vuoto in cui gli individui rivendicano singole esigenze puramente economiche, espresse in termini di necessità di usufrutto e consumo. Se, invece, il rapporto sociale con l’acqua e con le risorse a essa strettamente associate, prima fra tutte il cibo, è rispettato, valorizzato e protetto nelle sue forme descrittive della comunanza, il diritto all’acqua assume l’importante valenza simbolica di diritto comunitario e non semplicemente dei singoli membri del gruppo la cui rilevanza, quindi, si esprime nel momento in cui esercitano i propri diritti scambievoli. Questo connubio tra la risorsa acqua, territorio, sviluppo – sia esso economico, infrastrutturale o culturale –, paesaggio, qualità dell’ambiente, costumi sociali e alimentari e valori etico-religiosi ha profonde radici storiche … […] un legame, quello tra acqua e civiltà, che è continuato nel corso dei secoli e ha reso le città che sull’acqua vantavano una posizione di privilegio – accesso, controllo, dominio – punti di snodo economico e culturale che ne hanno decretato lo splendore e l’affermazione nel panorama storico e sociale di diverse epoche: è questo il caso, per esempio, di Venezia, Amburgo, Amsterdam, San Pietroburgo e Milano, quest’ultima naturalmente dotata di una ricchezza d’acqua unica nello scenario europeo, le cui ingegnose modalità di sfruttamento ne hanno determinato lo sviluppo basato su una fiorente economia rurale, prima, e industriale, poi, che ha destato meraviglia per secoli.
Di questa meraviglia, oggi, siamo chiamati a custodire la memoria e a fare tesoro attraverso una lettura attenta delle testimonianze storiche e l’interpretazione dei paesaggi agrari e urbani, storicamente e intimamente connessi gli uni agli altri, così come all’ecosistema entro il quale la comunanza di cui siamo parte esercita il diritto alla sua unicità.
AAA pianificatori cercasi. Periferie, immigrazione e rigenerazione urbana

Con oltre 5 milioni di stranieri regolarmente presenti (Idos, 2018), dei quali il 70% “a tempo indeterminato” (perchè comunitari o con permesso di lungo periodo), l’immigrazione in Italia è ormai un fenomeno strutturale e consolidato. A questi si aggiunge una popolazione più fluttuante e in parte potenzialmente ‘temporanea’ costituita dai richiedenti protezione internazionale, assai più ridotta (c.a. 180 mila, secondo l’ultimo rapporto della fondazione Migrantes) ma talmente mediatizzata e strumentalizzata negli ultimi anni da essere comunemente percepita come “l’unica” immigrazione presente. Questi nuovi arrivi, comunque, alimentano solo in minima parte le diversità e pluralità che già da tempo caratterizzano gran parte delle città italiane, grandi o piccole che siano, soprattutto del centro-nord ma sempre più anche nel mezzogiorno.
Eppure il fenomeno continua ad essere letto, presentato, percepito e trattato – complici i toni sempre allarmistici dei media (vedi l’ultimo rapporto Carta di Roma) e i martellanti proclami di partiti e movimenti populisti che in modo palesemente strumentale fanno degli immigrati il capro espiatorio di problemi ben più complessi – come una perenne emergenza e, in quanto tale, da trattare con misure straordinarie. Dal decreto Maroni del 2008 (poi convertito nella L.38/2009) che ha dato il vialibera ai Sindaci di emettere ordinanze – spesso permeate di razzismo e classismo – al “nobile” fine di garantire decoro e pubblica sicurezza, al DASPO urbano, ai Centri di Accoglienza Straordinaria per i richiedenti asilo, le questioni legate all’aumento dell’immigrazione, della diversità e pluralità sono politicamente affrontate come emergenze e spazialmente confinate in ambiti periferici.
Nell’Italia contemporanea, gran parte dei luoghi percepiti nell’immaginario colettivo come ‘periferie’ sono infatti quelli dove ci sono “tanti”, “troppi” immigrati: che ci vivono e/o che ne fanno uso (per incontrarsi, per vendere o acquistare prodotti etnici, per passare il tempo libero). Quartieri o singoli edifici caratterizzati da un progressivo degrado (fisico, economico e/o sociale) e dal conseguente declino del valore immobiliare, dai quali chi poteva permetterselo se ne è andato, hanno lasciato numerosi spazi vuoti –abitativi e commerciali – accessibili più di altri a chi, come gli immigrati, ha in media lavori meno retribuiti. Attenzione però: sebbene si tratti di aree con crescente percentuale di residenti stranieri, non ci troviamo quasi mai di fronte a incidenze superiori al 20 o 30%. Non sono Banlieux, e la mixité (per lo meno quella tra italiani e stranieri, se non quella tra poveri e benestanti) è un dato di fatto, pur non ‘pianificata’ ma indotta da dinamiche di mercato. Si tratta però di ‘quartieri di scarto’ dove rischi, disagi e situazioni difficili si stratificano e dove la concentrazione di vulnerabilità avvia processi cumulativi che aggravano il problema di partenza, alimentando una spirale di povertà ed esclusione socio-spaziale con alto rischio di indebolimento del tessuto sociale, segregazione dal resto della città, stigmatizzazione. All’interno di queste aree la convivenza, il vivere insieme nella differenza (Fincher, ), se non mediata, come minimo acutizza la frammentazione urbana, quando non sfocia in aperto conflitto.

Un lavoratore fa una pausa in un cantiere vicino ai nuovi grattacieli e agli hotel in costruzione a Doha
Spazialmente, queste ‘periferie’ non stanno solo ai margini delle città, nei quartieri popolari a ridosso di grandi vie di comunicazione o isolati in quel che è rimasto dei grandi sogni modernisti dell’utopia urbanistica. Sono anche nei centri storici: nelle città più grandi solitamente nei dintorni delle stazioni ferroviarie centrali, a Milano come a Firenze o Roma, ma anche Padova, Ferrara, e così via; nei centri urbani più piccoli, o nelle aree interne in declino demografico, le ‘periferie’ spesso coincidono con il cuore antico e decadente, semi-abbandonato dagli italiani per standard di vita o modelli abitativi più appetibili e individualisti (tipo la villetta a schiera) che hanno consumato suolo e svuotato il downtown.
Non solo gran parte degli immigrati economici “occupano” i vuoti lasciati dagli italiani – nel mercato abitativo come in quello del lavoro – riciclando (e perchè non dire, rigenerando?) spazi di ‘scarto’ inutilizzati e antichi o umili mestieri, ma lo stesso trend, con conseguente sovrapposizione delle due popolazioni, si rileva nel sistema di accoglienza dei richiedenti asilo. Sia gli SPRAR sia la ben più ampia costellazione di CAS, sono per lo più confinati ai ‘margini’ in periferie ‘sacrificabili’, dove tanto i problemi sono già tanti, siano esse collocate in piccoli comuni dove il bacino elettorale è ridotto (e quindi non si perdono tanti voti), siano le ‘classiche’ periferie urbane o quartieri centralissimi ma ‘degradati’. Stessa dinamica: riempimento ‘casuale’ (unplanned) di vuoti urbani, che le cooperative che lavorano nell’accoglienza riescono a reperire a basso costo: ex-caserme, ex-scuole, ex-alberghi, ex-case… per gli extra-comunitari. Un patrimonio che viene anche riqualificato, perchè fortunatamente gran parte degli enti gestori cercano di offrire standard dignitosi agli ospiti e investono parte del budget per l’accoglienza nel ripristino e manutenzione degli immobili che utilizzano. Il problema è che ciò avviene nella totale assenza di una qualche forma di pianificazione strategica. La gestione emergenziale dell’accoglienza si traduce in una folle corsa a reperire spazi, su richiesta urgente della prefettura di turno, per accogliere chi arriva e viene redistribuito sul territorio rincorrendo il buon principio dell’accoglienza diffusa su scala nazionale, che però dovrebbe essere declinato anche a livello locale con studi che valutino impatti e opportunità nel medio e lungo termine per i contesti di inserimento. In tal senso, una pianificazione strategica e partecipativa sarebbe estremamente utile per mappare, individuare e ragionare collettivamente su quali, tra i tanti immobili (pubblici o privati) disponibili, puntare per limitare conflitti e rigenerare – con progetti integrati che promuovano l’inclusione e l’intercultura – edifici dismessi che possano essere ‘restituiti’ alla città, aperti e permeabili al pubblico, al quartiere dove si trovano, alle contaminazioni ed interazioni tra le persone, magari pensando a usi e funzioni (social housing, studentati, laboratori, turismo sociale, etc.) che possano subentrare quando e se non ci saranno più migranti da ospitare, o anche coesistere fin da subito per contrastare frammentazione e ghettizzazione e favorire la mutua conoscenza, il vivere insieme nella dfferenza (Valentine, 2008).
Certo, nelle aree divenute via via più multiculurali, negli anni sono state promosse – soprattutto dal terzo settore ma anche da alcune amministrazioni più illuminate – innumerevoli pratiche per integrare, conoscere, mediare, costruire ponti, contrastare stereotipi, offrire opportunità di interazione costruttiva tra gli abitanti.
Assente ingiustificata, però, è la pianificazione urbana e territoriale (Marconi, 2014) che, a fronte dell’incalzante aumento delle diversità e della pluralità sociale e culturale in molte periferie, non ha mai saputo (o voluto) assumere alcun ruolo di rilievo – politico, prima ancora che tecnico – nel governo delle trasformazioni che il fenomeno inevitabilmente comporta sul tessuto socio-spaziale urbano, sulla civitas e sull’urbs. Pianificatori territoriali e urbanisti, che “dovrebbero saper ascoltare la società, individuare le esigenze che sollecitano alla costruzione di una città bella perché buona, perché equa, perché aperta. E a quelle esigenze dovrebbero saper dare risposte” (Salzano, 2009) sono stati per lo più assenti dal discorso pubblico sulle migrazioni. Nelle società urbane plurali, dove si moltiplicano le domande di città, e le richieste di ‘diritti’ (d’uso dei suoli, di parola, di partecipazione e di coesistenza) ci si aspetterebbe invece che fossero proprio urbanisti e pianificatori a portare avanti un significativo discorso sulla diversità, l’integrazione e la convivenza plurale (quindi anche sull’idea stessa di città, di urbanità e di civiltà urbana) assumendosi la responsabilità innanzitutto etico-disciplinare di prendere in considerazione un fenomeno tanto rilevante per il presente ed il futuro delle città, e poi sul piano tecnico-professionale di contribuire a governarlo svolgendo una delle funzioni per le quali sono più equipaggiati: quella di mediazione e sintesi tra interessi diversi e contrapposti, propri dei soggetti diversi che popolano l’ambiente urbano (Marconi, 2014). E in questo senso, il tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo sembra tanto un’altra occasione persa.
Acqua e resilienza: per una governance locale dei beni comuni

L’emergenza acqua sta in questi giorni raggiungendo il picco massimo dell’attenzione mediatica, in particolare per le conflittualità generate dalle formule di gestione nell’approvvigionamento idrico in alcune aree del Paese. Un esempio di particolare gravità ha interessato il comune di Roma (e la multi-utility Acea) con i comuni del Lago di Bracciano, che si sono visti ridurre la portata del bacino, in termini drammatici, in prossimità della stagione turistica.
Quali sembrano essere le cause? Ad una prima occhiata sicuramente la concomitanza tra fattori metereologici delle temperature (di 2.5 gradi superiori alla media) e riduzione delle precipitazioni (del 53% inferiori alla media), che a partire dal mese di marzo hanno ridotto notevolmente la portata delle fonti di approvvigionamento idrico del nostro Paese.

La chiusura delle fontane pubbliche “i nasoni” di Roma rappresenta le contraddizioni politiche nelle formule di gestione dei beni comuni, con evidenti criticità nelle conseguenze di queste azioni.
Le criticità però non riguardano solo Roma e non solo questa stagione dell’anno. Negli anni e nei mesi scorsi in diverse regioni italiane le condizioni si sono rivelate particolarmente critiche. Nel bacino del Po, ad esempio, la lunga siccità ha portato in questi giorni il livello del fiume a scendere di un metro rispetto la profondità media stagionale. Nel Veneto, i fiumi in secca e le montagne senza nevi stanno creando forti danni alle colture agricole e al paesaggio. In Lombardia, il livello del lago di Como e del Lago di Iseo sono rispettivamente calati al 43 e al 35 percento rispetto al loro livello abituale in questa stagione (fonte: Coldiretti).
Come possiamo interpretare questo fenomeno? Quali errori commettiamo nella gestione e perché ci troviamo a far fronte a costanti situazioni di emergenza nell’accesso alle risorse idriche?
I cambiamenti climatici ci pongono sicuramente di fronte a sfide inedite, che rimettono in discussione il modo in cui siamo abituati a gestire le infrastrutture, le formule di approvvigionamento, gli usi diversificati delle produzioni agricole.
Insieme al tema ambientale però, bisogna riconsiderare la questione ad un ambito tanto economico quanto politico che riguarda la gestione dei beni comuni nel nostro Paese. Un tema cruciale, dato il danno stimato in 14 miliardi di euro (Coldiretti) come prodotto dalle continue siccità dello scorso decennio.
Ma cerchiamo di vederci chiaro: In Italia circa il 100% della popolazione rurale e urbana ha accesso all’acqua, il 70% ad un sistema di fognatura; sistemi per la totalità pubblici, regionali o municipalizzati. Ben sette anni fa, il referendum sull’acqua come bene pubblico ha visto un grande momento di partecipazione politica dell’elettorato italiano, sia nella campagna referendaria (1.4 ML di firme su 500.000 richieste) fino alle votazioni del referendum(su 27,6 ML di votanti, il 95% contro la privatizzazione).
I risultati gestionali però, a partire da quel momento di grande passione democratica, non sono stati entusiasmanti. In molte parti d’Italia, in particolare al sud, è diventato molto difficile far fronte alle vulnerabilità di un sistema centralizzato che sembra letteralmente “far acqua da tutte le parti”. In particolare nel rapporto conflittuale tra domande per usi civili e le richieste diversificate del settore agricolo, che rendono l’accessibilità all’acqua un tema sempre più scottante. Tema che diventa ogni anno più grave, data la generale assenza di strategie e misure di promozione di investimenti nelle infrastrutture e nelle tecnologie dedicate al riciclo delle risorse e alle nuove forme di approvvigionamento.

Con la crisi degli ultimi mesi, molte autorità regionali hanno imposto divieto temporaneo di prelievo dell’acqua dai fiumi, con ingenti danni alle produzioni agricole.
Altro annoso e noto problema sono le perdite della grande rete, che costituiscono nella media nazionale ben il 32% delle risorse idriche trasportate, con percentuali che arrivano in alcune aree fino al 70%, per Roma intorno al 45% (fonte: ispra; con eccezioni, tra le altre, di Milano con il 10%;). Medie inaccettabili, specialmente se paragonate con il 20% della Francia, il 10% del Regno Unito ed il 6% della Germania.
Un problema, quello dell’approvvigionamento idrico, che nel nostro Paese invece di sollecitare nuove e più dinamiche formule di governance locale, misure di prevenzione e mitigazione, vede il ruolo attivo della Protezione Civile nel controllare e gestire l’allocazione delle risorse nelle situazioni di già inoltrata emergenza.
Dove è finita la passione democratica ed ecologista del famoso referendum? Sembra essere sommersa come il costo dell’acqua potabile, in Italia tra i più bassi d’Europa: 25 euro al mese (circa lo 0,9% della spesa media mensile di una famiglia) contro i 22 del consumo di acque minerali (altri dati sul tema sono racchiusi in questo prezioso articolo del gruppo hera).
Occorre andare oltre la retorica della gestione pubblica, proponendo nuove formule capaci di promuovere investimenti in questo prezioso bene. Investimenti che non possono essere garantiti solo dai comuni e dalle regioni (spesso indebitati e incapaci a gestire le reti) ma da formule resilienti e locali di approvvigionamento: diversificate in relazione all’uso, orientate ai principi dell’economia circolare, decentralizzate ed eco-sostenibili.
Un discorso valido per la gestione delle risorse idriche, ma applicabile agli altri servizi a rete (l’elettricità ad esempio, World Bank ci dice che sprechiamo il 6%), per cui occorre costruire capacità e liberare nuove forme di competenze, capacità e responsabilità locali che siano concorrenti alle grandi reti ed ai operatori pubblici e privati.




