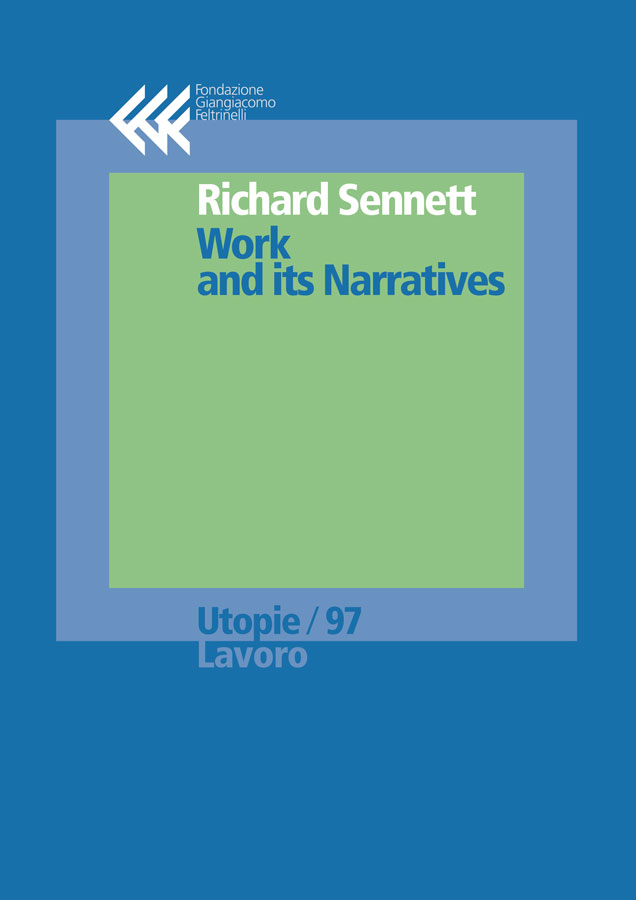Tempo
Capitolo 8
In questo mondo nuovo si chiede agli uomini di cercare soluzioni private a problemi di origine sociale, anziché soluzioni di origine sociale a problemi privati.
Zygmunt Bauman
Capitalismo parassitario
Roma-Bari, Laterza, 2009
La rivoluzione industriale produce significativi cambiamenti per quanto riguarda la gestione e la percezione del tempo perché l’affermazione del sistema di fabbrica porta per la prima volta a distinguere in modo molto chiaro non solo luogo di abitazione e luogo di lavoro, ma anche tempo di lavoro da quello che non lo è.
Tempo libero
Tra Otto e Novecento si verifica un’ulteriore importante passaggio, perché mentre si riduce in maniera significativa l’orario di lavoro si afferma un tempo libero che viene istituzionalizzato e assume dimensioni di massa quando vengono introdotte le ferie retribuite.
Eterno presente
L’affermazione delle nuove tecnologie ha cambiato radicalmente l’uso del tempo: l’iper connettività travolge infatti la barriera tra i tempi di vita e tempi di lavoro e produce un’accelerazione di tutte le attività umane che offre solamente l’illusione di avere più tempo a disposizione mentre minaccia di imporre nei fatti una sorta di “tirannia del presente”, di costringere le attività umane in ritmi sempre più frenetici. Quali strategie e/o politiche occorre quindi adottare perché le tecnologie digitali non costruiscano un nuovo grande divide tra chi riesce a utilizzarle per potenziare le sue possibilità e chi invece ne diventa schiavo?
Guarda la photogallery
Nella conferenza tenuta dal leader socialista italiano, il tempo di lavoro assume la veste di dichiarato obiettivo politico da perseguire; al netto della scansione sempre più serrata dei ritmi lavorativi, le “8 ore” rappresentano non solo una battaglia politica, ma anche – e forse soprattutto – la volontà di sottrarsi ad un modello occupazionale sempre più cadenzato dalla macchina – paradigma della civilizzazione industriale, l’orologio.
1. Filippo Turati, Le 8 ore di lavoro: sunto stenografico della conferenza pronunciata in Milano nel Teatro della Canobbiana il 1. maggio 1891, Milano, Critica Sociale, 1892, pp. 21-22.
“Con le otto ore il proletariato militante fa un passo gigantesco. Per esse potrà provvedere seriamente a sviluppare la solidarietà che gli è necessaria nella sua grande battaglia. Oggi, troppo esausti, disertate spesso le riunioni in cui si discutono i vostri interessi e vi si apre lo spirito al concetto della vostra missione storica. Colle otto ore sarà tutta un’umanità nuova che aggiungesi all’umanità. Che importa, di fronte a così grande risultato, se anche qualche tisica industria, tenuta su dall’olio di merluzzo delle concessioni governative e delle dogane, dovesse soccombere? Questo, dunque, il significato socialista delle otto ore”.
2. “Der wahre Jacob”, n. 18, 1° settembre 1928, riproduzione
Approfondimento
Sorveglianza \ Il capitalismo della sorveglianza
Cinquant’anni di Statuto dei Lavoratori
19 novembre 1969. La battaglia contro lo sfruttamento oltre la fabbrica
Che fine ha fatto il conflitto sociale?
Sorveglianza \ Il capitalismo della sorveglianza

Il termine capitalismo della sorveglianza non si riferisce, necessariamente, alle tecnologie digitali per il monitoraggio dei cittadini, quanto piuttosto ad una nuova forma di organizzazione economica e sociale governata dalle piattaforme digitali (es. Google, Facebook, Apple, ecc.) e fondata sull’estrazione e lo sfruttamento dei big data generati dai cittadini.
Ad oggi, il 59% della popolazione mondiale è connessa ad Internet ed il 45% possiede uno smartphone, attraverso cui, principalmente, naviga sui social media ed accede a specifiche App. Aldilà di PC e smartphone, le persone sono costantemente connesse ad Internet tramite una moltitudine di device digitali (es. navigatori gps, wearable, dispositivi di domotica, ecc.), e pertanto attraverso le loro attività online generano enormi quantità di dati pressoché su tutto: comportamenti di acquisito, interessi culturali, relazioni sociali, preferenze sessuali, orientamenti politici, stato di salute. In aggiunta a ciò, bisogna anche considerare che i dati digitali non sono solamente generati dalle persone, ma vengono anche automaticamente estratti da esse; si pensi, ad esempio, ai cosiddetti dati residuali, ossia alla velocità con cui una persona batte sui tasti della tastiera o al tempo che ci mette a coprire una distanza da un punto A ad un punto B. Questi dati derivano dalle tracce digitali che le persone lasciano dietro di sé per il semplice fatto di aver usato un device digitale connesso ad Internet.
Ora, questa enorme quantità di dati è il vero e proprio carburante della economia digitale contemporanea. I protagonisti dell’economia digitale sono un ristretto gruppo di digital company globali, come Google, Facebook o Amazon, le quali, oltre ad essere tra le più ricche al mondo, sono riuscite ad imporre i loro business model e le loro strategie di gestione dei dati ad una moltitudine di altri player pubblici e privati. Tecnicamente queste aziende si configurano come piattaforme che, da un lato, si pongono come (semplici) intermediari tra diversi attori (consumatori, pubblicitari, sviluppatori, ecc.), dall’altro, sfruttano la loro posizione di intermediari per estrarre sistematicamente dati dai suddetti attori e dalle loro interazioni. Si consideri inoltre che il controllo delle piattaforme sui dati si estende ben al di là dei confini digitali delle piattaforme stesse, raggiungendo l’open Web (es. bottoni di sharing), gli smartphone (es. App Store), le case private (es. Alexa) e le istituzioni pubbliche (si veda ad esempio la partnership tra Google e il servizio sanitario nazionale inglese).
Shoshana Zuboff sintetizza tali processi di estrazione e controllo dei dati con il termine capitalismo della sorveglianza. Nello specifico Zuboff concepisce il capitalismo della sorveglianza come una nuova logica economica basata sull’estrazione unilaterale e l’accumulazione sistematica dei dati digitali generati dai cittadini, i quali vengono usati per perfezionare gli algoritmi delle piattaforme, investire nel nuovo (redditizio) mercato dell’Intelligenza Artificiale e vendere modelli previsionali a tutte quelle aziende che hanno bisogno di prevedere i comportamenti dei loro consumatori o clienti (come le agenzie di assicurazione o le grandi catene di distribuzione).
Sebbene molti analisti concordino sul fatto che il capitalismo della sorveglianza sia già ben radicato nei paesi ad economia avanzata, è ragionevole pensare che l’emergenza Covid-19 – così come le possibili future pandemie previste da alcuni epidemiologi – possa fungere da acceleratore delle logiche e delle infrastrutture del capitalismo della sorveglianza, che potrebbe estendersi ben al di là del dominio della produzione economica. Nel prossimo futuro, infatti, potremmo assistere ad una progressiva diffusione dei meccanismi di sorveglianza digitale nelle forme, ad esempio, dello smart-working, della platformizzazione dell’istruzione universitaria o dello sviluppo di App governative per il monitoraggio della salute pubblica. In particolare, l’espansione delle logiche del capitalismo della sorveglianza all’interno delle istituzioni pubbliche ha sollevato molte preoccupazioni circa il futuro delle democrazie nei paesi occidentali. La preoccupazione, infatti, è quella che si vada verso un modello cinese, il cui sistema di Social Credit già determina (algoritmicamente) l’accesso dei cittadini ad alcuni servizi essenziali – come il micro-credito o l’uso di treni ad alta velocità – in base al tracciamento dei loro pattern di consumo e navigazione online.
Nonostante l’attualità e la pervasività del fenomeno, il capitalismo della sorveglianza è ancora poco studiato (a livello empirico) dalla ricerca accademica e praticamente assente nel dibattito pubblico. In particolare, sappiamo ancora molto poco circa il livello di consapevolezza e le percezioni dei cittadini riguardo ai processi di estrazione e sfruttamento dei dati e del valore economico da essi generato. Tra l’altro, questa mancanza di attenzione verso la consapevolezza dell’opinione pubblica sembra riflettere le asimmetrie di conoscenza e potere su cui si fonda il capitalismo della sorveglianza.
Infatti, se da un lato le piattaforme dispongono di informazioni granulari circa i comportamenti dei loro utenti, dall’altro queste sono esplicitamente progettate per essere opache, ad esempio riguardo alle terze parti a cui i dati vengono venduti e agli scopi di queste ultime – come il recente scandalo di Cambridge Analytica ha messo in evidenza. Inoltre, le percezioni e preferenze degli utenti sono raramente prese in considerazione dalle piattaforme nella stesura dei contratti di servizio che questi sono spinti a sottoscrivere per accedere alle piattaforme stesse. Ad oggi, il dibattito scientifico e pubblico sul capitalismo della sorveglianza sembra concentrarsi esclusivamente sul tema della privacy. Certamente le questioni relative alla protezione dei dati personali sono (e devono rimanere) centrali, dato che la privacy è rubricabile come diritto fondamentale dell’essere umano, strettamente connesso alla dignità e all’autodeterminazione individuale. Tuttavia, le problematiche di appropriazione del valore sono egualmente importanti, in quanto i dati digitali prodotti dai cittadini tramite le loro attività online generano un cospicuo valore economico che viene estratto dalla società ma non redistribuito all’interno di essa – a tal proposito si considerino anche le sistematiche pratiche di evasione fiscale perpetrate da colossi multinazionali come Apple o Airbnb.
Pertanto, se come alcuni analisti sostengono il capitalismo della sorveglianza sarà inevitabile, quanto meno diviene fondamentale aprire una discussione sui possibili modi attraverso cui governarlo, perché si basi su relazioni più eque e trasparenti tra cittadini e piattaforme. Relazioni che possono essere costruite a partire innanzitutto da una maggiore comprensione dei livelli di consapevolezza dei cittadini rispetto alle logiche che guidano i processi di estrazione e sfruttamento dei loro dati digitali, nonché di ascolto dell’opinione pubblica. In secondo luogo, diviene fondamentale una riflessione sul sistema di relazioni che lega aziende, istituzioni pubbliche, policy maker e cittadini e sugli equilibri di potere sottostanti. Infatti, è intorno a questo sistema di relazioni che è possibile negoziare i confini del capitalismo della sorveglianza. Se dunque, come già menzionato, il capitalismo della sorveglianza sarà (forse) inevitabile, queste piste di ricerca e dibattito potranno guidare una critica positiva, volta a riequilibrarne gli impatti sulle nostre società.
Cinquant’anni di Statuto dei Lavoratori

#Forzalavoro
Il percorso di Fondazione Feltrinelli nel palinsesto di #Fuorileidee dedicato ai cambiamenti strutturali che attraversano il mondo del lavoro
Leggi l’editoriale di Luca Cigna| Scarica l’ebook di Richard Sennet
Il 20 maggio 1970, al termine di una stagione di mobilitazioni sindacali e riforme politiche, viene approvata la legge n. 300 dal titolo “Norme sulla tutela e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.
Lo Statuto dei Lavoratori porta “la Costituzione nelle fabbriche” in un momento storico in cui il testo costituzionale da solo non riusciva a proteggere efficacemente i diritti e le libertà fondamentali dei lavoratori, come illustrato dallo stesso Ministro del Lavoro Giacomo Brodolini nella relazione di accompagnamento alla legge. Lo Statuto approvato in Senato il 20 maggio di cinquant’anni fa, d’avanguardia assoluta tra i paesi sviluppati, rappresenta il risultato di un doppio avanzamento: l’iter parlamentare promosso dal Ministro socialista fa da scenario alla serrata negoziazione sul tavolo dei rinnovi contrattuali da parte dei sindacati e alle lotte sociali promosse dal movimento dei lavoratori, come quella degli elettromeccanici a Milano il giorno di Natale del 1960 in piazza Duomo e i fatti di Piazza Statuto del 1962.
Lo Statuto viene introdotto in un momento di grande difficoltà per quel che riguarda i diritti economici e sociali. Con una media di 7-8 infortuni mortali al giorno, nel 1970 lavorare costituisce ancora un rischio per molte persone. Alla fine degli anni ’80 il numero di invalidi per incidenti sul posto di lavoro si terrà su livelli maggiori di quelli determinati dalla seconda guerra mondiale. La violazione di diritti e tutele è la normalità, anche per via di una dura politica antisindacale. Soprattutto negli stabilimenti di maggiori dimensioni, i lavoratori attivi vengono schedati e licenziati senza indennizzi economici né alcuna possibilità di reintegro. Come una pentola a pressione, l’autunno caldo del 1969 vede l’esplosione delle tensioni accumulate in una poderosa ondata di scioperi: nel 1969 le ore perdute nell’industria manifatturiera superano i 200 milioni, contro i 113 milioni del 1962.
A livello istituzionale, lo Statuto approvato il 20 maggio 1970 è il culmine di un importante processo di riforme, che include provvedimenti come l’abolizione delle zone salariali, l’eliminazione del sistema del caporalato e l’approvazione della prima riforma organica in materia previdenziale. In netta discontinuità rispetto ai predecessori, il ministro Brodolini decide di schierarsi dalla parte dei lavoratori, superando l’idea di un esercizio del potere come neutrale e di mediazione tra le parti. A dimostrarlo è il contenuto progressista dello Statuto, che sancisce la libertà di opinione e di associazione (artt. 1, 8 e 14), il divieto di ricorrere a guardie giurate e impianti audiovisivi (artt. 2 e 4), nonché forti limitazioni sulle sanzioni disciplinari (art. 7). Gli artt. 9, 13, 15 e 16 normano poi la tutela della salute e dell’integrità fisica, la limitazione del potere di variare le mansioni, e il divieto di atti discriminatori. All’art. 18 si stabilisce invece la reintegrazione nel posto di lavoro per chi viene illegittimamente licenziato, un principio che verrà modificato solo quarantadue anni più tardi.
Rileggere lo Statuto ai nostri giorni e alla luce della crisi in corso serve a interrogarsi sui cambiamenti strutturali che attraversano il mondo del lavoro. La progressiva trasformazione dei tessuti produttivi, con lo spostamento del centro di gravità dalla fabbrica all’economia dei servizi e della conoscenza, ha prodotto un graduale scollamento tra le possibilità dello Statuto di difendere chi lavora e le realtà emergenti con cui questo si confronta nella società odierna. Allo stesso modo, il lavoratore di fabbrica si è trovato progressivamente più isolato e meno capace di riconoscersi come attore politico. Quello statuto che era una “carta dei diritti fondamentali” per un’epoca il cui punto di riferimento era l’operaio-massa deve fare oggi i conti con una classe lavoratrice atomizzata, fluida, frammentata dal punto di vista contrattuale, politico e produttivo, le cui modalità organizzative spesso escono fuori dai recinti tradizionali dell’orario e del posto di lavoro. L’allargamento degli orizzonti produttivi, con la globalizzazione dei mercati e la competizione dai paesi emergenti, hanno diminuito ulteriormente la spinta propulsiva della legge n. 300/1970, pensata per un’economia nazionale e in forte crescita.
Negli ultimi decenni, i processi di flessibilizzazione e deregolamentazione del mercato di lavoro hanno posto nuove sfide a chi organizza il movimento dei lavoratori. A fronte della stagnazione dei redditi da salario e delle crescenti disuguaglianze nella maggior parte dei paesi avanzati, la classe lavoratrice “in sé” è stata sempre più raramente in grado di riconoscersi in classe “per sé”, mancando l’obbiettivo di fare fronte comune nel promuovere i salari, diritti e tutele di chi lavora. Le difficoltà nel trovare un minimo comune denominatore tra i segmenti più deboli del mercato del lavoro, in primis la galassia dei lavori considerati “atipici” – contratti a termine, a chiamata, di agenzia, autonomi e di piattaforma – chiama in causa i sindacati, che si interrogano oggi sulle strategie per riconfigurare e dare vitalità ai processi di rappresentanza. Allo stesso modo, urge interrogarsi sui percorsi di partecipazione dei lavoratori alla governance delle imprese di tutte le dimensioni, in un momento storico che registra la (ri)scoperta di modelli virtuosi di coordinazione delle economie tra parti sociali e governi.
L’emergenza sanitaria ha riportato in superficie molte delle contraddizioni che caratterizzano la nostra struttura occupazionale. I lavoratori di settori essenziali come la logistica e la distribuzione, i servizi socio-assistenziali, la filiera agricola e alimentare sono esposti sia a una maggiore precarietà lavorativa, che si manifesta con l’insufficienza di redditi e protezioni sociali, sia a un maggiore rischio di contagio da Covid-19. Secondo l’evidenza empirica disponibile, i lavoratori dei servizi fondamentali risultano svantaggiati in termini di salari e di protezione dell’impiego rispetto a chi può lavorare da casa. Alcune categorie sono particolarmente vulnerabili: è il caso dei rider, che in molti casi non possono rispettare le precauzioni di distanziamento sociale e non ricevono protezioni sanitarie adeguate da parte delle piattaforme. Nelle scorse settimane i ciclo-fattorini di diverse città d’Italia hanno protestato per rivendicare migliori tutele sul lavoro e salari dignitosi.
Reinterpretare lo Statuto assume grande rilevanza in un contesto in cui i confini tra lavoro retribuito e non retribuito si fanno sempre più sfumati, e il contratto di lavoro cessa di essere sinonimo di benessere e partecipazione alla cittadinanza. Da un lato, in molti contesti il lavoro non è di per sé sufficiente per garantire un reddito adeguato: il lavoro povero (in-work poverty) ha raggiunto livelli allarmanti nel nostro paese, con più di un lavoratore su dieci a rischio povertà. Dall’altro lato, il lavoro informale e non retribuito continua ad assorbire una fetta consistente della popolazione. Tra i quattro milioni di lavoratori che operano nell’economia sommersa rientrano le centinaia di migliaia di persone, prevalentemente donne, concentrate nei settori “riproduttivi”, ovvero le attività che fanno sì che l’economia formale continui a funzionare: dalla pulizia alla cura di bambini e anziani, dal lavoro domestico all’alimentazione, dall’educazione alla formazione.
Partendo da queste riflessioni, il percorso promosso da Fondazione Feltrinelli, nei giorni che intercorrono tra l’1 e il 20 maggio, intende interrogarsi sul significato storico della legge n.300 del 1970 e sulla sua importanza per sondare i nuovi movimenti del mercato del lavoro e della società. Le tensioni tra diritto al lavoro e alla salute, lavoro retribuito e non retribuito, organizzazione e armonizzazione degli interessi, salari e redditi, vanno rilette alla luce degli obbiettivi dello Statuto, delle questioni strutturali e dei profondi cambiamenti che hanno trasformato, negli ultimi cinquant’anni, il mondo del lavoro.
Con questo spirito è interessante prendere in esame non solo gli aspetti produttivi, salariali e di tutela della salute intesa in senso strettamente fisico, ma anche l’attenzione che cinquanta anni fa era stata data all’istruzione, alla formazione, alla libera espressione – nelle diverse accezioni – dei lavoratori. Da un lato l’articolo 10, per esempio, riconosceva particolari diritti ai “lavoratori studenti” per i quali si segnalava l’esigenza di agevolare i percorsi di studio in rapporto alla frequenza e ai turni di lavoro. Dall’altro, l’articolo 11 menzionava le attività culturali, ricreative e assistenziali. Certo oggi viviamo un’epoca in cui sfumano i confini tra tempo ricreativo e tempo di lavoro, tra reti sociali e relazioni professionali, tra passioni individuali e produzione di valore, quegli articoli tuttavia ci aiutano a ricordare che la dignità del lavoratore non è confinata alla mera regolazione giuslavoristica e alla tutela della sua capacità prestazionale, ma che la “comunità” dei lavoratori e i luoghi di lavoro – anche quelli virtuali di oggi – sono parte di uno spazio sociale, culturale, ambientale più ampio. In quello spazio-tempo sempre meno nitidamente definito che è oggi il lavoro si gioca anche la possibilità della crescita personale e collettiva, della cura di sé e degli altri, di un’arte di governarsi da sé che è un tentativo di sottrarsi alla coercizione e allo sfruttamento.
A cinquant’anni dallo Statuto, nel bel mezzo di un capitalismo flessibile fatto di impieghi temporanei e traiettorie frammentate, la condivisione di storie, vissuti, insoddisfazioni e aspirazioni – anche nel quadro di dispositivi culturali, ricreativi, di scambio e dibattito che le rappresentanze sindacali e i movimenti dei lavoratori possono abilitare e rinnovare – può essere l’elemento generativo di senso di co-appartenenza e di pratiche di solidarietà volte alla ricerca di risposte comuni.
Il percorso che inauguriamo oggi si avvarrà di fonti storiche tratte dal patrimonio di Fondazione, di voci della comunità scientifica e della nuova rappresentanza, ma anche di testimonianze di lavoratori e lavoratrici che, tra pur tra difficoltà e un senso crescente di vulnerabilità, si fanno portatori di una tensione trasformativa, per un dialogo tra le parti che torni a fare del lavoro – in tutte le sue forme – uno strumento di emancipazione e di eguaglianza sociale.
Avviamo oggi questo tragitto con un testo di Richard Sennett, una riflessione sul valore politico delle storie e della capacità di narrarsi.
19 novembre 1969. La battaglia contro lo sfruttamento oltre la fabbrica

L’articolo fa parte della Rassegna A cinquant’anni dallo sciopero nazionale per il diritto alla casa
CGIL CISL e UIL nel corso dell’autunno già caldo per le vertenze legate ai rinnovi contrattuali promuovono una serie di scioperi articolati ‘per le riforme’ e in particolare per una modifica radicale delle politiche abitative. L’obiettivo è quello di trasformare la casa in un servizio sociale sottraendola alle logiche di puro profitto per assicurare a tutti i cittadini condizioni abitative adeguate ad un livello civile di vita collettiva.[1]
La spinta alla mobilitazione arrivava certamente dalle fabbriche ma anche dai territori dove si erano sviluppate forti lotte spontanee che spesso né le strutture sindacali né i partiti della sinistra tradizionale erano state in grado di organizzare e dirigere.
A Milano il problema della casa era drammatico. Migliaia di lavoratori giunti dalle campagne e dal sud attratti dalle grandi fabbriche trovavano affitti inaccessibili o sistemazioni precarie in condizioni di degrado; i ceti popolari erano espulsi dal centro storico in seguito alla prima grande ‘rigenerazione urbana’ fatta di demolizioni e sfratti; migliaia di proletari vivevano ammassati in quartieri dormitorio, costruiti frettolosamente e senza i minimi servizi. I bisogni immediati di queste famiglie si stavano saldando con la nuova consapevolezza politica espressa dai movimenti giovanili e con il rinato protagonismo operaio.
Il 19 novembre l’Italia si ferma. Milioni di lavoratori in sciopero vogliono modificare i rapporti di potere anche fuori dalla fabbrica consapevoli che se questi non si modificano le stesse conquiste contrattuali e aziendali rischiano di essere riassorbite.[2]
Anche a Milano la mobilitazione ha un indubbio successo. Ma ha un epilogo tragico. Al termine del comizio tenuto all’interno del Teatro Lirico la polizia interviene in modo violento per disperdere un corteo, in quel momento pacifico, di dimostranti della sinistra extraparlamentare che si stava unendo ai lavoratori in uscita dal teatro[3]. Nel buio generato dai gas lacrimogeni resterà ucciso l’agente di polizia Antonio Annarumma. Le circostanze della morte non furono mai chiarite ma questo episodio diede l’occasione alle destre per attaccare in modo violento il movimento sindacale. Attacchi verbali nelle dichiarazioni di alcuni esponenti del governo e nei titoli di giornale ma anche vere e proprie azioni squadriste effettuate dai fascisti nel giorno del funerale dell’agente. Solo ventitré giorni dopo, il 12 dicembre, parole e azioni simili saranno portate alla massima potenza.
Facciamo però un passo indietro: per provare ad analizzare le lotte che diedero la spinta alla mobilitazione generale del 19 novembre proviamo a concentrarci su un caso specifico.
Gennaio 1968, Quarto Oggiaro. Il quartiere, composto in gran parte da edilizia pubblica, negli anni 60 aveva vissuto uno sviluppo demografico impressionante: dai 7.232 abitanti censiti nel 1959 ai 60.000 del 1969. La composizione della popolazione era il frutto della logica di segregazione sociale attuata dallo IACP con l’offerta differenziata di alloggi (tramite il valore dei canoni e i criteri di selezione) nei diversi quartieri periferici[4]: operai non specializzati, pensionati a basso reddito, piccoli esercenti, precari. Gli abitanti provenivano prevalentemente da altre regioni italiane, in modo particolare dal Meridione, e in misura minore da altre quartieri più centrali di Milano, come conseguenza di sfratti o abbattimenti di stabili.
In seguito all’ aumento dell’affitto e delle spese da parte dello IACP, il 14 gennaio ‘68 l’assemblea degli inquilini, contro le indicazioni delll’APICEP (Associazione Provinciale Inquilini Case di Edilizia Pubblica) dove operano anche i rappresentanti dei partiti di sinistra (PCI e PSIUP), avvia uno sciopero dell’affitto ad oltranza con la richiesta di mantenere il valore dell’affitto al 10% del reddito del capofamiglia[5]. Dal primo Comitato di Agitazione nascerà in breve tempo l’Unione Inquilini che riuscirà a intercettare bisogni e pratiche già maturi “dando pubblicità ad un comportamento sino ad allora “clandestino” e trasformandolo in una parola d’ordine semplice e chiara”[6].
La lotta proseguirà estendendo le proprie rivendicazioni alle necessità degli abitanti di servizi e spazi sociali e alla democratizzazione dell’IACP. Il movimento dovrà presto affrontare la repressione, organizzerà l’opposizione di massa agli sfratti e il sostegno alle occupazioni di alloggi sfitti, e a volte di interi stabili, da parte di sfrattati e famiglie senza casa. Pur senza riconoscimenti ufficiali da parte delle istituzioni gli inquilini in sciopero otterrà la sospensione degli sfratti e la proposta di alloggi agli occupanti.
Nel frattempo, dopo la fiammata dello sciopero generale, la battaglia per le riforme delle organizzazioni sindacali si era spostata principalmente sul terreno della contrattazione con il governo rinunciando alla mobilitazione generale dei lavoratori.
Certamente i risultati della contrattazione non furono marginali. Il 22 ottobre 1971, dopo due anni di incontri e modifiche che limitarono di molto la portata delle rivendicazioni sindacali, viene votata la legge di Riforma della Casa: viene istituita l’Edilizia Residenziale Pubblica inserendo il comparto nel sistema dello stato sociale e vengono varate le norme sulla espropriazione per pubblica utilità. Pochi anni dopo, nel 1978, sarà approvato l’Equo Canone che, sebbene non fosse quello richiesto dalle mobilitazioni sindacali, sottrae la determinazione dell’affitto alla pura volontà della Proprietà. Dopo l’autunno caldo però l’intervento sindacale non riuscirà più a intercettare nello stesso modo le istanze dei quartieri popolari rinunciando troppo presto a “uscire dalla fabbrica”.
Per rileggere oggi la mobilitazione di 50 anni fa proviamo ora a utilizzare tre immagini.
La prima. BASTA RAZZISMO CASE POPOLARI A PREZZI POPOLARI[7] è scritto sul cartello portato da una giovane lavoratrice: non possiamo non pensare oggi alle leggi discriminatorie che cercano di limitare l’accesso all’edilizia popolare ai cittadini stranieri. In questi giorni si avvia a Milano l’attuazione della nuova legge regionale che premia con punteggi determinanti i cittadini residenti in Regione da più di 15 anni e nel comune da più di 10 limitando nel contempo l’accesso delle famiglie definite “indigenti” ad una quota massima del 20%.[8] Una doppia discriminazione dunque, nei confronti dei cittadini stranieri in particolare e comunque nei confronti di tutti i cittadini poveri.

La seconda. Emerge un cartello scritto a mano tra la folla radunata fuori dal Teatro Lirico: SALARIO 100.000 AFFITTO 40.000. CON COSA MANGIAMO?[9] A Milano oggi gli affitti continuano a aumentare. Si stima che siano saliti del 10% solo nell’ultimo anno. L’incidenza del costo casa rispetto al reddito supera ormai nella maggioranza dei casi il 50%. La domanda posta nel cartello nel 1969 è quindi oggi ancora più attuale. E la risposta sta negli ultimi dati diffusi dal Ministero dell’interno: nel 2018 a Milano sono stati eseguiti 2.845 sfratti, il 90% per morosità.

La terza immagine riprende invece molti operai che portano uno striscione: LA CASA NON È UN LUSSO MA UN BENE INDISPENSABILE [10]. Di fronte alla completa liberalizzazione del mercato degli affitti e ai processi di dismissione del patrimonio di case pubbliche negli ultimi 20 anni il movimento sindacale è stato spesso assente e a volte anche direttamente responsabile. Non vi è stata la capacità di contrastare l’assunto per cui l’alloggio non è altro che un bene da cui il proprietario ha il legittimo diritto di ottenere il massimo profitto possibile e ci si è affidati alle presunte virtù regolatrici del mercato rinunciando nei fatti alla rappresentanza della parte di popolazione esclusa dal diritto alla casa.

Se oggi la fabbrica del 1969 da cui partire per estendere la battaglia non esiste più, continua ad esistere quel fuori richiamato nel manifesto di convocazione dello sciopero generale e continua ad esistere lo sfruttamento. I quartieri sono ancora popolati da migliaia di persone e famiglie cui è negato il diritto ad una casa e ad un abitare dignitoso, anche se spesso sono “invisibili” ai media ed alle istituzioni. La città è attraversata, anche se in modo discontinuo e disorganico, da varie forme di resistenza: mobilitazioni per chiedere al Comune risposte concrete per le famiglie sfrattate, iniziative di quartiere per ottenere la riduzione degli affitti, opposizioni agli sfratti e agli sgomberi, momenti di denuncia contro le politiche discriminatorie, richieste di intervento perché siano garantite condizioni di vita dignitose nei quartieri popolari. Da fuori la battaglia può ancora ripartire.
[1] Le indicazioni della CGIL, della CISL e della UIL per una politica organica della casa, 24 settembre 1969. Il Testo integrale del documento in Lo spreco edilizio, a cura di Francesco Indovina, Marsilio Editori, 1972.
[2]Dal Testo del manifesto dello sciopero generale unitario del 19 novembre 1969 in Achilli, Casa Vertenza di massa, Marsilio Editori, 1972
[3] Vedi Sergio Turone, Storia del Sindacato Italiano, Editori Laterza, 1998.
[4] Mario Boffi, Stefano Cofini, Alberto Giasanti, Enzo Mingione, Città e conflitto sociale, Feltrinelli, 1972.
[5] Vedi Francesco Di Caccia, La questione urbana. Storia dell’Unione Inquilini, Feltrinelli,1974
[6] Testimonianza di Giuseppe Zambon, primo dirigente dell’Unione Inquilini
[7] http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-2w020-0002444/
[8] Per un approfondimento della norma: http://sbilanciamoci.info/modello-welfare-abitativo-lombardo-opportunita/
[9] http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-2w020-0004681/
[10] http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-2w020-0002443/
Che fine ha fatto il conflitto sociale?

L’immagine è tratta dal patrimonio di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. L’istantanea raffigura un’assemblea dell’Alfa Romeo di fine anni settanta.
Nel tempo della disintegrazione del lavoro salariato, della progressiva erosione dei diritti, dell’aumento crescente di disuguaglianze, disoccupazione, vulnerabilità, instabilità economica e sociale, vale la pena interrogarsi sul ruolo del conflitto. Nei nuovi, per certi versi inediti rapporti di lavoro emersi nell’era digitale, dov’è il conflitto? Si può parlare di aumento, diminuzione, moltiplicazione dei conflitti nei rapporti di lavoro in questo momento storico? Quali sarebbero i regimi di lavoro dell’economia capitalistica contemporanea in cui emergono maggiori mobilitazioni, e quali le dimensioni in cui si registra la totale assenza di tensioni?
Rispondere a questa serie di domande senza dare nulla per scontato è un’operazione semplice solo in apparenza, e sebbene possa sembrare banale, si tratta di una riflessione necessaria a osservare ciò che è ovvio nel tentativo di decostruirlo. La ricerca di una risposta generale rischia di ridurre la complessità delle reali, molteplici forme di mobilitazione sociale nei rapporti di lavoro oggi, in Italia e non solo, ma anche di sminuire le contraddizioni che emergono nei processi di lotta, che andrebbero analizzate di pari passo per non cadere in analisi strumentali. Interrogarsi su che fine abbia fatto il conflitto sociale nel mondo del lavoro in costante decomposizione può indurre in altre parole ad assecondare un dibattito sterile che cerca di prendere posizione all’interno di una visione dicotomica, superficiale, tra chi in sostanza vede con inguaribile ottimismo aumentare sempre più i conflitti e chi al contrario sostiene che il conflitto non esiste più, che le piazze sono deserte, che i sindacati non servono a nulla se non a gettare acqua sul fuoco, eccetera. Un dibattito privo di sfumature, al di là di ogni “pessimismo dell’intelligenza e ottimismo della volontà”.
Come viene raccontato il conflitto nel mondo del lavoro è invece un’ulteriore questione connessa agli interrogativi precedenti. Nella letteratura accademica proliferano studi e analisi sul rapporto tra forme di lavoro e rivoluzione digitale, sul cosiddetto capitalismo delle piattaforme e sulla crisi del valore del lavoro in queste dinamiche. Numerosi sono gli studi che riflettono sui processi di resistenza e sulla varietà delle forme di sindacalizzazione nell’economia delle piattaforme e nel mondo del lavoro condizionato dalle tecniche digitali. Una letteratura ibrida s’interroga poi sulla genesi del conflitto, sulle condizioni materiali che producono l’emergere di una coscienza a partire da un punto di non ritorno in cui la situazione diventa inaccettabile.
A tal proposito, vale la pena di ricordare brevemente due luoghi in cui la conflittualità sembra esprimersi nella sua forma più viva. Il primo luogo riguarda il microcosmo dei lavoratori di consegne del cibo, senza dubbio tra i fronti più caldi del conflitto in questo momento. Più o meno dalla notizia della sentenza che sanciva l’assenza di un vincolo di eterodirezione e dipendenza, il lavoro dei riders delle piattaforme di food delivery è al centro dell’attenzione politica e mediatica, una centralità che è andata di pari passo con i recenti fatti di cronaca – come l’incidente grave di un lavoratore che consegnava cibo a Milano. La stampa e le istituzioni, oltre al mondo accademico e ai sindacati confederali, hanno iniziato a prendere in considerazione le mobilitazioni di questo segmento di forza lavoro, le cui lotte in verità sono portate avanti da molto prima che si accendessero i riflettori su questo universo lavorativo. Sono infatti da almeno due anni che tra i fattorini c’è chi ha iniziato a protestare contro le multinazionali delle piattaforme digitali. Attraverso assemblee, scioperi, pratiche di mutualismo, vertenze legali, è stato riaffermato il diritto alla lotta sindacale per rivendicare un contratto collettivo decente, delle condizioni di lavoro migliori laddove il dispositivo tecnologico esercita controllo e disciplinamento sulla forza lavoro spacciandolo per autonomia. Un sistema che favorisce l’estrazione di valore dalla prestazione di lavoro basandosi sui princìpi dell’accumulazione flessibile, della massima fungibilità e flessibilità di un lavoro che la controparte si ostina a definire autonomo.

Milano, 1960. Manifestazione degli elettromeccanici
Il secondo terreno di conflitti e tensioni è quello che viene generalmente definito come la catena logistica del trasporto merci. E nonostante le differenze, si tratta di un luogo contiguo al primo per due ragioni principali: l’esercizio di un servizio di manipolazione e trasporto di una merce, sia essa il cibo o un pacco di Amazon, e una polarizzazione estrema che passa dall’ipertecnologizzazione delle attività logistiche-distributive da un lato a una perversa deregolamentazione dei diritti più elementari in tema di lavoro dall’altro (si pensi al “modello Amazon” e al rifiuto di riconoscere qualsiasi forma di negoziazione con i sindacati).
I conflitti in questi ambiti evidenziano una questione centrale più volte ribadita dagli studiosi, vale a dire la posizione strategica occupata nel capitalismo reticolare contemporaneo dai lavoratori della logistica e da quelli che movimentano le merci. Un libro uscito di recente parla non a caso di “choke points”, nodi critici e fragili delle catene di fornitura capitalistica in cui sono posizionati gruppi di lavoratori alle prese con lotte e conflitti che sfidano gli stessi principi di accumulazione del capitalismo globale, basati sulla circolazione di beni senza soluzione di continuità e sui processi di accelerazione dei flussi di merci.
Prima di riflettere sulle mutevoli dinamiche di subordinazione e sfruttamento nel mondo del lavoro in questo o quel settore, e sulle relative istanze portate avanti, occorre tuttavia fare un passo indietro e ribadire un principio di natura concettuale: è necessario introdurre la categoria di “conflitto” quando si parla di lavoro (magari evitando retoriche vittimistiche e narrazioni superficiali che tendono a dipingere gli attori principali di queste lotte come dei subalterni). Non si può prescindere dall’uno senza l’altro. È opportuno mettere questa parola di nuovo al centro delle analisi sui mutamenti dei rapporti di lavoro in relazione ai meccanismi di accumulazione della ricchezza nell’economia contemporanea, e riflettere, da un lato, su come questi meccanismi incidono sulle condizioni di vita delle persone coinvolte direttamente, dall’altro su come, dove, perché e in che misura queste persone esprimono o meno istanze di emancipazione collettiva capaci di restituire dignità al lavoro. Se si vogliono interpretare le trasformazioni del lavoro in un’epoca segnata dalla rivoluzione tecnologica e digitale bisognerebbe partire da questa semplice, duplice constatazione: lavoro e conflitto, lavoro è conflitto. Nel suo studio sulle trasformazioni storiche dei movimenti operai, Beverly Silver ha sottolineato come Marx e Polanyi affermavano entrambi, seppure in modo diverso, questo dato di fatto: il lavoro è una “merce fittizia”. Di conseguenza, qualsiasi tentativo di considerare gli esseri umani come una merce al pari di ogni altra non può che portare a contestazioni profondamente sentite e forme di resistenza dalla natura ciclica, a fasi, o oscillatoria e ricorsiva. I conflitti sono quindi endemici rispetto al rapporto tra capitale e lavoro, anzi definiscono in teoria tale rapporto. Nel tempo in cui la prestazione di lavoro è sempre più una merce fungibile, svalorizzata, vale la pena ribadirlo. Ancor di più se ci si chiede spesso come cambia il lavoro mentre ci s’interroga raramente su come dovrebbe cambiare il modo di studiare il lavoro che cambia.