Società e consumi
Capitolo 7
Ci avete messo in mano uno smartphone a basso costo con l’intento ben riuscito di neutralizzarci. Avete reso vane le nostre fatiche, i nostri progetti, le nostre idee. Avete distrutto i nostri spazi sociali, il nostro tempo libero (che è “libero” solo perché dipende da voi), regalandoci più spazio interconnesso – uno spazio morto e inerme se privo di realtà.
Francesco Paolo Cazzorla
Non è vero che non c’è lavoro è che non ci volete pagare
Il conformista online, 2018
Sono le innovazioni della seconda rivoluzione industriale a modificare radicalmente la vita e i consumi delle persone. Così mentre la “casa elettrica” e gli elettrodomestici rendono meno gravosi i lavori domestici, la motorizzazione di massa consente orizzonti di spostamento impensabili e la trasmissione a distanza di suoni e immagini cambia radicalmente il modo di comunicare.
Progresso tecnologico
Nel secondo dopoguerra lo sviluppo del traffico aereo, la nascita di internet, la crescita del web e la diffusione esponenziale degli smartphones rendono il mondo sempre più “piccolo” e sempre più interconnesso. Se nel “primo mondo” l’avvento della società dei consumi di massa ha certamente migliorato le condizioni di vita delle persone, in quelle medesime porzioni di pianeta, così come nelle altre, si è assistito ad una continua e costante diminuzione delle risorse disponibili.
Trasformazioni
Parallelamente, il cambiamento nelle abitudini e negli stili di vita produce anche una rivoluzione dei costumi: nuovi simboli del benessere diventano la televisione o l’automobile. A lungo andare, queste trasformazioni disarticolano i legami tradizionali delle società, amplificando da un lato le possibilità di emancipazione e auto-affermazione dell’individuo sulla base dei suoi orientamenti ma provocando dall’altro lato tendenze alla frammentazione e all’individualizzazione che rendono più difficili processi di emancipazione sulla base di mobilitazioni collettive.
Guarda la photogallery
1. William Thompson, An inquiry into the principles of the distribution of wealth most conducive to human happiness, London, 1824, p. 19.
“The only reason that can be given for the production of wealth at all, is, that it adds to the means of happiness; the only reason that it should be distributed in one way more than another, is, that it tends more to produce , to add the stock of happiness, the object of its production, by one mode of distribution than by another”. [L’unica ragione che può essere data per la produzione di ricchezza a tutti, è, che si aggiunge agli strumenti deputati a raggiungere la felicità; l’unica ragione per cui dovrebbe essere distribuita in un modo piuttosto che in un altro, è che tende a produrre, per aggiungere lo “stock” di felicità, l’oggetto della sua produzione, da un modo di distribuzione rispetto ad un altro].
2. John Kenneth Galbraith, The Affluent Society, New York, Hamish & Hamilton, 1955, p. 272. “In our society the increased production of goods – privately produced goods – is, as we have seen, a basic measures of social achievement. This is partly the result of the great continuity of ideas which links the present with a world in which production indeed meant life. Partly it is a matter of vested interest. Partly it is a product of the elaborate obscurantism of the modern theory of consumer need. Partly it reflects an erroneous view of the problem of national security. And partly, we have seen, the preoccupation with production is forced quite genuinely upon us by tight nexus between production and economic security. However, it is a reasonable assumption that most people pressed to explain our concern for production – a pressure that is not often
exerted – would be content to suggest that it serves the happiness of most men and women. That is sufficient”. [Nella nostra società l’aumento della produzione di beni – beni prodotti privatamente – è, come abbiamo visto, una misura di base della realizzazione sociale. Questo è in parte il risultato della grande continuità di idee che collega il presente con un mondo in cui la produzione ha significato vita. In parte è una questione di interesse personale. In parte è un prodotto dell’oscurantismo elaborato della moderna teoria del bisogno dei consumatori. In parte riflette una visione errata del problema della sicurezza nazionale. E in parte, abbiamo visto, la preoccupazione per la produzione ci viene imposta in modo abbastanza reale da uno stretto nesso tra produzione e sicurezza economica. Tuttavia, è ragionevole supporre che la maggior parte delle persone che hanno insistito per spiegare la nostra preoccupazione per la produzione – una pressione che non viene spesso esercitata – sarebbe soddisfatta di suggerire che essa serve la felicità della maggior parte degli uomini e delle donne. Questo è sufficiente].
3. Annuncio pubblicitario, in “L’Espresso”, n. 15, 18 aprile 1982.
Approfondimento
Deindustrializzazione: nostalgia di un futuro perduto
I consumi dei lavoratori nell’era Thatcher
Come la diseguaglianza logora la nostra salute mentale
Come sta cambiando il capitalismo occidentale?
Deindustrializzazione: nostalgia di un futuro perduto

Pubblichiamo qui un estratto del saggio di Roberta Garruccio pubblicato nel volume Le eredità delle crisi a cura di Paolo Frascani ed edito da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli), disponibile su tutti gli store online 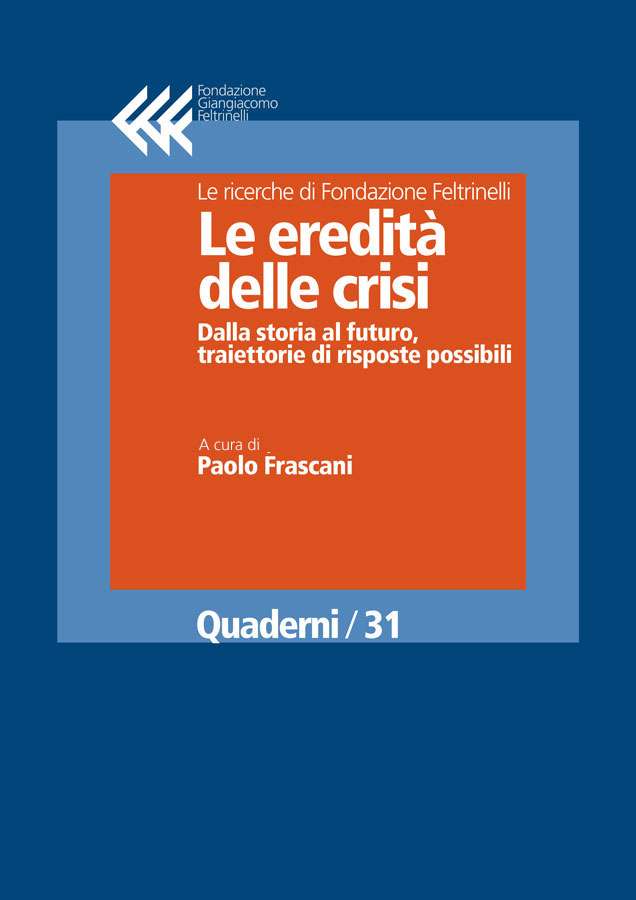
La deindustrializzazione ci interessa perché si presenta non come una fluttuazione ciclica, ma come una discontinuità strutturale che sta seduta su una intera cascata di processi e transizioni economici, tecnologici, geostrategici, politici e culturali rispetto ai quali le società dei paesi sviluppati non hanno ancora trovato un punto di appiglio e di equilibrio.
La deindustrializzazione ci interessa perché i rischi distributivi e di dumping sociale (ossia l’impatto pesantissimo in termini di distribuzione del reddito tra paesi e dentro i paesi) generati congiuntamente dalle tecnologie itc, dai grandi accordi multilaterali e dalle unioni monetarie a partire dagli anni ’90 sono stati sottovalutati a lungo, eppure è da subito che hanno iniziato a presentare il conto. La deindustrializzazione implica infatti meccanismi di generazione e distribuzione del reddito che sono nuovi e quindi forme di disuguaglianza inedite: nell’Unione Europea, la componente intra-nazionale della disuguaglianza misurata in termini reali è in aumento sin dal 2003, e nel 2015 è arrivata a pesare il doppio di quella internazionale.[1] Questa “divergenza locale” è insomma la tendenza macroeconomica speculare alla “convergenza globale”.
La deindustrializzazione ci interessa perché il suo impatto non si limita a presentarsi come de-manufacturing, ma si sostanzia in un nuovo e generalizzato senso di vulnerabilità e incertezza sociale che pesa anche più della disuguaglianza. Essa comporta un mutamento molto ampio nell’ambito delle relazioni di lavoro, con la caduta della partecipazione sindacale e più in generale con difficoltà crescenti di contrattazione sotto la minaccia della delocalizzazione, e con una polarizzazione della qualità del lavoro e dei redditi da lavoro: «una voragine nuova tra […] impieghi stabili, ben remunerati e gratificanti e […] lavori non qualificati, incerti, malpagati e frustranti»,[2] in cui sono due i fattori che giocano: il livello di istruzione e le competenze effettive della forza lavoro (poiché richiedono livelli di istruzione alti, le nuove tecnologie sono particolarmente divisive dentro il tessuto sociale) e il grado di istituzionalizzazione del nuovo mercato dei servizi.
Proprio in contrasto con il fatto che per tutto il ‘900 è stato il settore industriale a rappresentare l’epicentro della legislazione protettiva del lavoro, ciò che si osserva in molti paesi europei è la sua profonda ridefinizione giuridica e di nozione condivisa. Tanto il sistema della protezione sociale quanto la regolazione del mercato del lavoro affondano le loro origini in quel ciclo del capitalismo che sui due lati dell’Atlantico ha concorso allo sviluppo dell’industria, all’emergere della questione operaia, alle conquiste delle classi lavoratrici in termini di diritti. Dopo gli anni ’90, quei sistemi regolativi sono stati oggetto di una decisa torsione, con riforme che il mondo dell’impresa interpretava come chiave della competitività e il sindacato subiva come definitiva rottura del compromesso sociale di epoca fordista e senza esser più in grado di contrastarne la dinamica globale.
Nei paesi più ricchi, la deindustrializzazione si è associata più in generale all’aumento dello spettro di fattori di vulnerabilità sociale, spettro nel quale rientrano anche le toxic legacies di molti luoghi ex-industriali e in cui confluiscono standard di vita declinanti per le classi medie, una quota rilevante della disoccupazione operaia, della nuova occupazione discontinua e precaria nei servizi, lo stesso fenomeno dei “poveri che lavorano”, stili di vita autodistruttivi.
Negli Stati Uniti in particolare, questa vulnerabilità sociale ha fatto registrare un aumento significativo della mortalità e della morbilità dei maschi bianchi con basso titolo di studio: si tratta di un fenomeno che viene ora studiato a fondo perché è la prima volta da un secolo che la mortalità nella fascia di età 25-65 anni ha ripreso a crescere.[3] Al centro dell’attenzione sono le cosiddette deaths of despair: l’impennata dei tassi di suicidio e dei decessi legati all’abuso di alcol e droghe (legati a stati mentali che spingono a comportamenti autodistruttivi) è diventato drammaticamente vistosa proprio dove l’economic distress legato alle trasformazioni strutturali si è più manifestato: i grandi centri urbani più colpiti dal ritiro dell’industria, come Chicago, Baltimora, Detroit, con una sovra-rappresentazione nei middle class suburbs, o regioni come il Midwest, il New England, la regione degli Appalachi. Niente di nuovo nella diffusione di eroina e cocaina e in generale delle sostanze illegali derivate dall’oppio, ma a partire dagli anni ’90 la novità è invece rappresentata dalla crescita nei consumi degli oppioidi sintetici sotto forma di farmaci da prescrizione.[4] Si tratta di analgesici, sedativi, antidepressivi che hanno generato dipendenze, misuso prolungato fuori da ogni indicazione medica, che in vent’anni hanno lasciato una scia di morti per overdose maggiore per numero delle morti registrate tra i soldati americani nella seconda guerra mondiale, in quella di Corea e in quella del Vietnam sommate insieme. È una connessione lassa quella individuata tra l’impatto della deindustrializzazione su alcune specifiche aree degli Usa, le death of despair, la crisi degli oppioidi, ma è una connessione che sta calamitando crescente attenzione: molti progressisti la leggono come causalmente legata al crescere della disuguaglianza;[5] altri più cautamente vi vedono giocare tendenze sociali più complesse (e tra queste il collasso della classe operaia bianca americana, il declino del tasso di occupazione e quindi le patologie che accompagnano questo declino); altri ancora si sono applicati a cercare correlazioni tra le mappe delle death of despair contea per contea e i pattern di voto per Donald Trump durante la campagna per le presidenziali 2016. [6]
Lo slittamento tettonico delle trasformazioni economiche che la rivoluzione digitale e la svolta liberista ha trascinato con sé non ha avuto impatto solo sulla sicurezza del posto di lavoro, ma ha prodotto nel tempo una stagnazione salariale che perdura da almeno due decenni, una netta contrazione della partecipazione maschile al mercato del lavoro (il che a sua volta impatta sulle relazioni tra i generi, sul tasso dei divorzi, su quello della violenza domestica), un generale processo di disembeddedness – vecchia categoria polanyana – che ha aumentato l’isolamento sociale, liquefatto molte comunità locali e ha ridotto il loro controllo sulle policy che le riguardano.
La deindustrializzazione ci interessa perché siamo nel lungo domani della crisi finanziaria del 2007-2008. La cosiddetta Grande Recessione ha esacerbato le tensioni che la globalizzazione andava scaricando sui principi di sovranità nazionale e di democrazia rappresentativa già dal decennio precedente. E in quello successivo ha intensificato la scossa sui processi di “recessione democratica” o di “deconsolidamento della democrazia rappresentativa”.[7] Questi si sono manifestati più vistosamente quando, nel nostro continente, agli effetti della crisi che ha lasciato un tasso mediano di disoccupazione tra le regioni europee di almeno due punti percentuali più alto rispetto a prima del 2007 (e con ampia varianza tra paesi), si sono aggiunti quelli della crisi dei debiti sovrani (2011-2012) con le tensioni che questa accollava ai sistemi di welfare europei e proprio nel momento in cui scoppiava anche la crisi dei migranti (2015). Deflazione, disoccupazione o precarizzazione del lavoro, rallentamento economico, malessere sociale ed economico degli elettori, polarizzazione dello scontro politico, ascesa di movimenti politici estremisti, affermazione delle destre radicali e in generale una perdita di consenso dei partiti tradizionali che sembra correlata più alle variazioni nella disoccupazione che ai suoi livelli assoluti.[8] È questo il contesto largo in cui un’analisi empirica della deindustrializzazione europea va inserita.
[1] G. Ottaviano, Geografia economica dell’Europa sovranista, Laterza, Bari, 2019, pp. 77-85.
[2] D. Rodrick, Dirla tutta sul mercato globale, cit., p. 85.
[3] A. Case, A. Deaton, Mortality and Morbidity in the 21st Century, “Brookings Papers”, March 17, 2017.
[4] Il fenomeno è drammatico negli USA, anche per le peculiarità del suo sistema di assicurazione sanitaria, ma non è limitato agli USA: ricerche recenti documentano il quasi raddoppio nell’uso degli anti-depressivi tra 1990 e 2000 in Europa e una continua tendenza alla crescita in tutti i paesi ocse anche per i due decenni successivi, cfr. D.G. Blanchflower, Not Working, cit., pp. 212 ss.
[5] J. Stieglitz, When Inequality Kills, “Project Syndicate”, December 7, 2015.
[6] S. Monnat, Deaths of Despair and Support for Trump in the 2016 Presidential Election, Pennsylvanya State University, Department of Economics, Sociology and Education, “Research Brief”, April 12, 2016.
[7] M. Giugni, M. Grasso, Citizens and the Crisis: Experiences, Perceptions and Responses to the Great Recession in Europe, Palgrave-McMillan, London, 2017; L. Morlino, F. Raniolo, The Impact of the Economic Crisis on South European Democracies, Palgrave-McMillan, London, 2017.
[8] Y. Algan et al., The European Trust Crisis and the Rise of Populism, “Bookings Papers”, Settembre 2017.
I consumi dei lavoratori nell’era Thatcher

L’articolo è tratto dal percorso editoriale dedicato alla figura e alle eredità di Margaret Thatcher in occasione di quarantanni dalle elezioni del 4 maggio 1979 che avrebbero cambiato per sempre la Gran Bretagna e l’Europa
Molte sono state le polemiche suscitate dalla politica dei governi Thatcher e varie le opinioni sui suoi effetti nel lungo periodo. Ma su alcune cose tutti sono concordi. In primo luogo, sui suoi effetti recessivi nel periodo 1979-1981, che portarono a un arretramento del Pil di alcuni punti, salvo poi una ripresa nella seconda metà degli anni Ottanta. In secondo luogo, sul costo sociale delle nuove politiche liberiste che, sfidando apertamente i sindacati operai, portarono alla chiusura di miniere e fabbriche, e un conseguente picco di disoccupazione che superò i tre milioni di persone nel 1983. Infine, vi è accordo sulla crescente disuguaglianza nei redditi che influì sulle caratteristiche della società britannica anche nei successivi decenni di crescita.
Un punto di vista poco utilizzato per valutare i cambiamenti del periodo sono invece i consumi e le spese familiari, angolazione invece molto utile per comprendere le variazioni di stile di vita e le trasformazioni interne alla società. Usando questa prospettiva, emergono alcune conferme e alcune novità.

Da un punto di vista generale, gli anni Ottanta sono un periodo di notevole crescita dei consumi per tutti in Gran Bretagna. Il classico paniere delle spese obbligate subì una trasformazione, per cui scesero percentualmente le spese per cibo e bevande, ma non quelle per la casa; salirono le spese per servizi e i nuovi consumi legati a mobilità e entertainment. L’elemento più caratterizzante del periodo 1979-1992 è la crescita della disuguaglianza all’interno dei consumi stessi: le fasce più povere, o meglio quelle che consumano meno, risultarono via via composte da un crescente numero di individui e il divario tra i loro consumi e quelli dei ricchi si accentuò. In altre parole, anche nella distribuzione dei consumi si nota una crescente disuguaglianza sociale, come nei redditi. Come suggeriscono studiosi come Alissa Goodman e Steven Webb, il 40 per cento della popolazione più povero vide salire le spese più del reddito, mentre per tutte le fasce più alte avvenne il contrario: gli introiti crebbero più delle spese, permettendo quindi risparmi e investimenti.
In questo quadro è interessante osservare alcuni dati che riguardano la classe operaia. In realtà, in questo periodo sembra di assistere a una profonda trasformazione dell’identità operaia: la “sconfitta” delle lotte nelle miniere e nelle fabbriche, con conseguente perdita di lavoro o diminuzione di salario, sembrò intaccare la tradizionale cultura di classe. Dal punto di vista dei consumi, a fine Ottanta i nuclei operai non si differenziavano più significativamente da altri gruppi di fascia bassa. L’identità basata sulla classe sociale si diluì in uno stile di vita sempre più influenzato dai media e dalla cultura popolare, al punto che molte analisi ritennero che gli elementi più qualificanti per valutare i consumi fossero ormai divenuti aspetti come il genere e l’età. Non solo. Un dato sorprendente segnala come nella fascia più povera della popolazione (primo decile), sempre nel periodo 1979-1992, si sia registrata una forte crescita dei consumi, del tutto indipendente dal reddito. La spiegazione ipotizzata, secondo Goodman e Webb, è che fino al 1979 la grande parte di questi poveri fosse composta da pensionati, con basse pretese in fatto di consumi, mentre nel corso degli anni Ottanta a loro si siano aggiunti i “nuovi poveri”, di età più giovane, e cioè ex operai disoccupati, lavoratori part-time, autonomi precari e simili, con esigenze di consumo più elevate. Pur senza reddito, questi ultimi cercarono di mantenere un discreto livello di consumi attraverso l’indebitamento, poiché lo ritenevano parte irrinunciabile del loro stile di vita.
La decadenza dei tradizionali consumi operai è documentata in molti modi. Prendiamo il consumo simbolo per eccellenza della socialità operaia britannica, la birra. Consumare birra insieme aveva da sempre rappresentato un fattore importante nello stabilire relazioni tra pari, al di fuori della fabbrica. Si tratta infatti di una pratica sociale, specificamente maschile, che connota la classe operaia dal suo insorgere, attingendo a una lunga tradizionale pregressa. John Burnett ha documentato come nel secondo dopoguerra il consumo di birra abbia registrato il suo massimo picco proprio nel 1979, con 27,1 galloni pro capite (124 litri), per declinare subito dopo: 24,3 galloni nel 1990; 22,4 nel 1993. Nello stesso periodo 1979-1990, il consumo di vino ha conosciuto al contrario un’impennata del 58 per cento e quello di bevande analcoliche è cresciuto anche di più. Anche in questo caso, il declino sembra legato all’impoverimento e alla riduzione numerica della classe operaia, e in particolare di minatori e operai delle fabbriche, che riconoscevano nella birra uno specifico valore culturale. Il risultato è stato un “imborghesimento” dei gusti in fatto di bevande.
Negli anni Ottanta, i consumi legati ai modi di vita tradizionali della classe operaia registrano quindi un progressivo slittamento, sotto i colpi della crisi e delle politiche neoliberiste. Ma non dappertutto. John Clarke, nei suoi studi sul calcio e la realtà operaia, ha mostrato come i consumi e gli stili tipici delle classi lavoratrici, cacciati dai posti di lavoro e da molti ritrovi sociali, si siano riprodotti nel calcio. Ovviamente non nello spettacolo “borghese” dello sport, ma nella partecipazione attiva, nei cori, nelle curve, nelle bevute, nei rituali a volte violenti degli spettatori popolari. I figli della classe operaia in crisi, magari divenuti skinhead, diedero nuova vita a forme di partecipazione diretta, purtroppo anche con derive drammatiche. Il governo Thatcher rispose agli hooligans con la creazione di un organo specifico, con compiti di polizia e repressione. Ma il problema non era semplicemente di ordine pubblico: forse, si trattava della reazione alla fine di un certo mondo operaio, con i suoi consumi e i suoi spazi.
Come la diseguaglianza logora la nostra salute mentale

Quando le persone vengono interrogate su cosa abbia rilevanza per la propria felicità e per il proprio benessere tendono a parlare del valore delle relazioni con familiari, amici e colleghi. Il mondo dei rapporti intimi sembra contare di più rispetto ai beni materiali, al reddito o alla ricchezza.
La maggior parte delle persone probabilmente non ritiene che questioni più generali e strutturali, relative alla politica e all’economia, abbiano a che fare con la propria salute emotiva. Invece è così. Sappiamo da tempo che le disuguaglianze causano una vasta gamma di problemi di salute e di natura sociale: dalla ridotta aspettativa di vita alla più elevata mortalità infantile, dai bassi livelli di istruzione a una scarsa mobilità sociale fino all’aumento dei gradi di violenza.
La disuguaglianza logora il cuore del nostro mondo più intimo e personale, insinuandosi tra noi e gli altri, facendoci sentire vicendevolmente a disagio, facendoci preoccupare di come possiamo essere visti, rendendoci timidi e impacciati. Alimentando, in breve, tutte le nostre ansie sociali.
Per alcune persone queste ansie diventano tanto insostenibili da far diventare il contatto col mondo esterno un calvario e da spingerle all’isolamento. Altre continuano a partecipare alla vita sociale, ma sono costantemente assalite dalla paura di non aver argomenti di conversazione o di apparire noiose, stupide o sgradevoli. Sfortunatamente, tutti noi abbiamo la tendenza a considerare queste ansie una debolezza psicologica personale e pensiamo di doverle nascondere agli altri.
Un recente studio della Mental Health Foundation Survey1 ha scoperto che nell’anno passato il 74% degli adulti del Regno Unito era così stressato da sentirsi sopraffatto dalla situazione e incapace di reagire. Un terzo di questi ha avuto pensieri suicidi e al 16% è capitato di commettere atti di autolesionismo. Le cifre erano molto più elevate tra i giovani. Negli Stati Uniti i tassi di mortalità sono in crescita, soprattutto tra uomini e donne bianchi di mezza età, per motivi legati alla “disperazione”. Il che significa che muoiono a causa di dipendenze da sostanze stupefacenti o alcolici, suicidio e incidenti stradali. Sembra che un’epidemia di angoscia stia attanagliando alcune delle nazioni più ricche del mondo.
Le disparità socio-economiche sono determinanti in quanto rafforzano la convinzione secondo cui alcune persone valgano di più rispetto ad altre. Chi è al vertice sembra estremamente importante mentre chi sta alla base è considerato pressoché inutile. Nelle società meno eque siamo più portati a giudicarci in base alla condizione sociale e siamo maggiormente preoccupati di come ci reputano gli altri. Una ricerca condotta in 28 paesi europei2 dimostra che la diseguaglianza aumenta lo stato d’ansia rispetto alla propria posizione all’interno di tutte le fasce di reddito, dal dieci percento più povero al dieci percento più ricco.
Un altro studio3 relativo a come le persone vivano l’appartenenza a un basso status sociale sia in paesi ricchi che paesi poveri ha rivelato che, nonostante le enormi differenze di standard di vita in termini economici, in tutto il mondo coloro che soffrono condizioni di relativa povertà manifestano un forte senso di vergogna e disprezzo verso se stessi, reputandosi dei falliti: essere in fondo alla scala sociale determina la medesima propriocezione sia che si viva nel Regno Unito, in Norvegia, in Uganda o in Pakistan. Pertanto, il semplice innalzamento degli standard di vita economici non basta per generare un benessere autentico.
Se da un lato abbiamo i casi di scarsa autostima, un altro e opposto modo di reagire è l’ostentazione del proprio valore e dei traguardi raggiunti, l’“autoesaltazione” e il narcisismo. Sintomi psicotici come le manie di grandezza o la schizofrenia sono più comuni nei paesi a più elevato tasso di disuguaglianza. Come illustrato dal grafico sottostante, stando ai calcoli del Narcissistic Personality Inventory (NPI)4 eseguiti in successione su campioni di popolazione statunitense, il narcisismo cresce proporzionalmente all’aumentare della disparità di reddito.

Fonti: L’equilibrio dell’anima5 e Twenge et al 20086
Un risposta sta nel cercare altri modi di superare quella che gli psicologi chiamano la “minaccia di tipo socio-valutativo”, che si manifesta attraverso l’uso di sostanze stupefacenti, di alcol o con il gioco d’azzardo, cercando una consolazione emotiva nel cibo o dimostrando la propria condizione attraverso un consumismo eccessivo che evidenzi il proprio status sociale. Chi vive in luoghi affetti da una maggiore disuguaglianza sociale è più propenso a spendere soldi in macchine costose e negozi di lusso e ha più probabilità di contrarre forti debiti personali nel tentativo di dimostrare di non essere una “persona di seconda classe”, possedendo “oggetti di prima classe”.
Nelle pagine de L’equilibrio dell’anima mettiamo in discussione due dei concetti chiave che alcuni opinionisti utilizzano per giustificare il tollerare e il perpetuarsi della disuguaglianza.
Prima di tutto, attraverso l’analisi del nostro passato evolutivo e della nostra storia egualitaria, cooperativa, di condivisione tra cacciatori e raccoglitori; sfatiamo il falso mito secondo cui l’umanità sia, per natura, competitiva, aggressiva e individualista.
La diseguaglianza non è inevitabile e noi esseri umani abbiamo tutte le attitudini psicologiche e sociali per poter vivere diversamente.
In secondo luogo, contrastiamo anche l’idea secondo cui gli attuali livelli di disuguaglianza riflettano una giustificabile “meritocrazia”, che vede le persone dotate di capacità innate scalare la piramide sociale e gli incompetenti languire alla sue basi. È vero il contrario: la sperequazione dei redditi limita le pari opportunità; le differenze nel raggiungimento dei risultati e dei traguardi sono dettate dalle disuguaglianze piuttosto che esserne una conseguenza.
Infine, sosteniamo che la disuguaglianza sia uno dei principali ostacoli alla creazione di economie sostenibili, che permettano di ottimizzare la salute e il benessere sia delle persone che del pianeta. Il consumismo, avendo a che fare con l’autoesaltazione e la competizione basata sullo status sociale, è intensificato dalla diseguaglianza, che porta inoltre a un collasso dei valori societari quali la fiducia, la solidarietà e la coesione sociale, oltre a ridurre la volontà delle persone di agire per il bene comune. Ciò è dimostrato su tutti i fronti, dalla tendenza delle società più diseguali a porre poca attenzione al riciclo dei rifiuti fino ai sondaggi che mostrano come i leader d’impresa nelle società più inique siano meno interessati a sostenere gli accordi internazionali per la protezione dell’ambiente. La disuguaglianza si insedia come un nemico tra noi e ci impedisce di agire insieme per costruire il mondo che vogliamo.
Siamo davvero tutti coinvolti.
1 Stressed nation: 74% of UK “overwhelmed or unable to cope” at some point in the past year in https://www.mentalhealth.org.uk/news/stressed-nation-74-uk-overwhelmed-or-unable-cope-some-point-past-year
2 R. Layte, C.T. Whelan, Who Feels Inferior? A Test of the Status Anxiety Hypothesis of Social Inequalities in Health, in European Sociological Review, Volume 30, Issue 4, August 2014, pp. 525-535, https://academic.oup.com/esr/article/30/4/525/2763459, testo integrale in https://doi.org/10.1093/esr/jcu057
3 R.Walker, G.Bantebya Kyomuhendo, E. Chase, S.Chouldry, E.K. Gubrium, J. Yongmie Nicola, I. Lødemel, L. Mathew, A. Mwiine, S. Pellissery, Y.Ming, Poverty in Global Perspective: Is Shame a Common Denominator?, in Journal of Social Policy, Volume 42, Issue 2 April 2013 , pp. 215-233, https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-social-policy/article/poverty-in-global-perspective-is-shame-a-common-denominator/DED0C9DC02D8ABCAA8F177BA3CC477AB testo integrale in https://doi.org/10.1017/S0047279412000979
4 M. Twenge , S. Konrath ,J. D. Foster, W. K. Campbell, B. J. Bushman, Egos Inflating Over Time: A Cross-Temporal Meta-Analysis of the Narcissistic Personality Inventory, in https://www.ipearlab.org/media/publications/JoP2008a.pdf
5 Wilkinson,R., Pickett,K., The inner level. How more equal societies reduce stress, restore sanity and improve everone’s wellbeing, Penguin book, Londra 2019, tr.it Carlotti,G., L’equilibrio dell’anima. Perché l’uguaglianza ci farebbe vivere meglio, Feltrinelli editore, Milano 2019.
Come sta cambiando il capitalismo occidentale?

Molte volte il capitalismo è stato dato per finito, e molte volte si è rigenerato cambiando il proprio modo di funzionamento. Non è mai mutata, però, la natura profonda dello “spirito del capitalismo”, cioè il desiderio di trarre un profitto dal proprio lavoro da reinvestire in un continuo processo di accumulazione. È stato proprio questo il motivo del successo del capitalismo come principio di funzionamento dell’economia, a cui si è dovuta adattare la società nel suo complesso dotandosi di istituzioni sociali coerenti con l’incessante processo di accumulazione: dalla famiglia nucleare all’individualismo liberale, dalla democrazia come forma di organizzazione politica al welfare state come difesa dagli effetti negativi della competizione di mercato.
Contrariamente a quanto sostenuto all’inizio degli anni ’90 da alcuni studiosi a proposito della “fine della storia” e dell’inevitabile successo del modello sociale, politico ed economico occidentale, da almeno una ventina d’anni il capitalismo occidentale sta vivendo una profonda trasformazione. I fenomeni che hanno innescato questo processo sono noti, e senza pretese di esaustività possiamo ricordare la globalizzazione economica e culturale e la crescente competizione che essa innesca, le trasformazioni tecnologiche e le conseguenze che queste hanno sull’organizzazione della produzione e del lavoro, l’accelerazione dei movimenti di persone su scala globale che sfidano la rigida concezione della cittadinanza basata sull’appartenenza alla comunità nazionale. La “superiorità” del modello occidentale e la supremazia politica, militare e culturale dei paesi ad esso appartenenti (gli USA in primis) sono drammaticamente messe in discussione dall’emergere di paesi (per prima la Cina) che sono in grado di generare crescita economica e benessere per i propri cittadini pur negando quel pacchetto di diritti individuali (civili, politici e sociali per dirla con Marshall) che sono sempre stati considerati parte integrante e indispensabile del modello occidentale.
E infatti vediamo aumentare le disuguaglianze e regredire i diritti sociali in tutti, o quasi, i paesi occidentali, in primo luogo quelli europei. A questo si accompagnano crescenti tensioni sociali che creano fratture e conflitti sociali che la politica non sembra in grado di ricomporre. Si pensi per esempio al successo che stanno avendo movimenti politici populisti spesso xenofobi e di estrema destra in tutti i paesi europei, e in generale all’estremizzazione del confronto politico che ha portato al successo di Brexit in Gran Bretagna e all’elezione di Donald Trump negli USA.

Manifesto tratto dal patrimonio di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Tuttavia si segnalano anche fenomeni che potremmo chiamare di innovazione sociale ed economica, che lasciano immaginare una ridefinizione del modello sociale capitalistico. Innanzitutto, a fronte della crisi delle tradizionali appartenenze collettive (partiti e sindacati in primo luogo) si osservano nuove forme di aggregazione e identificazione da parte dei giovani. Per esempio, nelle città la mobilitazione su istanze locali, invece che sui grandi ideali novecenteschi, sembra in grado di aggregare i cittadini in modo trasversale. Si può forse intravvedere un nuovo tipo di partecipazione democratica non motivata dalle appartenenze contrapposte sull’asse del conflitto tra capitale e lavoro, ma dal riconoscersi cittadini che condividono interessi simili nella difesa del proprio contesto di vita. Quindi, meno ideologia e più pragmatismo. Il successo della sharing economy – al netto dell’uso strumentale che a volte ne viene fatto – è allo stesso tempo una soluzione innovativa che consente anche a chi possiede minori risorse economiche di accedere a consumi che altrimenti gli sarebbero preclusi, e l’espressione di un’attenzione ai beni collettivi che si era forse affievolita nei decenni passati. Il tutto grazie alla diffusione di quelle innovazioni tecnologiche che spesso vengono frettolosamente demonizzate come foriere di disoccupazione e declino economico.
In Western capitalism in transition. Global processes, local challenges (a cura di Andreotti, Benassi e Kazepov, Manchester University Press, in uscita a febbraio 2018), alcuni dei più noti scienziati sociali si interrogano su questi processi di mutamento del capitalismo contemporaneo e che investono diverse dimensioni sociali: il welfare state, la cittadinanza e le nuove forme di mobilitazione sociale, le migrazioni, le trasformazioni urbane, la povertà e i processi di segregazione spaziale.





