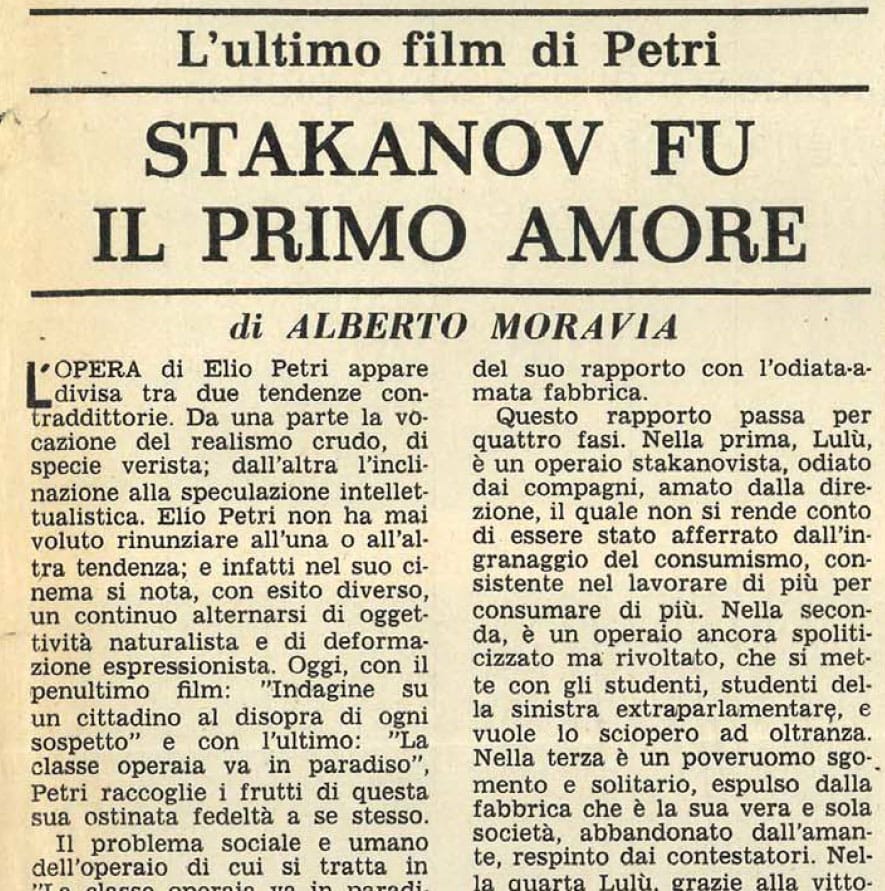Lavoratori
Capitolo 4
Il lavoro dovrebbe essere una funzione e una gioia, spesso non è altro che servitù e sofferenza. Dovrebbe essere la lotta di tutti gli uomini uniti contro le cose, contro le fatalità della natura e le miserie della vita; è spesso la lotta degli uomini tra loro.
Jean Jaurès
Inurbamento
A seguito della Seconda rivoluzione industriale, le grandi fabbriche richiamano masse ingenti di manodopera non qualificata, proveniente in larga misura dalla campagna. Uomini, donne e minori erano obbligati a lavorare anche dodici ore consecutive in ambienti malsani, privi di qualunque forma di tutela per infortuni o malattie. Sottopagati, vivevano in baracche prive di servizi igienici. In queste condizioni maturano la consapevolezza dei propri bisogni e dei diritti negati che sviluppano coscienza di classe e identità condivise.
Sindacalizzazione
A partire dalla metà del XIX secolo le masse di salariati si danno nuove forme organizzative collettive, dalle casse di mutuo soccorso alle associazioni sindacali di categoria alla rappresentanza politica dei propri interessi. Spesso nel corso del Novecento i soggetti politici e sindacali legati al movimento operaio hanno dovuto modificare le loro proposte sulla base delle nuove esigenze che stavano prendendo corpo sull’onda delle innovazioni all’interno dei processi produttivi e dei cambiamenti avvenuti nelle società.
Identità
Oggi processi come la globalizzazione, la frammentazione del mondo del lavoro, l’individualizzazione dei percorsi di formazione e occupazione e l’impatto della rivoluzione digitale pongono con urgenza il tema della costruzione di identità collettive nelle quali potersi riconoscere per restare un soggetto attivo in grado di incidere sull’agenda politica.
Guarda la photogallery
Le fonti presentate – relative agli Statuti ed ai regolamenti delle Società di mutuo soccorso – consentono di comprendere l’origine, la costruzione e l’affermazione nel tempo di una pratica sociale che si fonda sulle basi della stima di sé e, dunque, sulla percezione del lavoro come mezzo per l’elevazione morale.
1. Archivio della Società operaia di mutuo soccorso in Acquanegra sul Chiese, bozza di statuto e regolamento della Società di mutuo soccorso in Acquanegra sul Chiese, 1868.
2. Statuto e regolamento della società di mutua assistenza al lavoro fra i lavoratori fabbri-meccanici, Firenze, 1873, p. 14, riproduzione.
“La società si obbliga verso i singoli soci di soccorrerli ove ne sia riconosciuto il bisogno tanto se il medesimo si trova privo di lavoro, come pure se si trova ammalato. A tale scopo i singoli Soci non potranno rifiutarsi a qualunque sottoscrizione che venisse aperta per deliberazione del comitato nelle proporzioni che le sue finanze li permetteranno”.
Regolamento dell’Associazione generale di mutuo soccorso degli operai di Milano e corpi santi, Milano, 1867, riproduzione.
“È costituita una società, la quale prende il nome di Associazione generale di Mutuo soccorso degli operai della città di Milano e Corpi Santi. Essa ha per base l’unione e la fratellanza, per iscopo il mutuo soccorso materiale, intellettuale e morale. Tende quindi a procurare ai Soci che la compongono un soccorso in caso di malattia ed un sussidio in caso di vecchiaia; a facilitare ad essi il conseguimento del lavoro dell’istruzione, a promuoverne la moralità”.
3. CGT, Premier Mai 1937, Paris, Editions du Centre Confédéral d’Education Ouvrière, 1937.
Approfondimento
Le lotte e i diritti, intervista ad Aboubakar Soumahoro
La tecnica, il lavoro e la democrazia
Il lavoro in scena dentro e oltre la fabbrica
Il diritto del lavoro nella politica e nella cultura dell’Italia contemporanea
Le lotte e i diritti, intervista ad Aboubakar Soumahoro

Di seguito un’intervista ad Aboubakar Soumahoro sociologo e sindacalista del Coordinamento dei lavoratori agricoli USB a cura di Sara Troglio, ricercatrice di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
ST – La convergenza di singoli e gruppi – considerati come marginali dalla politica – verso forme di impegno sociale e di attivismo politico ha rappresentato, anche nel nostro passato prossimo, una delle strade più efficaci per l’inclusione di questi nella collettività e nella cittadinanza. Il soggetto che lotta è un soggetto che, di fatto, spezza la subalternità e gli stereotipi, costruendo attivamente la sua posizione sociale e la rappresentazione di sé. Ad oggi, quanto pesano le lotte – lavorative, sindacali – nella definizione di un nuovo protagonismo e di un nuovo attivismo sociale?
AS – Le lotte sindacali e sociali sono indispensabili, in particolare partendo dal contesto attuale di crisi e repressione sistematica delle lotte, quando sono espressione di processi che vedono il protagonismo dei diretti interessati. Quanto più i soggetti di una lotta diventano consapevoli dei propri diritti, quanto più si connettono i diritti sindacali e i diritti sociali, tanto più cresce il peso delle questioni sindacali nel conflitto.
ST – Possono ancora rappresentare un modello di “inclusione” – per esempio per i lavoratori stranieri – attraverso cui divenire pienamente cittadini?
AS – I lavoratori sono lavoratori tout court. Però è chiaro che le lotte sindacali, là dove coinvolgono lavoratori e lavoratrici definiti “stranieri”, possono essere l’occasione di lotte per diritti generali e non di solo di un mero segmento lavorativo. L’unica inclusione possibile è quella che non è frutto di concessioni caritatevoli, ma nasce dal protagonismo e dalla lotta dei soggetti esclusi.
ST – Chi è oggi, nella società italiana, l’escluso, l’invisibile, il marginale? Questa marginalità in che contesto e in che luoghi si attua (politica, lavoro, città)?
AS – Gli esclusi e gli invisibili sono i dannati della globalizzazione. Sono anche le donne che continuano a subire forme di esclusione e di sfruttamento tanto quanto i migranti. Una marginalità che si manifesta nelle varie articolazioni della nostra comunità sia nella dimensione sociale, culturale che lavorativa.
ST – I cambiamenti del mondo del lavoro e del sistema produttivo a cui stiamo assistendo hanno spesso fatto parlare gli osservatori di “crisi dei corpi intermedi ”e“ del sindacato”. Qual è lo stato di salute della rappresentanza sindacale?
AS – Non parlerei di crisi del sindacato, ma di crisi di un certo modo di praticare e rappresentare gli interessi sindacali e sociali di uomini e donne che faticano a soddisfare i propri bisogni vitali. Quindi penso che ci sia bisogno dello strumento sindacale. Un sindacato capace di coniugare indipendenza e ricerca di convergenze è più che mai necessario.
ST – In questo scenario, le strada di sindacato e lavoratori sembrano destinate a dividersi: quale futuro spetta al sindacato?
AS – Non credo, perché non c’è sindacato senza lavoratori e lavoratrici direi. Però casomai il rischio di una divisione tra una certa burocratizzazione di fare sindacato e lavoratori. Però si tratta di situazioni che vanno circoscritte e non da generalizzare. Oggi c’è assoluto bisogno dello strumento sindacale, perché è necessario avere una capacità organizzativa che sia all’altezza delle sfide che dobbiamo affrontare.
ST – E quale futuro per i lavoratori?
AS – Il futuro per i lavoratori è da leggere in un presente fatto di atomizzazione e costante abbrutimento dei lavoratori. Parlerei di un futuro che sarà caratterizzato da maggior attacco a diritti e dignità dei lavoratori e delle lavoratrici. Perché parliamo dell’era della digitalizzazione e di un datore di lavoro sempre più transazionale e globale.
ST – Su quali anticorpi possiamo oggi investire per rafforzare il nostro impegno per una società più aperta e solidale?
AS – Ci tocca partire dalla cultura e dalla sua valorizzazione, dobbiamo saper “restare umani”. Quindi bisogna partire dalla persona nel rispetto della sua dignità e delle sue libertà in una prospettiva di giustizia sociale per l’intera società.
ST – Qual è il rapporto fra filiera agroalimentare italiana e sfruttamento del lavoro regolare e nero? Quanto sfruttamento c’è dietro ad uno dei settori più al centro della narrazione sul Made In Italy?
AS – Basta girare nelle nostre aree rurali e le sue campagne, vedere le condizioni di sfruttamento di migliaia di lavoratrici e lavoratori per interrogarsi sui prezzi che troviamo sui banchi dei supermercati. Voglio dire che il rapporto fra filiera agroalimentare italiana e sfruttamento del lavoro regolare, sommerso o “grigio” è caratterizzato da forme di privazione dei più elementari diritti salariali, previdenziali, sindacali e sociali. Spesso tutto questo è volutamente trascurato nella narrazione sul Made In Italy, perché bisognerebbe ammettere che ci sono persone che lavorano 12 ore al giorno, per due euro all’ora, mentre dall’altra parte cresce sempre più il fatturato delle imprese della grande distribuzione organizzata.

Aboubakar Soumahoro, manifestazione braccianti agricoli, Foggia, 2018
La tecnica, il lavoro e la democrazia

Era il sogno di Ford e di Taylor, così come oggi sembra esserlo di Ryanair e di Foodora: indebolire il sindacato ed evitare la democrazia nelle imprese. Tesi e tendenza ben riassunta da un neoliberale tedesco come Wilhelm Röpke: «L’imprenditore può paragonarsi a un navigatore (…). Sarà ragionevole, da parte dell’equipaggio di non accampare richieste di ‘partecipare alle decisioni’ o di ‘democratizzazione’ della guida della nave. La democrazia qui è fuori luogo, come nella sala operatoria. La vera democrazia economica sta altrove e cioè sul mercato, dove sono i consumatori ad essere gli elettori»1. 
Tesi surreale e falsa (l’impresa non è una sala operatoria e gli elettori/consumatori, cioè la domanda, sono sempre prodotti dall’offerta – a questo serve il marketing – e quindi il mercato non è mai democratico in sé); e che soprattutto contraddice uno dei fondamenti dello stato di diritto (liberale): il bilanciamento e il controllo reciproco dei poteri (anche nell’impresa). Ma questa è l’essenza e la ragione di ciò che definiamo tecno-capitalismo2.
Ma oggi quel sogno si realizza grazie alla tecnica intesa come sistema di macchine/apparati, sempre più convergenti tra loro. Facendoci passare non dal vecchio e pesante fordismo a un leggero, virtuoso e flessibile post-fordismo (come troppo ingenuamente si è sostenuto), ma dal fordismo concentrato nelle fabbriche chiuse da quattro mura del ‘900 – perché questo permetteva allora il mezzo di produzione/connessione, cioè la catena di montaggio (che resiste anche oggi, rinominata come World Class Manufacturing) – al fordismo individualizzato ed esternalizzato di oggi, dove il vero mezzo di produzione/connessione è una piattaforma (Amazon, Uber, Foodora, ecc.), trasformando la rete nella nuova Fabbrica-rete.
Non la Fabbrica 4.0, ma la Fabbrica-rete dove ciascuno è messo al lavoro incessantemente e a produttività crescente, sia nel lavoro di produzione e di consumo h24, sia nel lavoro (gratuito) che svolge quando naviga e condivide in rete lasciando i suoi dati e i suoi profili che diventano profitto privato per i signori del silicio3.
È quindi la rete-piattaforma come sistema tecnico che ha permesso di scomporre e di flessibilizzare ancora di più la struttura organizzativa delle imprese rispetto al just in time del modello-Toyota degli anni ’70; e di passare dal lavoro/diritto (pesante, ma stabilizzato) al lavoro/merce di oggi. Lavoro a chiamata o altrimenti definito on demand o lavoro in deroga (dai diritti e dalla dignità), ancora più pesante di ieri, ma oggi accettato/subìto nel segno disciplinare – tecnico e neoliberale – del: non ci sono alternative. Un lavoro uberizzato e sempre più low cost grazie alla messa in competizione tra loro (ancora il neoliberalismo) dei lavoratori. Che si devono però credere imprenditori di se stessi o micro-capitalisti liberi e indipendenti – come ha sentenziato (in perfetto formalismo giuridico e funzionale ortodossia neoliberale, rinunciando a capire le nuove forme tecniche di organizzazione del lavoro) il Tribunale di Torino contro i riders di Foodora.
Qualcuno chiama tutto questo: innovazione che non si può e non si deve fermare. Oppure – ancora i neoliberali – dice che l’uomo e la società devono sempre adattarsi alle trasformazioni richieste/imposte dall’economia di mercato e dalla divisione del lavoro. Ed è ciò che appunto è accaduto, dal Pacchetto Treu al JobsAct, destra e sinistra sempre fraintendendo la vera natura della tecnica – che non è neutra(le), ma di parte: quella del profitto capitalistico e soprattutto dell’accrescimento del proprio potere di apparato.

Battersea Power Station di Londra, antica sede della centrale elettrica.
Nel 2021 diventerà una sede di Apple
Tutto questo significa però non governare i processi tecnici e capitalistici – sbilanciando pericolosamente la struttura dello stato di diritto e negando la democrazia. Processi che infatti – se non governati dal demos – sostituiscono progressivamente le proprie forme e norme tecniche e di mercato alle forme sociali e democratiche4), producendo – oltre a quelle marxiane, oggi replicate nei lavoratori autonomi ma dipendenti dalle piattaforme – nuove forme di alienazione: del demos dalla sovranità e degli uomini dalla possibilità/capacità di mutare le cose, perché sempre più chiusi nella gabbia d’acciaio weberiana (oggi virtuale), presi da un determinismo tecnologico integralista, illiberale e soprattutto anti-democratico, ma dal forte e affascinante inprinting5. Utile allora richiamare – soprattutto per la sinistra, o quello che ne resta (poco), ma anche per il sindacato – un pensiero del filosofo Salvatore Veca6: No Innovation without Representation (and Participation).
Perché se la Fabbrica oggi si chiama rete, allora occorre portare la democrazia oltre i suoi cancelli virtuali. Non solo contrattando gli algoritmi (sarebbe un mero re-agire, a valle), ma appunto governando democraticamente (risalendo a monte) i processi tecnici (e non solo capitalistici) che li generano e impongono.
1 W. Röpke (1974), Scritti liberali, Sansoni, Firenze, pag. 160
2 L. Demichelis, La religione tecno-capitalista, Mimesis, Milano, 2015; Id. (2017), Sociologia della tecnica e del capitalismo, FrancoAngeli, Milano
3 E. Morozov (2016), Silicon Valley: i signori del silicio, Codice, Torino
4 G. Anders (2003), L’uomo è antiquato, 2 voll., Bollati Boringhieri, Torino; J. Ellul (2009), Il sistema tecnico, Jaca Book, Milano
5 F. Chicchi – A. Simone (2017), La società della prestazione, Ediesse, Roma
6 S. Veca (2018), Il senso della possibilità, Feltrinelli, Milano
Il lavoro in scena dentro e oltre la fabbrica

1971. Elio Petri scrive la sceneggiatura e dirige La classe operaia va in paradiso, un film che per molti aspetti marca un’epoca e, soprattutto, uno stile di recitazione. Il tema è la condizione del lavoro in fabbrica, l’alienazione da lavoro, il senso del riscatto, la dignità che il ritmo del lavoro spesso aggredisce e svilisce. Lulù, il protagonista, è l’operaio prima dedito al lavoro e poi, in seguito a un incidente in cui subisce una mutilazione a una mano, indotto a riconsiderare la sua vita, il suo lavoro, il confronto con la sua doppia famiglia (prima moglie e la convivente), ma anche con il sindacato, con gli altri operai con cui non ha mai avuto un rapporto amichevole. Un film che non lascia indifferenti i molti critici già allora, come si vede dalle tre diverse opinioni – di Mino Argentieri sul settimanale Rinascita, di Alberto Moravia sul settimanale L’Espresso e di Goffredo Fofi sul periodico Quaderni piacentini – che abbiamo tratto dal patrimonio di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
A quasi cinquant’anni dall’uscita del film, viene da chiedersi se il 1971 sia irrimediabilmente lontano, o se viceversa qualcosa di quel mondo viva ancora nel nostro quotidiano. Rivedere Lulù – riascoltare il suo mantra “un pezzo, un culo, un pezzo, un culo, un pezzo, un culo”, con cui tiene il livello della produzione e scandisce il ritmo della sua alienazione – ci induce a domandarci: dopo quasi cinquant’anni, le cose sono cambiate? Come sono cambiate? E qualcosa, invece, è rimasto come allora?
1971. Alberto Moravia su L’Espresso
Scarica la fonte
1971. Mino Argentieri su Rinascita
Scarica la fonte
1917. Goffredo Fofi su Quaderni piacentini
Scarica la fonte
Il diritto del lavoro nella politica e nella cultura dell’Italia contemporanea

Estratto dal libro L’Italia che lavora. Persone, flessibilità, prospettive, edito da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in collaborazione con The Adecco Group.
L’inarrestabile aumento delle forme contrattuali atipiche, il ricorso distorsivo al lavoro autonomo […], l’agglomerarsi del potere economico intorno a strutture mastodontiche capaci di inseguire i mercati più convenienti, sono tutti fattori che complicano vertiginosamente l’agenda pubblica e quella giuslavoristica.

Persino sotto il cielo della costituzione e dello Statuto dei lavoratori, degli astri che avevano permesso una declinazione fortemente promozionale del garantismo, si iniziano ad annidare interpretazioni di segno opposto: in nome dell’identico principio dell’uguaglianza sostanziale si ritiene che certe previsioni […] abbiano comunque contribuito (è il caso dell’art. 18 St. lav.) a scavare un fossato incolmabile tra insiders e outsiders, tra inclusi ed esclusi, tra chi sta dentro (le tutele, il mercato, i diritti) e chi sta fuori[1].
Con i nuovi esclusi che sembrano scontare «un tasso di inutilità sociale molto più elevato dei loro predecessori ottocenteschi: non servono al mercato, in quanto relegati in uno status di non consumatori, ma nemmeno vengono a formare un esercito industriale di riserva, dal momento che nella seconda modernità la produzione sembra aver bisogno di un numero decrescente di addetti e si preoccupa soprattutto di potenziare il proprio corredo tecnologico e diminuire il costo del lavoro»[2].

I tradizionali baluardi del garantismo laburista – il collettivo e lo statuale – non godono, del resto, di buona salute: lo Stato «non è deceduto, ma [sicuramente] è azzoppato»[3]: incrinate – dalla crisi interna e dal volto di un’economia incurante dei confini nazionali – le sue capacità di integrazione sociale, capacità in buona parte legate alla tenuta del legame territorio-sovranità[4], lo Stato sembra riabilitare […] il proprio volto di tutore della sicurezza tout court. Parallelamente, posto di fronte al rischio di fratture all’interno della sempre meno omogenea caratterizzazione del lavoro, il sindacato sconta la difficoltà a raggiungere ampi strati di lavoratori, proprio in ragione del loro profilo occupazionale intermittente e mutevole.
[In questo quadro pare che] il lavoro corra il rischio di perdere la propria centralità di veicolo privilegiato per la realizzazione di certi valori (autonomia, libertà, dignità) posti a fondamento della vita democratica. Cercare altrove le risposte per rendere ancora plausibili ed effettivi quei valori può allora esprimere anche una scelta di resistenza alla prepotenza prevaricatrice del mercato o, più realisticamente, per trovare un momento di raccordo tra mercato e tutele: reddito di cittadinanza, welfare mix, flexsecurity possono cioè essere dipinti come strumenti di rottura col passato, ma nondimeno incaricati di rinnovare, accanto e oltre il lavoro, la centralità della persona. Che si immagini un reddito minimo garantito, un concorso (virtuoso) tra privato e pubblico sul fronte delle politiche sociali, o che si ritenga di poter compensare la flessibilità in ingresso e in uscita attraverso una corrispondente security, interessata a riqualificare e a creare nuove opportunità di impiego, può anche costituire una scelta sensata (o, meno ottimisticamente, obbligata) per gli ordinamenti[5]. Affiancata, però, da qualche clausola di cui si dovrebbe asserire l’inderogabilità. In particolare, l’eventuale distanza tra intenti dichiarati e risultati conseguiti, non può, in tali ipotesi, essere archiviata tra gli inconvenienti, più o meno usuali, più o meno fisiologici, del gioco socio-politico, visto che a essere coinvolti sono beni giuridici dal cui rispetto dipende la stessa possibilità di qualificare come democratica una convivenza. Al tempo stesso, ritenere che possano essere immaginate e sperimentate nuove modalità di intersezione tra mercato e regolazione, tra etica del lavoro ed etica del profitto, tra doveri e diritti, rappresenta il modo per non arrendersi all’idea che si stia consumando un «ribaltamento totale di prospettiva», responsabile di aver trasformato il lavoro in una semplice «variabile dipendente» del gioco economico[6] e per non cedere a «quella convinzione, spesso rappresentata nel corso dell’età moderna, secondo cui economia e politica apparte[rrebbero] a due mondi diversi: il primo fatto di dure oggettività, di rapporti naturali e necessari, il secondo fatto di volontà artificiali, più o meno ideologicamente determinate»[7].
Sarebbe, ad esempio, necessario che l’agenda pubblico-politica non limitasse la ‘questione-lavoro’ all’esame dei soli due estremi della catena occupazionale – le tipologie di contratto individuale di lavoro, da un lato; il sistema degli ammortizzatori sociali, dall’altro – senza un’adeguata considerazione di tutto ciò che sta in mezzo, delle politiche e degli attori, privati e pubblici, che dovrebbero costituire il fulcro di una scommessa regolativa, tanto complessa quanto indispensabile. Viceversa l’evenienza di una lotta tra deboli pare difficilmente arginabile: la pellicola, bellissima e scarna – Due giorni e una notte – sintetizza meglio di tante parole il peso di un presente che rischia di non riscattarsi.