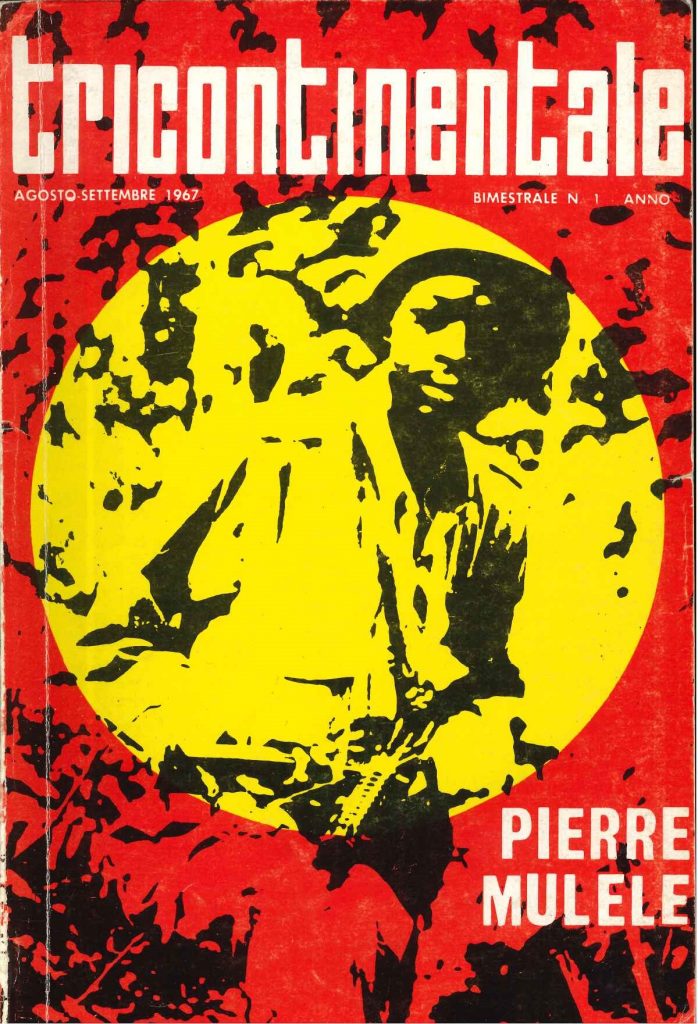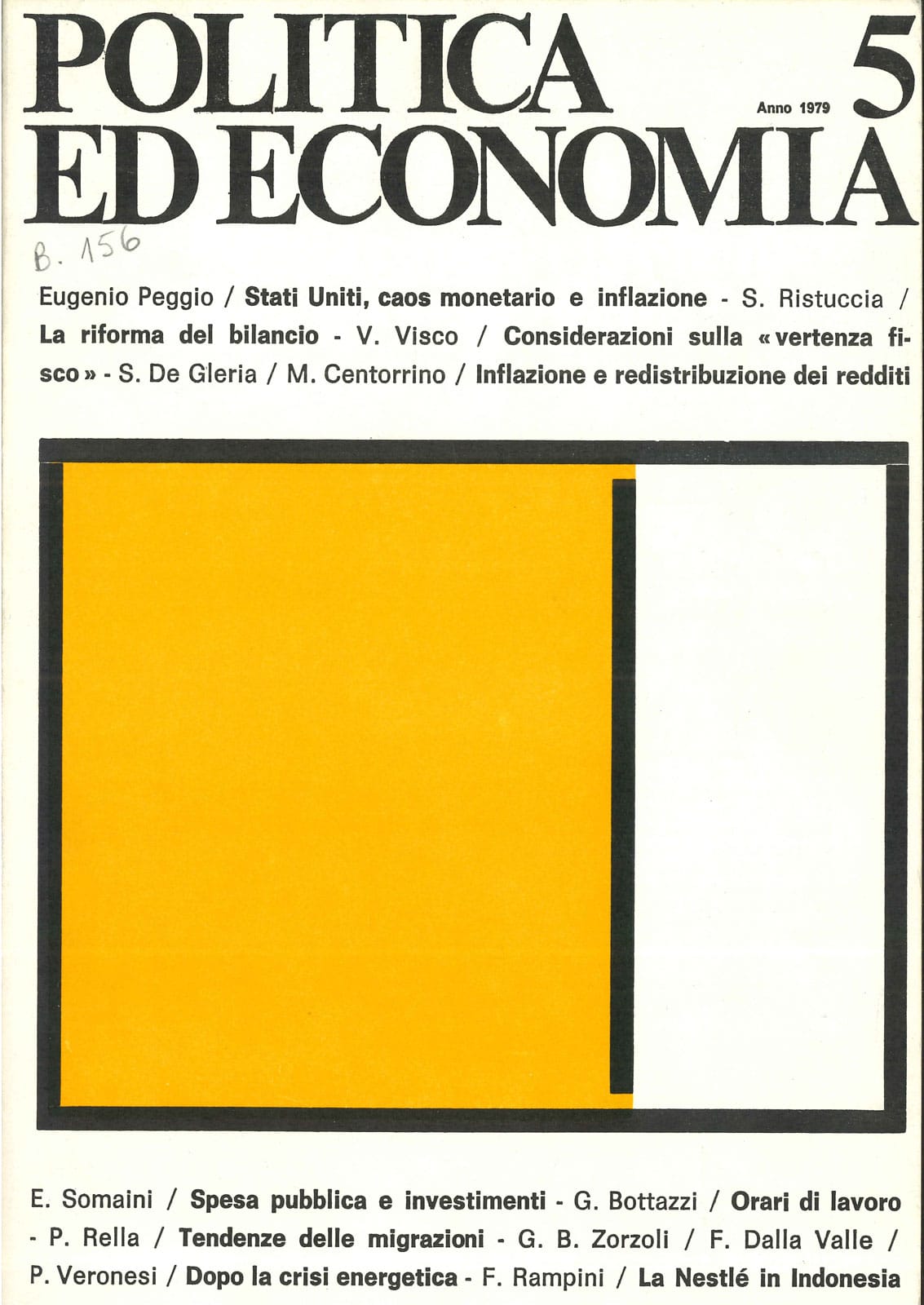Mai più schiavi!
Capitolo 4
Le violenze del 1960
Il 21 marzo 1960 a Sharpeville, in Sudafrica, 7.000 persone si radunano davanti alla stazione di polizia per protestare contro la Pass Law, che regola i lasciapassare segregando la popolazione nera, che costituisce la stragrande maggioranza dei cittadini. In risposta alla protesta pacifica la polizia apre il fuoco uccidendo 69 civili, ferendone 180 e arrestando 20 mila persone.
In Sudafrica i coloni bianchi – sia inglesi sia di origine olandese, i boeri – avevano costruito un regime di discriminazione che aveva trovato nelle leggi di apartheid del secondo dopoguerra una vera separazione e sudditanza razziale.
Il 1960 è anche l’anno in cui svanisce il sogno di Patrice Lumumba, Primo ministro della Repubblica del Congo divenuta indipendente, rapito e ucciso a seguito di un colpo di Stato militare.
Le conseguenze del colonialismo
Gli esiti della lotta per l’indipendenza e per l’emancipazione dal colonialismo sono ancora presenti e caratterizzano i rapporti tra il Nord e il Sud del mondo. I legami di dipendenza e subordinazione che imbrigliano la crescita e il processo di riscatto dei paesi in via di sviluppo non sono terminati con la fine del colonialismo.
Il regime sudafricano dell’apartheid è caduto solo all’inizio degli anni Novanta, dopo la liberazione dal carcere
di Nelson Mandela, mentre ancora oggi il Congo continua a pagare il prezzo di questa dipendenza coloniale: sebbene sia un paese ricchissimo di minerali e materie prime, resta uno dei più poveri del mondo.
Guarda la photogallery
Approfondisci
1948
Il Partito Nazionale sudafricano vara una serie di leggi e norme che istituiscono il regime di segregazione razziale di Apartheid. La separazione avviene attraverso la creazione del sistema delle Homeland – Bantustan: ghetti sovrappopolati (80% della popolazione nel 13% del territorio) senza risorse, posti in aree improduttive e senza acqua. Attraverso questo sistema, ogni sudafricano non-bianco, costretto a spostarsi nelle ricche industrie, miniere e piantagioni delle aree boere del paese, si trova nella condizione di straniero, senza diritti né tutele.
1961
17 GENNAIO
Patrice Lumumba, primo presidente del Congo eletto democraticamente, viene rapito e ucciso da paramilitari sostenuti dal Belgio, ex potenza coloniale della regione. Nei giorni seguenti, contingenti statunitensi, inglesi e belgi reprimono nel sangue le proteste della popolazione, favorendo il colpo di stato di Mobutu.
1990
FEBBRAIO
Dal 1984 il Sudafrica vive una lunga crisi economica acuita dal coinvolgimento nella guerra in Angola. La situazione spinge il Governo a concedere riforme, nel timore che il malcontento delle comunità nere possa rovesciare il regime di Apartheid. Nel 1990 il Governo di Frederik de Klerk rende legali partiti e sindacati non-bianchi, scarcerando il leader del Partito del Congresso antiapartheid Nelson Mandela dopo 26 anni di carcere duro.
1994
27 APRILE
In Sudafrica le prime elezioni democratiche con suffragio esteso a tutti gli abitanti affidano il governo all’African National Congress e al suo leader, Nelson Mandela.
1997
MAGGIO
Il regime “cleptocratico” eretto da Mobutu, senza sostegno internazionale e al collasso economico e sociale, crolla durante la devastante guerra con Rwanda e Uganda.
Kit didattico: Opportunità per tutti
Khomeini ritorna a Teheran e fonda la Repubblica Islamica dell’Iran. 1 febbraio 1979
Piazza Massaua, Torino. Ri(n)tracciare la memoria coloniale
La Storia dovrà tener conto dei poveri d’America
Kit didattico: Opportunità per tutti

Il 14,5% della popolazione mondiale è povero: oltre un miliardo di persone vive con meno di 1,25 dollari al giorno, tra queste, una su tre ha meno di 13 anni. Cosa significa essere poveri? La povertà è un problema complesso e si accompagna al tema delle disuguaglianze. Lo sapevi che il 10% della popolazione globale non ha accesso ad efficienti servizi di acqua potabile? Che nel 2011 65 milioni di ragazze non hanno avuto accesso all’istruzione primaria e secondaria?
Il kit didattico Opportunità per tutti stimola una riflessione su disuguaglianza e giustizia sociale collegati al tema della “cittadinanza” e prende in esame il programma di assistenza sociale brasiliano Bolsa Familia finalizzato a ridurre la povertà anche attraverso l’accesso a istruzione, servizi sanitari.
Khomeini ritorna a Teheran e fonda la Repubblica Islamica dell’Iran. 1 febbraio 1979

Il Medio Oriente non sarebbe stato più lo stesso. La Rivoluzione iraniana del 1979 avrebbe spostato l’asse del conflitto israelo-palestinese verso l’Iran, come nuovo centro della crisi, avrebbe avuto un impatto decisivo nel delineare nuove tendenze nel mondo islamico, grandi movimenti geopolitici e nel segnare una tappa del rapporto tra Nord e Sud del mondo. Khomeini era un leader rivoluzionario decisamente atipico per quanto riguarda il mondo islamico, dato che era esponente della minoranza sciita rispetto alla maggioranza sunnita dei musulmani, ma è stato proprio lui a dare vita al risveglio dell’Islam politico, facendone un fenomeno di massa, statale e istituzionale. Era, allo stesso tempo, un rivoluzionario inedito nel contesto delle rivoluzioni del Novecento: se la matrice culturale e ideologica dei movimenti e dei leader che hanno condotto i loro popoli fuori dal colonialismo si era, fino a quel momento, ispirata al marxismo o era comunque legata ai principi della modernità, Khomeini faceva perno attorno ai principi religiosi del Medioevo persiano, stabiliti dalla dinastia dei Safavidi dello Sha Ismael del XVI secolo. E questo avveniva al principio dell’era post-industriale in cui il mondo stava assumendo il volto della globalizzazione.
La vicenda della Rivoluzione iraniana ci pone, pertanto, di fronte alla necessità di riflettere, oggi, su binomi troppo spesso dati per scontati: modernizzazione e secolarizzazione, religione e politica, globalizzazione e conflitto.
Tratti dal Patrimonio della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, pubblichiamo un articolo di Loris Gallico “Khomeini, l’Iran e il Medio Oriente” (in «Politica ed economia» n. 5/ settembre-ottobre 1979) un’ottima sintesi geopolitica del Medio Oriente all’indomani della Rivoluzione in Iran in cui l’autore mostra fiducia in una possibile evoluzione democratica del paese e l’articolo di Maurizio Peggio “Prima del dopo Khomeini” (in «Politica ed economia» n. 5/ maggio 1989) in cui vengono messi in luce, dieci anni dopo, lo stato di salute del paese e le sue divisione sociali e politiche interne.
Scarica l’estratto dal patrimonio di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Politica ed Economia, 1989
Scarica l’estratto dal patrimonio di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Politica ed Economia, 1979
Qui di seguito la ricostruzione di Paolo Branca dell’Università Cattolica di Milano
Benché la rivoluzione islamica del 1979 in Iran avesse molte anime, tra le quali anche una sorta di teologia della liberazione rappresentata soprattutto da ‘Ali Shariati, il regime teocratico-clericale che prevalse infine fu quello dominato dall’ayatollah Khomeini: una sorta di riedizione in salsa islamica dello stato-etico, con chiari elementi populisti. Se ne evince l’orientamento dalla stessa Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran: «La Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran, che è espressione dei fondamenti culturali, sociali, politici ed economici della società iraniana, è basata sui principi e sulle norme dell’Islam, in conformità alle autentiche aspirazioni della comunità islamica. Tale aspirazione fondamentale si è manifestata nella natura della grande Rivoluzione islamica dell’Iran e nel corso delle lotte del popolo musulmano che, dall’inizio sino alla vittoria, l’ha espressa nelle esplicite e ferme parole d’ordine di tutti i gruppi sociali. Ora, all’alba di questa grande vittoria, il nostro popolo ne cerca con tutta la propria forza la realizzazione completa».
La caratteristica fondamentale di questa Rivoluzione, rispetto ad altri movimenti sorti in Iran nell’ultimo secolo, risiede nel suo essere islamica e nel suo riferirsi ad un orientamento di pensiero. Il popolo musulmano dell’Iran, che si era già mobilitato nel movimento per la monarchia costituzionale contro il dispotismo, e nel movimento anticolonialista per la nazionalizzazione del petrolio, grazie a queste dure esperienze aveva compreso che la ragione principale dell’insuccesso di tali movimenti era costituito dalla mancanza di un’ispirazione dottrinale per le loro lotte. Sebbene nelle recenti mobilitazioni l’ideologia islamica e la guida del clero che combatteva per il progresso avessero svolto un ruolo rilevante e basilare, tuttavia quei movimenti non ottennero la vittoria, e rapidamente declinarono, perché le lotte si erano allontanate dalle originali posizioni islamiche.

Il progetto del governo islamico, fondato sul principio della “tutela del giurisperito islamico”, quale fu presentato dall’Imam Khomeini nel periodo culminante della repressione politica operata dal regime dispotico, creò nel popolo musulmano un nuovo e consistente incentivo: esso preparò la strada per la lotta ispirata all’ideologia islamica e rafforzò gli sforzi dei Musulmani impegnati e combattenti sia all’interno sia all’esterno del Paese.
Il movimento proseguì in questo percorso fino a quando le insoddisfazioni e la fermezza del furore crescente della popolazione, causate dalle pressioni e repressioni crescenti nel Paese, e in tutto il mondo l’eco e i riflessi della lotta delle guide religiose e degli studenti impegnati, scossero violentemente le basi del potere del regime: quest’ultimo, e i suoi padroni, furono così costretti ad allentare la pressione e la repressione e a cercare una sorta di distensione nell’ambiente politico, illudendosi di poter impedire la propria disfatta ormai certa. Ma il popolo insorto, consapevole e risoluto, sotto la guida ferma dell’Imam sempre indomito, avviò ed estese a tutto il Paese la propria vittoriosa e unitaria insurrezione.
Dalla Costituzione della Repubblica Islamica dell’Iran, uno stralcio de “La forma dello Stato nell’Islam”:
«Nella concezione islamica la forma dello Stato non scaturisce da particolari situazioni sociali o dalla supremazia di un individuo o di un gruppo: è invece l’espressione degli ideali politici di un popolo, unificato dalla stessa religione e dallo stesso modo di pensare, che dà a se stesso un’organizzazione, grazie alla quale nel corso della propria evoluzione spirituale possa aprirsi la via verso la meta finale, movendo cioè verso Dio. Nel suo processo di evoluzione rivoluzionaria il nostro popolo si è liberato dalla polvere e dal sudiciume della tirannia e delle influenze culturali straniere, per tornare all’ideologia e alla visione del mondo islamica. Ora esso sta per edificare una società esemplare sulla base delle norme islamiche. Compito di questa Costituzione è creare le condizioni per il radicamento delle convinzioni del movimento e il terreno favorevole affinché l’essere umano possa nutrirsi dei supremi valori della dottrina universale dell’Islam. In considerazione dell’ispirazione islamica della Rivoluzione dell’Iran, che ha rappresentato un movimento verso la vittoria di tutti gli oppressi sugli oppressori, la Costituzione prepara il terreno affinché tale rivoluzione prosegua sia all’interno che all’esterno del Paese. In particolare si impegna nell’allargamento dei rapporti internazionali con altri movimenti islamici e popolari affinché si renda possibile la creazione di un’unica comunità mondiale. In forza della natura propria di questo grande movimento, la Costituzione garantisce contro ogni forma di tirannide sociale o ideologica e contro la monopolizzazione dell’economia, liberandosi dal dispotismo, e si impegna a rendere il popolo padrone del proprio destino».
Piazza Massaua, Torino. Ri(n)tracciare la memoria coloniale

La città come misura della modernità europea, come protocollo d’economia lungo reti e traiettorie che conducono fuori dall’Europa, negli altri continenti. La città come strumento entropico della conflittualità e quale luogo della governamentalità delle soggettività insubordinate e dissentite. La città, ancora, come disseminazione, tra pubblico e privato, della memoria collettiva, ma anche come silenzioso procedere dell’oblio e delle pratiche di dimenticanza, come archivio di ricordi ‘incarnati’ che ridisegnano i territori a partire dalle posizionalità dei soggetti. La città è tutto questo, e tanto ancora. Lo sguardo critico sulla città (Lefebvre 1967) permette di elaborare un modello interpretativo al ‘negativo’, ossia capace di mettere in evidenza continuità e discontinuità tra passato coloniale e condizione postcoloniale. Facendo saltare i dispositivi che regolano la linearità e i sistemi di coerenza della cultura delle nazioni europee – e determinando quindi fratture, squarci e discontinuità che fanno emergere linguaggi ibridati e meticci – questo approccio è particolarmente interessante per comprendere forme di resistenza all’interno dei confini d’Europa.
‘Faire la ville’, fare la città, secondo l’antropologo Michel Agier è il processo complesso e mai finito che realizza il «diritto alla città» qui e adesso attraverso pratiche controverse e minori, le quali acquistano significati radicali perché evocano il desiderio e il piacere della creazione del sogno, virtuale o ideale, della città (Agier, 2015). Tra di esse vi è, senza dubbio, l’occupazione dello spazio, la creazione di percorsi e di traiettorie che ricalcano, eludono o attraversano altre traiettorie, antiche, dimenticate e nascoste tra il reticolo di strade della città, tra i «frammenti e luoghi [che] scompongono la totalità invisibile della grande città permettendo di dargli un’altra forma, sensibile, fondata sull’esperienza, quella di un ologramma personale che consente, in ultima analisi, un’identificazione al nome del luogo, identificazione molteplice prima di essere comune» (Agier, 2015: 37-38).
Guardare alle periferie significa osservare la città nel suo spazio più giovane. Spostare l’attenzione dal centro ai margini in cui il sogno, la città pensata, ha preso forma in tempi più recenti. Fuori dalle antiche mura, lontano dai salotti cittadini, esiste uno spazio che, frammento dopo frammento, è stato conquistato in un tempo più vicino a quello presente ma, paradossalmente, meno vivo nella memoria di chi lo spazio urbano lo vive e lo attraversa quotidianamente. ‘Interland’ era una categoria usata, per la prima volta in Libia, per descrivere le aree periferiche della colonia: il termine, negli anni Cinquanta, fu usato in Italia per marcare il crescere della città dai suoi confini più estremi. Se il centro è il luogo simbolico di attrazione e gravitazione della popolazione, con un moto temporale circolare e scadenzato proprio del farsi della storia, nella periferia – sebbene progettata dal centro – germinano spazi interstiziali capaci di accogliere post-memorie del colonialismo e racconti di diaspore che rimettono in discussione la geografia del passato e la storia degli spazi nazionali, continentali e urbani.
Giovani e dalla memoria spesso obliata, gli spazi delle periferie sono “segnati” meno in profondità dal procedere del racconto del passato e del futuro. Spazi conquistati da sogni recenti e percorsi di traiettorie frammentarie, le periferie fanno fatica a essere riconesse alla storia della città e a trovare riconoscimento nella memoria condivisa della comunità. Non di meno sono spazi di produzione di nuove socialità, in cui memorie e linguaggi antichi e nuovi vengono risemantizzati, accolti dal centro, rielaborati e rimandati indietro. Spazi in cui i «ritmi» della città (De Boek 2015; Chambers 1985) a volte dissentono da quelli delle vie centrali, le periferie sono il vero reame del ‘faire la ville’, ossia quel processo che permette alla città di sopravvivere (Agier 2015). Ma sono anche il luogo della contraddizione,quindi del conflitto e della rivendicazione che eccedono e contrastano la logica della norma e del diritto (Harvey 2012). Indagare le periferie torinesi significa allontanarsi dalle piazze dai nomi altisonanti, dai viali alberati e dalle rive del Po per addentrarsi in mondi che conservano storie e ne producono, costantemente, altre che danno senso e forma alla città e alla comunità che la abita, ma anche che mostrano modi altri di significare lo spazio urbano e i linguaggi della città.
Le periferie offrono l’occasione di cogliere all’interno delle narrative e degli spazi della «città panorama» i passi, le memorie, i nomi e il mutamento costante della sua controparte «abitata» (De Certeau, 1980). Mutamento, spazio, nomi: la memoria va ricercata nel cuore del centro urbano dove inciampa nelle traiettorie che conducono alle periferie attraverso documenti e indizi di vario genere custoditi negli spazi del centro, come in quelli dei margini. Se le mappe i documenti conservati nell’Archivio Storico della città di Torino sono utili nel far luce sul procedere dell’occupazione dello spazio e del mutamento delle sue funzioni e della sua natura dall’epoca romana ad oggi, altri archivi aprono squarci sulle memorie “altre” che da tempi non sospetti connettono la città con l’Oriente (Said 1978), con spazi “altri” per definizione. I fondi della Biblioteca Reale (Triulzi 1989), le collezioni etnografiche di Palazzo Madama, del Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino, dell’Istituto Missioni Consolata, del Museo delle Arti Orientali, così come gli archivi del Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso, costituiscono un archivio diffuso in città in cui risiede la memoria di un interesse per l’alterità, e per l’Africa in particolare, che ha caratterizzato Torino sin dai primissimi entusiasmi coloniali della seconda metà del XIX secolo. Ma non solo archivi e musei. In epoca crispina e, poi, giolittiana fino ai primi anni del governo fascista, Torino è alla ricerca di un nuovo ruolo nazionale dopo il trasferimento della capitale. La città si propone come capitale dell’innovazione attraverso le esposizioni, spazi e luoghi rappresentativi della società torinese in trasformazione. Vero e proprio rituale commemorativo, le esposizioni svolgono un ruolo di collante e di recupero della memoria per la comunità cittadina (e nazionale). Tra il 1884 e il 1928 “esposizioni” di vario genere celebrano le invenzioni scientifiche e il mito dell’Italia moderna attraverso la messa in scena delle civiltà. In questi eventi, l’Africa e la colonia costituiscono un nucleo essenziale della rappresentazione tanto delle retoriche politiche quanto della politica commerciale e coloniale del Paese. Mentre la città cresce e sposta sempre un po’ più in là i propri confini, in centro viene “fondata” la memoria del rapporto di Torino con la colonia che oggi ritroviamo, viva ma nascosta e silenziosa, nei quartieri periferici e che rivive tanto nei nomi delle vie, quanto nelle traiettorie che ha portato nuovi torinesi ad abitarle.

Divisa in ventitré quartieri e otto circoscrizioni, Torino si sviluppa secondo spazi delimitati dai grandi viali e dal fiume Po. Guardando la mappa cartografica della città si nota come monumenti e grandi piazze polarizzano lo spazio urbano. Lo sguardo dell’osservatore viene condotto verso il centro, lasciando i quartieri periferici ai margini dell’immagine classica della città. Se i monumenti, le piazze e i grandi viali risultano essere i luoghi topici della memoria storica della città, i reticoli di vie che riempiono gli spazi tra questi veri e propri poli conservano anch’essi tracce indelebili della storia sociale di Torino. La divisione in quartieri avvenne nell’Ottocento secondo una logica geometrica che non seguiva quella, forse più immediata, che identificava e distingueva gli spazi della città tra quelli all’interno e all’esterno delle mura, creando una gerarchia netta tra il centro città e le sue periferie. A una divisione in vere e proprie fette, gli spazi urbani furono oggetto, nel 1858, di una rivisitazione della numerazione. L’operazione di “riordino” delle vie urbane procedette dal centro, identificato in piazza Castello, verso l’esterno e divise la città in quattro grandi compartimenti secondo le quattro grandi arterie che partono dalla piazza più centrale.
Ma si dovettero aspettare gli anni Cinquanta e il boom economico per assistere a processi di occupazione e ri-semantizazione consistente di spazi che videro mutare la propria natura, la propria funzione e le pratiche e i discorsi di cui erano – e sono – oggetto. La collina oltre il Po divenne allora area residenziale, mentre l’aperta campagna che circondava Torino fu investita sia dallo sviluppo industriale sia dalla parola d’ordine dell’epoca: “costruire”. Corso Francia fu una delle direttive principali su cui la città oltrepassò le antiche mura e crebbe verso occidente, prendendo il posto dei campi e dei cascinali di memoria medioevale. La “strada di Francia”, sin dalla sua creazione per editto regio nel 1711 fu palcoscenico dello sviluppo commerciale e industriale del capoluogo torinese e asse viario fondamentale che connette Porta Susa e, immettendosi nella via Dora Grossa (oggi via Garibaldi), piazza Castello, con le periferie occidentali. Dall’apertura della metropolitana, il corso è percorribile anche sottoterra e una delle ultime fermate prima del capolinea è il motivo per cui la ricerca riguardo memoria coloniale conduce ai quartieri periferici in questa parte della città.
Rivoli, Montegrappa, Pozzo Strada, Massaua, Marche, Paradiso: le sei stazioni della metropolitana di corso Francia presentano un’unica, evidente e indelebile, sbavatura. Piazza Massaua è come un nome mal pronunciato nella toponomastica torinese. Si confonde con via Cardinal Massaia, si chiude con un dittongo a cui non siamo abituati. Come per piazza Bengasi, l’accento è ambiguo e, come per piazza Stampalia, il suono lascia interdetti. Poco lontane da piazza Massaua, alcune vie portano altri nomi che connettono gli spazi urbani a suoni e memorie lontani: via Mogadiscio, via Cirenaica, via Eritrea. Nominare oggetti e luoghi è sicuramente parte del processo del ‘faire la ville’. La toponomastica della città è una cartina al tornasole delle memorie nascoste o esplicitate che riecheggiano nei percorsi urbani. I nomi dei luoghi, spesso mutati nel tempo, guidano l’osservatore attento come i sassolini di Pollicino connettendo la memoria cittadina a quella della nazione nell’oltremare e lasciando meno obliati alcuni dei loro frammenti.
Come è facile prevedere, i toponimi torinesi fanno riferimento in massima parte a figure al passato risorgimentale e alla casata reale dei Savoia, seguono artisti, santi e personaggi storici italiani e non. Molti i nomi di partigiani e martiri della Resistenza, segno che nel secondo dopoguerra è avvenuto un ripensamento dei modelli di riferimento nella costruzione dell’identità nazionale che ha avuto espressione anche nelle nuove dedicazioni degli spazi della città.
Presumendo la dimensione profondamente relazionale e sociale dello spazio urbano, è intuibile che la toponomastica conservi e celi tracce della memoria e delle relazioni che hanno abitato lo spazio “nominato” e praticato dagli abitanti della città. Secondo questa prospettiva, l’elenco viario torinese appare essere un archivio di memorie conservate, stratificate e spesso obliate
La storia coloniale italiana trova, a dire il vero, poco spazio nella toponomastica torinese dei giorni nostri. Ma alcune tracce dell’entusiasmo coloniale ottocentesco, prima, e del ventennio fascista, dopo, ancora rimangono nei nomi dati ai luoghi della città. Piazza Massaua e piazza Bengasi, così come via Tripoli o via Mogadiscio, sono alcuni esempi della memoria coloniale conservata nello spazio urbano.
Riferimenti bibliografici
Agier M., 2015, Anthropologie de la ville, Presses Universitaires de France, Paris.
Chambers, I., 1985, Urban Rhythms: Pop Music and Popular Culture, Macmillan, London.
De Boeck, F., 2015, «“Divining” the City: Rhythm, Amalgamation and Knotting as Forms of Urbanity», Social Dynamics. A Journal of African Studies, 41:1.
De Certeau, M., 1980, L’invention du quotidiane. I Arts de faire, UGE, Paris.
Harvey, D., 2012, Rebel Cities. From the Right to the City to the Urban Revolution, Verso, London – New York.
Lefevbre, H., 1967, Le Droit à la ville, Seuil, Paris.
Said, E. 1978, Orientalism, Penguin, New York.
Triulzi, A., (a cura di), 1989, L’Africa dall’immaginario alle immagini: scritti e immagini dell’Africa nei fondi della Biblioteca Reale, Torino.
La Storia dovrà tener conto dei poveri d’America

Quello che segue è un estratto del primo dei due discorsi pronunciati da Ernesto Che Guevara nella nona sessione dell’Assemblea Generale dell’ONU l’11 dicembre 1964. Il comandante argentino partecipa all’assemblea in qualità di ministro dell’Industria di Cuba – carica che ricopre dal 1961 – e approfitta dell’occasione per mettere sul tavolo la questione dei gravi squilibri che minano l’ordine internazionale che le stesse Nazioni Unite puntano a consolidare.
Senza fare sconti e senza giri di parole, Che Guevara punta il dito contro gli Stati Uniti, accusandoli di operare solo nel proprio interesse di potenza imperialista e di violare senza remore l’autodeterminazione e la libertà delle nazioni che non hanno i mezzi economici per competere allo stesso livello.
In chiusura, Guevara declama davanti alle Nazioni Unite la Seconda dichiarazione dell’Avana, che fu letta per la prima volta da Fidel Castro il 2 febbraio 1962 in un comizio pubblico nella capitale cubana, chiamando a raccolta le forze dell’America Latina per l’affermazione dei propri diritti e la liberazione da ogni forma di sfruttamento.

Discorso di Ernesto Che Guevara contro il colonialismo e per il risveglio dell’America Latina, 1964
Signor presidente, signori delegati,
[…]
Cuba viene ad esporre la sua posizione sui punti più importanti di controversia e lo farà con tutto il senso di responsabilità che comporta il far uso di questa tribuna, ma al tempo stesso rispondendo al dovere imprescindibile di parlare con piena franchezza e chiarezza.
Esprimiamo il desiderio di vedere questa Assemblea mettersi alacremente al lavoro e andare avanti; vorremmo che le Commissioni iniziassero il loro lavoro senza doversi arrestare al primo confronto. L’imperialismo vuole trasformare questa riunione in un vano agone oratorio, e non vuole che vengano risolti i gravi problemi del mondo; dobbiamo impedirlo. Questa Assemblea non dovrebbe essere ricordata in futuro soltanto per il numero XIX che la contraddistingue. Al raggiungimento di questo fine sono tesi i nostri sforzi.
[…]
Vogliamo chiarire, ancora una volta, che la nostra preoccupazione per l’America latina è ispirata dai legami che ci uniscono: la lingua che parliamo, la cultura che alimentiamo, il padrone che abbiamo avuto in comune. Che non siamo animati da nessun’altra ragione per desiderare la liberazione dell’America latina dal giogo coloniale nordamericano. Se qualcuno dei paesi latinoamericani qui presenti decidesse di ristabilire le relazioni con Cuba, noi saremmo disposti a farlo sulla base dell’uguaglianza e non in base al criterio che sia un dono fatto al nostro Governo il riconoscere Cuba come un paese libero del mondo; poiché questo riconoscimento lo abbiamo conquistato con il nostro sangue nei giorni della lotta di liberazione, lo abbiamo conquistato col sangue nella difesa delle nostre spiagge dall’invasione yankee.
Anche se respingiamo la pretesa volontà di ingerenza negli affari interni degli altri paesi che ci viene attribuita, non possiamo negare la nostra simpatia verso i popoli che lottano per la propria liberazione e dobbiamo onorare l’impegno del nostro governo e del nostro popolo di esprimere apertamente al mondo intero il nostro appoggio morale e la nostra solidarietà con i popoli che lottano in qualsiasi parte del mondo per rendere reali i diritti di piena sovranità proclamati dalla Carta delle Nazioni Unite.
Cuba, signori delegati, libera e sovrana, senza catene che la leghino a nessuno, senza investimenti stranieri nel suo territorio, senza proconsoli che orientino la sua politica, può parlare a fronte alta in questa Assemblea e dimostrare la giustezza della frase: “Territorio Libero di America” con cui è stata battezzata.
[…]
E se il nemico non è piccolo neppure la nostra forza è disprezzabile, poiché i popoli non sono isolati. Come afferma la Seconda Dichiarazione dell’Avana:
[…]
Nessun popolo dell’America latina è debole, perché fa parte di una famiglia di duecento milioni di fratelli che soffrono le stesse miserie, sono animati dagli stessi sentimenti, hanno lo stesso nemico, aspirano tutti ad uno stesso destino migliore e godono della solidarietà di tutti gli uomini e le donne del mondo.
Questa epopea che sta davanti a noi la scriveranno le masse affamate degli indios, dei contadini senza terra, degli operai sfruttati; la scriveranno le masse progressiste, gli intellettuali onesti e brillanti che sono così abbondanti nelle nostre sofferenti terre d’America latina. Lotta di masse e di idee, epopea che sarà portata avanti dai nostri popoli maltrattati e disprezzati dall’imperialismo, i nostri popoli sconosciuti fino ad oggi, che già cominciano a non farlo più dormire. Ci considerava come un gregge impotente e sottomesso e già comincia ad aver timore di questo gregge, gregge gigante di duecento milioni di latinoamericani nei quali il capitalismo monopolistico yankee vede già i suoi affossatori.
L’ora della sua rivincita, l’ora che essa stessa si è scelta, viene indicata con precisione da un estremo all’altro del continente. Ora questa massa anonima, questa America di colore, scura, taciturna, che canta in tutto il continente con la stessa tristezza e disinganno; ora questa massa è quella che comincia ad entrare definitivamente nella sua storia, comincia a scriverla col suo sangue, comincia a soffrirla e a morire; perché ora per le campagne e per i monti d’America, per le balze delle sue terre, per i suoi piani e le sue foreste, fra la solitudine o il traffico delle città, lungo le coste dei grandi oceani e le rive dei fiumi comincia a scuotersi questo mondo ricco di cuori ardenti, pieni di desiderio di morire per “quello che è suo”, di conquistare i suoi diritti irrisi per quasi cinquecento anni da questo o da quello. Ora sì la storia dovrà prendere in considerazione i poveri d’America, gli sfruttati e i vilipesi, che hanno deciso di cominciare a scrivere essi stessi, per sempre, la propria storia”.
Guarda il video del discorso di Ernesto Che Guevara all’Assemblea Generale dell’ONU l’11 dicembre 1964:
durata: 6:20 min.