Sviluppo
Capitolo 10
L’umanità ha la capacità di rendere lo sviluppo sostenibile per fare in modo che incontri i bisogni del presente senza compromettere l’abilità delle future generazioni di soddisfare i propri desideri.
World Commission on Environment and Development,
Our Common future, 1987
Il processo di sviluppo prende avvio con la rivoluzione industriale inglese quando, per la prima volta, il ritmo di crescita dell’economia diventa superiore a quello della popolazione. Tuttavia, data la semplicità delle innovazioni della prima rivoluzione industriale, occorre attendere la parte finale del XIX secolo per assistere a uno sviluppo senza precedenti. Sarà poi la transizione demografica, che interessa i paesi occidentali nel corso del XX secolo, a consentire anche un grande miglioramento delle condizioni di vita perché, contenendo l’incremento della popolazione, comporta un aumento spettacolare del Pil pro capite.
Crescita\Sostenibilità
Questa crescita apparentemente illimitata ha però un impatto negativo sempre più evidente sui fragili equilibri dell’ecosistema globale, sia in termini di consumo delle risorse, che in termini di inquinamento, fino a produrre cambiamenti climatici su scala mondiale. Nella parte più sviluppata del pianeta, quella che per prima è approdata al benessere e alla ricchezza, inizia a manifestarsi, in particolare a partire dal secondo dopoguerra, un crescente interesse per la questione ambientale e la necessità di perseguire maggiore sostenibilità nei modelli di sviluppo economico in modo da consegnare alle generazioni future un pianeta che possa ancora garantire una vita degna e un equo accesso alle risorse.
Immaginare il futuro
Il futuro della vita sulla terra per la specie umana ci impone di interrogarci sui limiti e sulle prospettive del nostro sviluppo. Quale sviluppo è possibile per tenere insieme ecosostenibilità, miglioramento delle condizioni di vita, giustizia sociale, inclusione e convivenza?
Guarda la photogallery
D. H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers, W. W. Behrens III, I limiti dello sviluppo. Rapporto del System Dynamics Group Massachussets Institute of Technology (MIT) per il progetto del Club di Roma sui dilemmi dell’umanità, Milano, Mondadori, 1972, p. 74.
“Se c’è abbondanza di terre vergini coltivabili, si può avere una popolazione più numerosa e insieme più alimenti per ogni abitante; ma quando tutta la Terra sia ormai sottoposta a sfruttamento, occorre scegliere tra le due alternative, delle quali l’una esclude l’altra. In generale, si può dire che la società moderna non ha ancora imparato a riconoscere la necessità di simili scelte. A quanto sembra, il sistema mondiale attualmente tende a far crescere tanto il numero di abitanti quanto la disponibilità di cibo, di beni materiali, di aria e acqua pulita per ciascuno di essi; ma, per quanto abbiamo osservato, questa tendenza alla fine porterà a raggiungere uno dei molti limiti naturali della Terra”.
2. W. Brandt, Relazione inaugurale, in W. Brandt, B. Craxi, F. Gonzales, C. A. Perez, L. S. Senghor, Disuguaglianze nel mondo, Milano, Sugarco, 1977.
“L’umanità è però minacciata – lo sappiamo tutti – non solo dalla guerra e dai mezzi di distruzione. Fin quando tante centinaia di milioni di persone soffriranno la fame non si può parlare di pace. Un miliardo e 200 milioni di persone vegetano oggi con un reddito di meno di 200 dollari l’anno. Uno dei maggiori esperti ha paragonato di recente le condizioni di vita nei Paesi sviluppati e in quelli più poveri: la mortalità infantile in questi ultimi è otto volte più alta, la speranza di vita un terzo più bassa, il tasso di analfabetismo del 60% più alto. Il livello di alimentazione è sotto il minimo accettabile per metà della popolazione, e milioni di bambini dispongono di proteine in numero insufficiente per lo sviluppo del cervello”.
3. Risoluzione della Confederazione generale italiana del lavoro sul disastro del Vajont, Belluno, 12 ottobre 1963, in Libro bianco sulla tragedia del Vajont. Prima documentazione presentata dalla delegazione parlamentare del PCI al Presidente della Repubblica, Antonio Segni, Belluno, 13 ottobre 1963.
“La delegazione e i dirigenti sindacali esprimono in primo luogo il loro commosso estremo saluto alle vittime e il loro profondo cordoglio alle famiglie e confermano quanto già dichiarato dall’esecutivo della C.G.I.L. circa la disponibilità di tutta la organizzazione dei lavoratori ad essa aderenti in unità a tutte le altre forze per le opere di solidarietà e sostegno. Denunciano le gravi responsabilità della SADE per avere portato a termine l’opera senza tenere conto delle indispensabili garanzie per le popolazioni: gli obiettivi di massimo profitto perseguiti dal monopolio ancora una volta sono stati tragicamente determinanti. Due elementi inconfutabili dimostrano questa terribile verità:
1) La SADE non ha tenuto in nessun contro la denuncia di non idoneità del terreno venuta da parte di eminenti geologi, da amministratori locali, dai partiti, dalle organizzazioni sindacali, dai parlamentari, dalla stampa e dalla popolazione tutta, fino all’inizio dell’opera;
2) La SADE non ha tenuto in nessun conto i segni premonitori che prima e durante le
operazioni di invaso e successivamente si sono manifestati sempre più fitti ed evidenti, sotto forma di smottamenti e di frane di proporzioni sempre più vaste.
Approfondimento
Alla ricerca di un modello di sviluppo per il Paese. Appunti in margine al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Alternative di sostenibilità tra economia, ecologia, società
Sostenibilità \ Sostenibilità ambientale e pandemia
Agricoltura, accesso alle risorse e lavoro: un nesso imprescindibile per lo sviluppo sostenibile
Alla ricerca di un modello di sviluppo per il Paese. Appunti in margine al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

La dimensione del piano europeo è certamente significativa, per quanto arrivi tardivamente e sia macchinoso nell’applicazione. Le risorse complessivamente messe a disposizione dall’UE al nostro Paese ammontano a 191,5 miliardi di euro dal RRF, più 13 miliardi di euro provenienti nel quadro del programma React-EU, disponibili sul biennio 2021-2022. A integrazione è stato previsto un fondo complementare dell’ammontare di circa 30,64 miliardi a valere su risorse nazionali.
Il piano italiano, in accordo con le linee guida della Commissione Europea, si articola in sedici componenti, raggruppate in sei missioni: (1) digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; (2) rivoluzione verde e transizione ecologica; (3) infrastrutture per una mobilità sostenibile; (4) istruzione e ricerca; (5) coesione e inclusione; (6) salute.
Tra queste sei missioni, la parte del leone la fanno la prima e la seconda, che contano rispettivamente 50,07 e 69,6 miliardi. L’impatto atteso delle misure è di 3,6 punti percentuali di PIL in più nel 2026 rispetto allo scenario base, cioè senza intervento alcuno; i primi benefici, trainati soprattutto dallo stimolo alla domanda aggregata (per quanto i moltiplicatori dell’effetto di domanda siano stati stimati molto bassi), si avranno già nel 2021 e nel 2022, mentre i pieni effetti degli investimenti non si registreranno che a partire dal 2023.
La prima missione intende promuovere la trasformazione digitale del sistema produttivo, con particolare attenzione ai settori del turismo e della cultura, cui sono dedicati otto miliardi, ma anche a quei settori di frontiera come la Space Economy. La seconda missione, quella di gran lunga preponderante come dotazione, vuole affrontare la transizione ecologica, favorendo la sostenibilità del sistema economico al cambiamento climatico: riserva molte risorse all’economia circolare, al ciclo di gestione dei rifiuti, alla promozione delle energie rinnovabili, al rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico. Lo sforzo infrastrutturale, incardinato nella terza missione, si sostanzia perlopiù in investimenti nella mobilità ferroviaria. Per quanto riguarda la quarta missione, i fondi allocati sono concentrati sul trasferimento tecnologico e nel favorire partenariati tra le imprese e il sistema universitario. Quanto ai fondi di coesione sociale, l’obiettivo è quello di estendere la partecipazione al mercato del lavoro; ampio spazio è riservato anche alla rigenerazione urbana e al rafforzamento dei servizi sociali. Da ultimo, per quanto concerne il comparto salute, l’intenzione è rafforzare i servizi sanitari sul territorio e la ricerca biomedica.
È utile analizzare le varie voci di investimento previste dal Piano elaborato dal Governo Draghi in chiave comparativa, confrontandolo con il piano del Governo Conte, per rilevare sia il dettaglio di alcune misure, sia per capire l’impronta data dal nuovo Esecutivo. Ora, il capitolo sulle infrastrutture è stato quello maggiormente penalizzato, sia in termini relativi che in termini assoluti. Assume particolare rilievo la compressione dell’investimento nel trasporto ferroviario regionale, che dai 2,67 miliardi d’investimento previsti dal precedente esecutivo conta ora solo 0,94 miliardi. Inoltre, laddove il Governo Conte aveva incluso nel Piano 3,32 miliardi nel progetto di finanziamento dei porti italiani, investendo sia sugli scali di Trieste e Genova che sulla logistica integrata di altri scali minori, il piano attuale non prevede alcuna dotazione per il comparto. I porti sono peraltro oggetto di un ulteriore indirizzo di riforma: nel nome della concorrenza si vuole flessibilizzare alcune regole sul movimento merci negli scali, a vantaggio di alcuni grandi armatori e a danno della sicurezza e dei diritti dei portuali, come denunciato fin da subito dalle organizzazioni sindacali di categoria.
All’interno delle prime due missioni, una quota consistente di fondi è stata riallocata dall’efficientamento energetico degli edifici al capitolo sulla mobilità sostenibile. In questo contesto, emerge un’attenzione particolare all’idrogeno: laddove il Governo Conte aveva previsto di investire 8,66 miliardi nella filiera delle rinnovabili, il Governo Draghi ne alloca solo 5,90, potenziando invece l’investimento sulle infrastrutture di rete e sulla mobilità locale sostenibile, e prevedendo, per l’appunto, 3,19 miliardi per l’idrogenizzazione del trasporto e dei settori hard-to-abate. Da ultimo, la componente d’investimento nella digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA vede una riduzione della propria dotazione sia in termini relativi che assoluti.
Agli investimenti su questi sei assi principali si affiancano alcune riforme strutturali, vera e significativa novità rispetto al piano delineato dal Governo Conte. Ad essere interessate saranno la Pubblica Amministrazione e la giustizia civile e penale, ma il Piano prevede altresì una serie di riforme chiamate “abilitanti”, misure di semplificazione legislativa e di promozione della concorrenza. Queste riforme, chieste con particolare energia da Bruxelles a titolo di contropartita e accompagnamento del finanziamento offerto nel quadro del PNRR, non rappresentano nulla di inedito.
Con una non piccola dose di autocritica nei confronti delle politiche pubbliche che hanno improntato i due decenni passati, il testo riconosce quanto il mancato ricambio negli uffici pubblici abbia impedito significativamente l’azione dell’amministrazione centrale e degli enti locali, sia per via del sempre minor numero di dipendenti pubblici, sia per l’appalesarsi di sempre più significativi vincoli anagrafici e formativi. A questa lettura non segue però un piano di assunzioni nel pubblico, ma si prevede invece una riforma della PA che va a toccare le forme di accesso al pubblico impiego (rivedendo la disciplina concorsuale) e prevedendo la possibilità – inedita e preoccupante – di concludere contratti a tempo determinato per sostenere sforzi temporanei delle varie amministrazioni, come con l’attuazione del PNRR stesso. Quanto alla promozione della concorrenza, il Governo prevede l’adozione annuale di una legge per il mercato e la concorrenza, auspicando la riduzione o rimozione di barriere all’entrata nei vari mercati e favorendo la deregolamentazione di determinati settori. Particolare rilievo assume, in questo contesto, la revisione della disciplina dell’ in-house providing dei servizi pubblici: l’intento dell’Esecutivo è quello di limitare il ricorso a fornitori di servizi internamente alle amministrazioni stesse, chiedendo conto in modo stringente delle ragioni per cui si è preferito non ricorrere al mercato, con particolare attenzione al settore del trasporto pubblico locale.
Il Piano è stato accolto con toni messianici. In questo gran disegno si vede il futuro del Paese, liberato da molti dei suoi limiti strutturali e, perché no, antropologici, chiave per modernizzare l’Italia. Dietro ai colori pastello delle infografiche, però, questa modernizzazione ha qualcosa di stantio. La dimensione del Piano è certamente significativa – anche se stiamo ragionando sui lordi dei trasferimenti europei e su di un orizzonte di sei anni, quindi di circa 36 miliardi all’anno – e prevede risorse fresche per un Paese in cui gli investimenti pubblici sono da anni alla canna del gas. Tuttavia, a questa benvenuta iniezione di risorse non si accompagna un rinnovamento del modo in cui viene pensata la politica economica. Tutto l’impianto del Piano è volto a potenziare l’efficienza dal lato dell’offerta, a snellire, sburocratizzare, razionalizzare la presenza pubblica nei mercati, a favorire la concorrenza e la gestione privata dei servizi pubblici.
La pianificazione in Italia ha una storia gloriosa. È con i piani che il nostro Paese ha potuto risollevarsi nel Dopoguerra e agganciare una traiettoria di sviluppo economico, ma soprattutto sociale e umano. Non rinchiusi in un recinto economicistico o di contabilità pubblica, la portata di quei disegni si trovava nella capacità di tenere insieme il ruolo democratico delle Università, la presenza pubblica diretta nei settori strategici e nel credito, l’iniziativa privata nella società e nell’impegno produttivo. Tra i tanti programmi e progetti del Piano vi sono ottime idee così come alcune criticità, come abbiamo avuto modo di rilevare. Manca tuttavia di un disegno organico e sconta la difficoltà – ormai trentennale – di elaborare un modello di sviluppo originale per il nostro Paese, che non sia una copia non mediata e meditata di quanto fanno i tedeschi, i francesi o gli americani. A queste domande l’esercizio del Piano avrebbe potuto forse iniziare a dare risposte.
Alternative di sostenibilità tra economia, ecologia, società

Partecipanti
Alberto Majocchi (Università degli Studi di Pavia), Lorenzo Sacconi (Università degli Studi di Milano), Sabina Ratti (Alleanza per o Sviluppo Sostenibile), Luca Carra (giornalista, Scienze in Rete), Nicolò Giangrande (Università degli Studi di Salerno), Niccolò Donati (Università degli Studi di Milano), Massimo Amato (Università Bocconi), Marina Trentin (Fondazione Feltrinelli)
1. Confini strutturali
1.1 Globalizzazione, disparità e impatto ambientale
Il processo di globalizzazione è stato promosso principalmente dagli sviluppi tecnologici nei settori dell’informatica e dei trasporti ed è stato sostenuto da una larga diffusione delle tecnologie mature, che ha consentito ai sistemi economici dotati di una sovrabbondante offerta di manodopera di diventare competitivi anche nella produzione industriale. In questo modo la globalizzazione ha permesso a molti Paesi di avviare un processo accelerato di sviluppo economico. Tuttavia, la diffusione della tecnologia non sarebbe stata in grado di sostenere da sola l’avvio dello sviluppo economico senza un’adeguata disponibilità di capitali, messa a disposizione dalla liberalizzazione del mercato, spostando enormi flussi di risorse da aree caratterizzate da un eccesso di risparmio rispetto agli investimenti verso quelle capaci di assorbire tale surplus. Questo ha consentito di finanziare il livello crescente di investimenti necessario per sostenere il decollo della produzione industriale.

Quali sono le conseguenze del decollo industriale nei Paesi in via di sviluppo? Ne parla Alberto Majocchi.
A partire da questa prima introduzione, Alberto Majocchi, professore di Scienza delle Finanze all’Università degli studi di Pavia, prosegue illustrando come la crescita della produzione industriale nei Paesi in Via di Sviluppo sia riuscita a trovare degli sbocchi adeguati grazie all’apertura dei mercati sostenuta dalla progressiva caduta degli ostacoli al commercio internazionale, promossa dai rounds di negoziati commerciali che si sono succeduti nell’ambito dell’Accordo Generale sulle Tariffe Doganali e il Commercio (GATT). In questo modo si è avviata la redistribuzione delle attività produttive, con una specializzazione dei Paesi in Via di Sviluppo nelle produzioni più tradizionali, mentre le economie più avanzate mantengono il controllo dei mercati nei settori più innovativi.
Una volta riconosciuti questi effetti positivi derivati per tutti i Paesi – inclusi quelli in Via di Sviluppo – da una progressiva liberalizzazione del commercio internazionale, occorre tuttavia prendere in considerazione anche i problemi legati alla crescente integrazione dell’economia mondiale dal punto di vista dell’ambiente e della stabilità dei sistemi economici e sociali coinvolti nel processo di globalizzazione, continua Majocchi.
La crescita del commercio internazionale produce, infatti, effetti ambientali positivi nelle aree che vengono progressivamente integrate nell’economia mondiale se queste si sono dotate di una buona politica ambientale. Viceversa, in territori sprovvisti di efficaci policy per la tutela dell’ambiente, alla crescita della produzione si accompagna il deterioramento delle condizioni ambientali, non solo a livello locale o regionale ma altresì a livello globale, a causa dell’uso eccessivo delle risorse naturali, dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua, dell’aumento delle quantità di rifiuti prodotti e in particolare a causa della crescita incontrollata delle emissioni di CO2, che ha reso drammatico il rischio di cambiamenti climatici.
È il caso ad, esempio, di ciò che si sta verificando nei territori dell’Amazzonia, in cui, secondo i dati forniti da Greenpeace , il tasso di deforestazione è aumentato del 30% nell’ultimo anno e, tra agosto 2018 e luglio 2019, ha raggiunto il suo picco più alto registrato dal 2008.
Quando si parla di cambiamenti climatici è fondamentale tenere presente che la complessità del quadro di riferimento non ci permette di prescindere da ragionamenti su scale spaziali e cronologiche multiple. Si tratta di un rapporto complesso tra scale diverse che è difficile da leggere e interpretare ma di cui è imprescindibile tenere conto.
1.2 Competitività del sistema economico e dominio del PIL
In questo contesto di economia globalizzata, l’obiettivo prioritario della politica economica diventa quello di garantire la competitività di ogni sistema economico. Accade spesso, tuttavia, che per raggiungere tale obiettivo e garantire al contempo una riduzione dei costi, siano sacrificate le politiche del benessere, sociali e ambientali: il rapido progresso del modello di produzione ha allargato le dimensioni dei mercati su scala universale, mentre la politica che ne governa l’evoluzione, e che dovrebbe stabilirne le regole, è ancora limitata in confini più ristretti, regionali o nazionali. In assenza di un governo dell’economia globale è la legge del più forte che si impone.
Su tale questione, si sono espressi sia Majocchi che Lorenzo Sacconi, professore di Politica Economica dell’Università degli Studi di Milano, ponendo l’accento sulla necessità di misurare il benessere non soltanto in termini di prodotto interno lordo, ma tenendo conto di altri indicatori relativi, ad esempio, alle condizioni di salute e vecchiaia della popolazione, alla riduzione dell’inquinamento, alla sicurezza sociale. In quest’ottica risulta evidente come il benessere generale possa aumentare senza essere necessariamente legato ad una crescita del prodotto interno lordo, disaccoppiando gli indicatori economici dagli indicatori di sviluppo.
L’ardua sfida della politica economica diventa dunque quella di favorire da una parte la competitività della produzione attraverso la crescita della disponibilità di beni e servizi e, dall’altra, di garantire al contempo il miglioramento del grado di protezione sociale e delle condizioni ambientali per l’insieme della popolazione. Per raggiungere questo obiettivo diventa fondamentale ispirarsi ad un modello di sviluppo che sia sostenibile, ovvero, rifacendosi alla definizione proposta nel 1987 dalla Commissione mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo dell’ONU, un modello di sviluppo in grado di soddisfare le necessità delle attuali generazioni senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare le proprie.
2. Risposte possibili
2.1 La necessità di un approccio multilivello
Per raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dai 193 Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015, è necessario affrontare la questione in modo globale attraverso un approccio multilivello, come suggerisce Niccolò Donati, ricercatore dell’Università degli Studi di Milano. Già il Rapporto Brundtland, pubblicato nel 1987 dalla norvegese Gro Harlem Brundtland, allora a capo della Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, introduceva la necessità di affrontare il discorso sull’ambiente e lo sviluppo in ottica integrata: Ambiente e sviluppo non sono realtà separate, ma al contrario presentano una stretta connessione. Lo sviluppo non può infatti sussistere se le risorse ambientali sono in via di deterioramento, così come l’ambiente non può essere protetto se la crescita non considera l’importanza anche economica del fattore ambientale. Si tratta, in breve, di problemi reciprocamente legati in un complesso sistema di causa ed effetto, che non possono essere affrontati separatamente, da singole istituzioni e con politiche frammentarie. Un mondo in cui la povertà sia endemica sarà sempre esposto a catastrofi ecologiche d’altro genere.
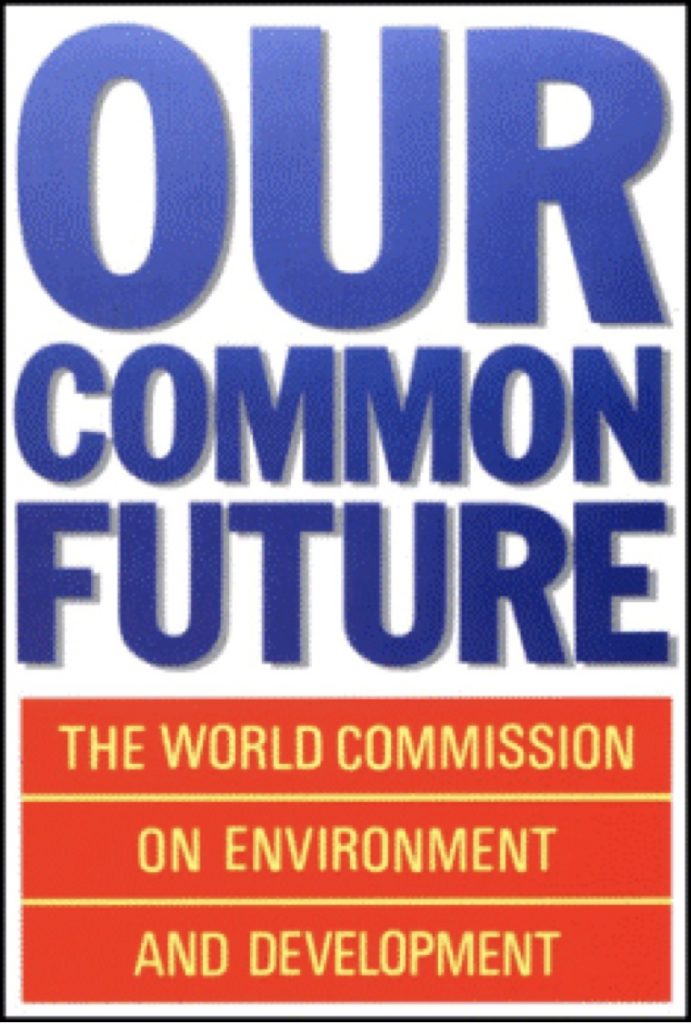
Emerge quindi già nel 1987 quanto sia fondamentale affrontare tali questioni attraverso una governance multilivello che consideri i diversi attori coinvolti. Esempio e applicazione di ciò è l’esperienza portata da Nicolò Giangrande, ricercatore dell’Università degli Studi del Salento, che porta un’esperienza accademica come professore presso la Facoltà dell’Amazzonia Occidentale (FAAO), un’istituzione universitaria brasiliana che si trova a Rio Branco, capitale dello stato dell’Acre. Più nello specifico, la Cátedra Barão do Rio Branco della FAAO ha l’obiettivo di analizzare le sfide e le opportunità dell’Amazzonia nell’attuale quadro di globalizzazione attraverso un programma internazionale composto da un corso dedicato e da una conferenza. Nel 2019 il tema della Cátedra, che si rivolge ad una variegata platea di studenti, è stato proprio lo “Sviluppo Sostenibile in Amazzonia”, affrontato da un punto di vista teorico e pratico.
Oltre a imprese, istituzioni, e al mondo accademico e della ricerca, anche l’arte può svolgere un ruolo importante nelle sfide poste dagli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Ne è un esempio l’impegno dell’artista e attivista francese Philippe Echaroux, che con il progetto The Blood Forest – Street Art 2.0, cerca di dare il suo contributo alla sensibilizzazione riguardo il delicato tema della deforestazione dell’Amazzonia immortalando il volto di alcuni indigeni amazzonici e proiettando questi scatti sugli alberi della foresta. In questo modo permette di comprendere come la vita di questo popolo sia davvero un unicum con ciò che lo circonda: per ogni albero in meno le possibilità che le tribù native possano continuare a vivere lì si fanno più rade.

2.2 Il ruolo del privato
L’esperienza della FAAO evidenzia anche la funzione svolta dal settore privato nella promozione di politiche a favore della sostenibilità, sociale e ambientale.
La conferenza internazionale, che si è svolta il 23 agosto nel teatro della FAAO, si è infatti focalizzata sulla “Condotta d’Impresa Responsabile in Brasile e nella regione amazzonica” e ha rappresentato l’evento di chiusura della Cátedra, vedendo il coinvolgimento di relatori provenienti da enti e livelli di governance differenti. Il confronto ha raccolto rappresentanti dell’Unione Europea, dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), di due ministeri federali brasiliani (Economia e Diritti Umani), di quattro università (FAAO, Brasile; Università del Salento, Italia; Pontificia Università Cattolica del Paraná, Brasile; Università di Monterrey, Messico), e di una organizzazione della società civile (Conectas), oltre che delle massime autorità statali e locali, il Governatore dello Stato dell’Acre e la Sindaca di Rio Branco.
Gli interventi hanno contribuito a delineare un complesso quadro in cui diventa determinante, da un lato, la cooperazione tra università, istituzioni, imprese e società civile e, dall’altro, l’adattamento a scala amazzonica di principi e norme internazionali.
Più in generale, affinché le imprese adottino sempre più un impegno verso l’attore pubblico in ottica di sostenibilità, è fondamentale che siano consapevoli dei vantaggi in termini di competitività derivanti dal suo perseguimento. Come afferma Massimo Amato, professore dell’Università Bocconi, è necessario ripensare il rapporto tra pubblico e privato perché le imprese siano mosse da un commitment pubblico. È ciò che sostiene anche Lorenzo Sacconi, il quale ribadisce che l’impresa non può perseguire la responsabilità sociale solo per un beneficio che abbia effetto sulla reputazione: è necessario modificarne il purpose. Come sostengono Porter e Van der Linde[1], una stringente regolamentazione ambientale può indurre le imprese ad una maggiore efficienza, nonché a stimolare ed incoraggiare l’innovazione, che a sua volta contribuisce ad aumentare ulteriormente la competitività.

Il passaggio a fonti di energia sostenibili comporta due livelli di costo: quello di adeguamento alla nuova regolamentazione e quello di introduzione dell’innovazione.
Gli autori affermano che i costi risparmiati grazie all’adozione di nuove tecnologie sono più che sufficienti a compensare sia i costi cosiddetti “di compliance”, ovvero di adeguamento alla regolamentazione, sia quelli necessari all’introduzione dell’innovazione. In quest’ottica una regolamentazione adeguata fornisce segnali chiari alle imprese, utili a ridurre o eliminare le inefficienze nello sfruttamento delle risorse, nonché alla possibilità di ridurre l’incertezza degli investimenti ambientali. Inoltre, può stimolare una maggiore coscienza, nei soggetti pubblici e nei cittadini privati, della necessità di migliorare il contesto ambientale, stimolando così la nascita di una domanda specifica rispetto a beni e servizi ambientali.
Un interessante esempio di intervento da parte del privato nel processo di valorizzazione di beni comuni è quello del Bosco in Città, citato da Luigi Carra, giornalista direttore di Scienzainrete. Negli anni ‘70 il Comune di Milano, con i sindaci Aniasi e Tonioli, fece la scommessa di creare un’estesa area che mobilitasse il volontariato partendo dal privato sociale. Si tratta di un’esperienza di successo in cui il privato, incaricandosi dell’esternalizzazione della gestione di un ampio spazio di verde pubblico, ha espresso livelli non solo di efficienza ed economicità, ma anche di efficacia nel costruire un verde urbano di qualità a servizio dei cittadini e del loro benessere. L’esperienza del Bosco in città risulta inoltre esempio di come i cosiddetti “beni pubblici” siano da intendersi come rispondenti non solo agli interessi di tutti, rischiando di essere considerati di nessuno, ma anche a interessi di categorie di stakeholders che usano il valore dei beni comuni per investirci: le abitazioni nei pressi del Bosco in Città, infatti, hanno aumentato considerevolmente il loro valore.
[1] Porter, Michael E., and Claas van der Linde. 1995. “Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship.” Journal of Economic Perspectives, 9 (4): 97-118.
Sostenibilità \ Sostenibilità ambientale e pandemia

Proprio nei mesi immediatamente precedenti allo scoppio della pandemia da COVID19 la sostenibilità ambientale ha progressivamente guadagnato spazio nell’agenda politica internazionale e continentale, divenendo uno dei termini di riferimento degli scenari d’intervento sia degli operatori pubblici, sia del settore privato. Esemplificativo in tal senso il Green Deal lanciato dalla Commissione europea nel dicembre 2019 (COM(2019)640), non come iniziativa settoriale, ma come più ampia “strategia di crescita mirata a trasformare l’UE in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse” (p. 2).
In tale quadro, è lecito chiedersi, se e come tale progressiva assunzione di centralità, ancora peraltro da consolidarsi nei fatti, possa venire influenzata da una fase di crisi sistemica di ampiezza e dimensioni così significative e imprevedibili.
Diverse appaiono le considerazioni e implicazioni possibili, in direzioni peraltro non coincidenti.
In termini preliminari, non può non osservarsi come l’evento Coronavirus mostri evidenti elementi di collegamento con i temi della sostenibilità energetico-ambientale e del rischio climatico. In entrambi i casi si tratta infatti di fenomeni fisico-naturali che, contrariamente, ad esempio, allo shock finanziario del 2007-2008, mettono in discussione in maniera profonda i rapporti tra uomo e natura e la capacità di governare le retroazioni che quest’ultima può ingenerare sui sistemi socio-economici. Mai come in questo momento, ci dovrebbe apparire chiaro come l’innescarsi di azioni o situazioni di rottura negli equilibri ecosistemici possa essere causa di effetti dinamici, non-lineari e potenzialmente cumulativi, per il governo dei quali il, pur importantissimo, stato di avanzamento della ricerca e della scienza possono risultare inadeguati o, comunque, non risolutivi. Tale segnale dovrebbe fungere da monito, a fortiori, per un tema come il cambiamento climatico che presenta caratteri di autoalimentazione e propagazione spaziale e intertemporale, nonché di irreversibilità degli effetti, che rischiano di essere ben maggiori rispetto a quelli manifestati nel caso del contagio da COVID19.
Se ben compresa, la lezione può, in termini generali, attivare una maggiore consapevolezza sui temi del rischio e dell’incertezza, favorendo l’affermarsi di una visione, e di comportamenti concreti, che si caratterizzino per un ampliamento dell’orizzonte temporale e per una capacità di gestione più consapevole, già nel presente, dei fattori di vulnerabilità futura. Tale approccio non potrebbe che giovare alla causa della sostenibilità ambientale, per sua natura connotata da forti elementi di interdipendenza nel tempo e nello spazio.
Un secondo fattore di rinforzo può essere dato dal ruolo delle politiche pubbliche, quasi ovunque rivalutate come strumento fondamentale di correzione dei fallimenti del mercato. La sostenibilità ambientale richiede, proprio come la gestione dei rischi igienico-sanitari, l’intervento di istituzioni che siano in grado, attraverso vari tipi di strumenti (regolamentazione, produzione pubblica, incentivi/disincentivi economici, ricerca di base, educazione e sensibilizzazione), di allineare costi e benefici privati con quelli sociali, tenendo conto anche dei già menzionati riflessi sulle generazioni future. Niente di nuovo, visto che il tema delle esternalità è vecchio quanto i primi contributi in tema di finanza pubblica (Pigou, 1920), ma un rilancio in questa direzione può costituire un importante fattore di svolta per accelerare e sostenere il processo di guida e correzione, sia a livello internazionale, sia statale, sia locale.
In questo periodo pare essersi altresì attivata e/o rivalutata, in maniera per ora forzosa, una serie di comportamenti e scelte (smart-working, attenzione al tempo libero e ai beni relazionali, importanza componenti immateriali del benessere, rilancio della filiera corta, riduzione delle esigenze di spostamento, rilancio dei negozi di vicinato, etc.) che, se consolidati nel tempo, possono contribuire in modo rilevante alla valorizzazione dell’approccio dal basso, di natura etico-comportamentale, alla sostenibilità ambientale. Non solo, quindi, tecnologia e infrastrutture, ma anche stili di vita, scelte consapevoli e responsabili, solidarietà intra e inter-generazionale, parsimonia e attenzione alla qualità come fattori di alimentazione di un circolo virtuoso che, lungi dal rappresentare un ritorno al passato, possa rappresentare una delle chiavi di lettura vincenti del futuro (incerto).
Di contro, l’emergere di priorità pressanti dovute all’emergenza e al forte depauperamento del capitale economico rischiano di allontanare la piena integrazione delle politiche energetico-climatiche nelle scelte degli operatori pubblici e degli agenti economici. Le imprese, in preda a crisi di liquidità e redditività possono essere indotte a ritardare il rinnovo in chiave sostenibile dei propri asset; i consumatori, anche grazie all’abbassamento del costo delle commodities energetiche, possono essere spinti dalla congiuntura a privilegiare scelte energy e environment – intensive; gli stati possono essere spinti a riallocare risorse e attenzioni prioritarie ad altri temi, apparentemente più pressanti. Detto in altri termini, il regresso delle variabili reddituali, se non governato e indirizzato, potrebbe determinare un percorso a ritroso lungo le curve di Kuznets ambientali, con effetti negativi su ambiente e natura.
Non emerge quindi, nel complesso, un responso univoco, ma una serie di forze e possibili influenze reciproche che chiamano in causa in maniera diretta la capacità dei governi, a tutti i livelli, di guidare in maniera selettiva le scelte in questo momento delicato. Se, nell’impianto originario del Green Deal della Commissione, un ruolo determinante nel sostenere la transizione era affidato al settore privato, tale prospettiva pare essere messa in discussione, almeno nel breve-medio periodo, dalla situazione di grave sofferenza a cui necessariamente andrà incontro il mondo delle imprese e dei consumatori, almeno nella prima fase post-emergenza. Il peso della bilancia nel mix pubblico/privato è destinato quindi a pendere in maniera prevalente, almeno nell’innesco dei nuovi percorsi di sviluppo, sulla prima componente. Ecco perché si tratta di un momento cruciale: perché un impegno di risorse pubbliche (o comunque garantite dal pubblico) di dimensioni come quelle attualmente in discussione sarà difficilmente replicabile e andrà ad ipotecare le future possibilità d’intervento per diverso tempo. Se si vuole quindi che obiettivi climatici, energia pulita, economia circolare, efficienza energetica, mobilità sostenibile e la preservazione della natura e della biodiversità (gli assi portanti del Green Deal) possano realmente trovare sostanza e seguito nei prossimi decenni, essi, coerentemente con il principio di integrazione previsto dal TFUE, devono divenire da ora un punto di riferimento orizzontale delle misure di recupero e investimento messe in campo per fa ripartire i sistemi economici.
Agricoltura, accesso alle risorse e lavoro: un nesso imprescindibile per lo sviluppo sostenibile

Nel dibattito sui modelli di sviluppo che ha seguito la conferenza delle Nazioni Unite Rio+20 orientato al tema della sostenibilità, e a partire dall’evidenza raccolta da ricerche che per tale tema propongono interpretazioni e soluzioni, è emerso il nesso tra la trasformazione strutturale di una economia, il ruolo, in questo senso, del settore agricolo e la redistribuzione della forza lavoro tra comparti economici. A questi fattori, poi, si connette anche il fenomeno delle migrazioni tra zone rurali e aree metropolitane.
Il catalizzatore di questa trasformazione strutturale è l’aumento della produttività dei sistemi di produzione agricola di piccola scala: un mutamento, questo, che innesca cambiamenti profondi nelle economie rurali fino a trainare trasformazioni sostanziali di tutto il sistema economico di un paese o di un’area geografica. Specificamente, incrementi nei redditi dei piccoli produttori rurali hanno l’effetto di determinare modelli di consumo e, quindi, di spesa che promuovono la crescita dell’economia rurale non agricola attraverso la creazione di una domanda di mercato relativa a beni di consumo per lo più di provenienza locale. Questo percorso mette in moto un circolo virtuoso in cui l’aumento dei redditi dei piccoli produttori agricoli alimenta lo sviluppo di settori produttivi non strettamente riconducibili al comparto agricolo che possono imprimere crescita e sviluppo a un intero impianto economico. Qui, poi, sono gli strumenti normativi che creano collegamenti e sinergie tra il settore agricolo e, più in generale, il comparto rurale con le aree urbane e peri-urbane a giocare un ruolo fondamentale nel garantire il consolidamento di sistemi funzionali entro i quali esistono opportunità per un’ulteriore crescita del reddito rurale assicurando, al contempo, la disponibilità di cibo a prezzi accessibili e di altri beni di produzione rurale per i quali esiste una domanda ‘urbana’. Quale conseguenza, si osserva che la forza lavoro locale passa gradualmente dall’agricoltura ai settori legati all’industria e dei servizi, alimentando un incremento nei livelli di migrazione verso le aree metropolitane dove tali settori tendono a concentrarsi.
In questo quadro, occorre evidenziare che le dimensioni sociali delle trasformazioni rurali – in particolare, la promozione dell’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne – definiranno le opportunità per quanti si affacceranno al mercato del lavoro. Ad esempio, secondo le tradizionali norme sociali proprie di molte società rurali, differenze di genere nell’accesso alle risorse di cui le famiglie dispongono – in particolare la terra – hanno implicazioni significative nel determinare scelte in materia di occupazione e migrazione tra i giovani. È il caso del nord della Tanzania, dove è consuetudine che le figlie femmine contribuiscano con il lavoro non retribuito alle aziende agricole a conduzione familiare, senza tuttavia avere il diritto a ereditare la terra, motivo per il quale un numero crescente di giovani donne sono attratte dalle possibilità di lavoro nei centri urbani e nelle località turistiche, anche a distanze considerevoli dalle località rurali di provenienza. Al contrario, i giovani, che invece hanno diritti sulla terra sono maggiormente orientati a spostarsi su piccole distanze e per periodi di tempo più brevi, ritornando a casa, spesso, per la stagione agricola.

Trasformazioni rurali nell’Africa sub-sahariana
Gli impatti di questi disequilibri di genere e la misura in cui le disparità che li generano persisteranno nelle società tradizionali in molti paesi dell’Africa sub-sahariana avranno implicazioni sociali ed economiche considerevoli per le comunità rurali nei prossimi decenni, soprattutto alla luce della portata dei numeri che descrivono l’evoluzione del mondo del lavoro in questa area. Qui, infatti, si prevede che nei prossimi quindici anni circa 330 milioni di giovani entreranno nel mondo del lavoro. È stato stimato che 195 milioni di questi vivranno nelle zone rurali insistendo sui mercati locali, quindi, per trovare occupazione. Tali dati sono in linea con il panorama mondiale: i soggetti di età inferiore ai quindici anni oggi rappresentano circa un quarto della popolazione totale dei cosiddetti paesi emergenti. I giovani tra i 15 e i 24 anni, invece, ne costituiscono circa un quinto.
Dato questo contesto, è importante osservare che, a parità di altri fattori, sono i giovani i più propensi a migrare. Questo, oltre a fare presagire sfide di grande rilievo nella previsione che il mercato del lavoro di aree economicamente ancora emergenti debba assorbire milioni di giovani garantendo la disponibilità di occupazione dignitosa, è stato indicato come leva per l’emersione di un dividendo demografico. L’energia e il dinamismo di una popolazione giovane, infatti, può potenzialmente dare un contributo significativo alla creazione e diffusione di innovazione nella produzione, nel marketing e nell’uso delle risorse naturali. Nel momento in cui le risorse umane depositarie di questo potenziale si spostano dalle aree rurali a quelle urbane, ecco che si delinea una perdita per il comparto rurale che, ancora, costituisce il contesto dal quale milioni di persone traggono le risorse per la propria sussistenza.
Sarà quindi sempre più importante garantire che la centralità delle zone rurali nei processi di sviluppo in un’ottica di sostenibilità si rifletta in modo prominente in un modello di sviluppo spazialmente integrato attraverso adeguati processi di pianificazione che sappiano tenere conto dei flussi di risorse, persone e competenze tra aree rurali e urbane. Riconoscere la centralità della trasformazione dell’economia rurale nel determinare un avanzamento strutturale di tutto il comparto economico di un paese passa, inoltre, attraverso lo sviluppo di opportunità per promuovere la mobilità del lavoro.
Un fattore chiave, in questo senso, sarà investire nelle popolazioni rurali: migliorarne le competenze, le conoscenze, promuovere l’uguaglianza di genere, l’empowerment femminile, facilitare l’accesso ai mercati, alle risorse ambientali e finanziarie, specialmente per donne e giovani dato il loro potenziale trasformativo dei contesti sociali di cui sono parte integrante.





