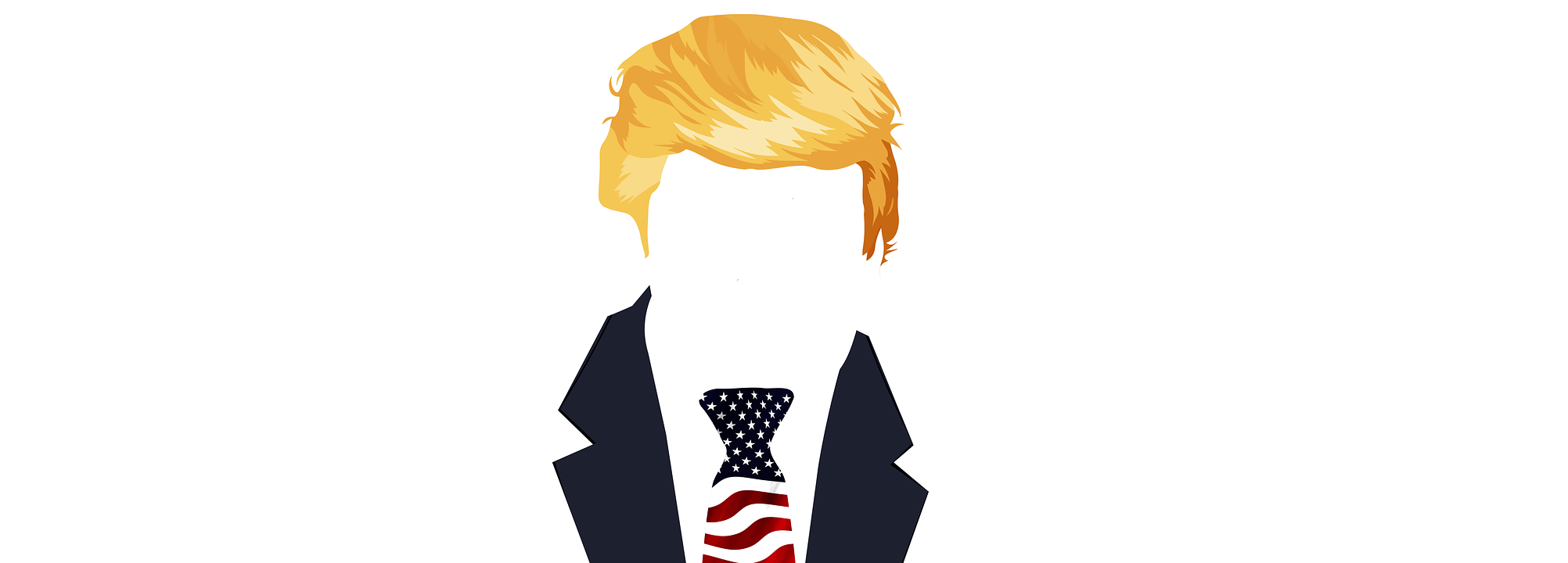La discussione globale sui media degli ultimi anni – o, per essere più precisi, da quando ha vinto Donald Trump – è stata pressoché dominata da due parole: fake news, ossia notizie false.
Il solo nominarle evoca sordidi tentativi di influenzare elezioni, orde di troll russi che manovrano nell’ombra, siti pronti a inondare i social media di bufale, e oscure società di consulenza che manipolano i cittadini a favore dei “populisti”.
Ovunque ci sono le fake news, insomma, la democrazia viene svuotata dal suo interno. O almeno, così viene spiegato qualsiasi grosso evento politico – dalla Brexit fino alla formazione del governo gialloverde in Italia, passando per la vittoria di Jair Bolsonaro in Brasile o l’emergere del movimento dei gilet jaunes in Francia.
Solo che questa narrazione è falsa. È essa stessa una fake news.
Secondo recenti studi e ricerche, poche persone sono state realmente influenzate da questo tipo di contenuti nel corso delle presidenziali del 2016; e il fenomeno è stato ancora meno rilevante durante le elezioni di metà mandato del 2018. Inoltre, il consumo di fake news è concentrato in un piccolo segmento della popolazione americana – quello conservatore di una certa età.
Una ricerca del Reuters Institute for Study of Journalism ha inoltre dimostrato che i cosiddetti siti bufalari sono letti infinitamente di meno delle testate giornalistiche mainstream, e hanno una portata davvero limitata.
Nonostante ciò, sentiamo ripetere ovunque quell’espressione. E sta proprio qui il punto: il principale problema delle fake news ruota intorno all’uso che ne facciamo, e al significato che ha assunto a livello politico e mediatico.
Lo so, lo so. Può sembra un enorme paradosso; ma non lo è affatto. E per capirlo, bisogna partire dalla più basilare delle domande: cos’è una fake news?
Nel 2016 il termine aveva un significato piuttosto circoscritto, e riguardava le notizie false al 100% diffuse su Internet per generare traffico e introiti pubblicitari. In breve, tuttavia, dentro l’espressione ci è finito dentro un po’ di tutto: errori giornalistici, teorie del complotto, contenuti satirici decontestualizzati e propaganda politica.
In altre parole, come ha come ha scritto il giornalista e ricercatore Philip Di Salvo, è diventato “un contenitore vuoto in cui buttare diversi ambiti e altrettanti problemi che, affiancati, finiscono per ammassarsi senza portare a un risultato di senso”. Questo svuotamento è ben rappresentato dal modo in cui Trump utilizza l’espressione fake news: una clava da dare in testa a giornalisti e politici a lui ostili
La studiosa di media Claire Wardle – seguita da altri – ha proposto di fare un passo in avanti per individuare in maniera rigorosa le forme di disinformazione e misinformazione, che vanno a formare quello che è stato definito “disordine informativo”. Oltre alle notizie completamente false o manipolate, esistono infatti collegamenti e contesti ingannevoli, contenuti fuorvianti o ingannatori, la manipolazione della satira, o la semplice propaganda travisata da altro.
Inquadrando così la questione, si capisce immediatamente che partiti e media – cioè i primi a denunciare il fenomeno – fanno in realtà ampio uso di fake news.
Concentrandosi sull’Italia, gli esempi in tal senso si sprecano. Qualche tempo fa, la storia falsa notizia della “sposa bambina” musulmana seviziata a Padova era partita da un quotidiano locale per essere ripresa senza verifiche da testate nazionali, finendo sulla bacheca di Matteo Salvini. Quest’ultimo, inoltre, fa sistematicamente ricorso a bufale o distorsioni sui propri social – specialmente quando si parla di immigrazione.
Dal Movimento Cinque Stelle, poi, di lezioni non ne possono proprio arrivare. I siti appartenenti alla galassia della Casaleggio Associati hanno fatto ricorso per anni al clickbaiting più sfrenato; e sul blog di Beppe Grillo – tra le varie cose – si sono fatti collegamenti fuorvianti tra il “ritorno” della tubercolosi e l’arrivo dei migranti sulle nostre coste.
La situazione non migliora nemmeno se si passa ad altre sponde politiche. Qualche anno fa, il sito de L’Unità aveva pubblicato il video di “Meno male che Silvio c’è”, alludendo al fatto che in un frame potesse esserci la sindaca di Roma Virginia Raggi. Naturalmente non era vero; eppure, l’allora direttore Erasmo De Angelis si era giustificato sostenendo che si trattava di “giornalismo 2.0” e che ormai “il web ha modificato profondamente il giornalismo, sui siti e sui social gira di tutto”.
Anche il Partito Democratico – che per un periodo ha pubblicato dei rapporti sulle fake news di Lega e Cinque Stelle – ha fatto ufficiosamente impiego di profili fake, pagine unofficial come Matteo Renzi News per spingere la propria propaganda con un linguaggio decisamente più aggressivo rispetto a quello ufficiale.
Insomma: nessuno ha la credibilità per intestarsi quella battaglia. E infatti, ogni tentativo di risolvere il problema in via legislativa ha fatto più danni che altro. Sempre in Italia, durante la scorsa legislatura era stato preparato un disegno di legge contro le fake news con la previsione di “alcuni obblighi a carico del fornitore di servizi delle rete sociali, stabilendo specifiche sanzioni in caso di mancata osservanza”.
Ma dare a piattaforme private il potere quasi assoluto di fare ordine nell’informazione digitale, avvertiva l’avvocato Guido Scorza, era di fatto “una cura antidemocratica a una minaccia – ma solo una minaccia – alla democrazia”. Sempre nello stesso periodo, si era addirittura parlato di un fantomatico “algoritmo verità” – una suggestione proveniente da Marco Carrai, imprenditore nel ramo della cybersecurity vicinissimo all’ex premier.
Altrove è andata decisamente peggio, e la lotta alle fake news è stata il preteso per reprimere il dissenso politico. Il caso dell’Egitto è il più eclatante: nel luglio del 2018 è stata approvata una legge che punisce chiunque ha più di cinquemila follower sui social e diffonde “notizie false” – nella pratica, notizie vere ma sgradite al regime di Al-Sisi.
Naturalmente, nemmeno i commentatori più critici del concetto di fake news negano la pericolosità della disinformazione. Come visto prima, però, non esiste alcuna prova sul loro strapotere.
Piuttosto, come scrive il docente americano Brendan Nyhan, la forma di inquinamento informativo più preoccupante rimane quella più classica di tutte: “affermazione false e fuorvianti di politici che dominano l’agenda mediatica e hanno poteri di governo”. Donald Trump è sicuramente il re indiscusso di questa categoria; basti pensare che, nei suoi primi due anni alla Casa Bianca, ha sparato più di ottomila falsità.
In definitiva, il panico sulle fake news non aiuta di certo a fare ordine nel “disordine informativo”; né tantomeno è un rimedio alla crescente polarizzazione politica nelle democrazie liberali. Alcuni esperti sono comunque convinti che, in questo dibattito, non tutto sia da buttare.
“Le ‘fake news’ sono la miglior cosa che è accaduta negli ultimi anni”, ha scritto il professore Charlie Beckett della London School of Economics. “Danno al giornalismo mainstream di qualità l’opportunità per dimostrare il proprio valore, fondato sulla capacità, l’etica, la relazione con i lettori e l’esperienza. È una chiamata d’allarme per stimolare a essere più trasparenti, rilevanti e ad apportare valore alle vite delle persone”.
Se maneggiate con cura – senza isterie di sorta, e senza cedere al complottismo – le fake news potrebbero dunque essere un’occasione per rinnovare in profondità il giornalismo, tornando a guadagnarsi la fiducia dei lettori e contrastando efficacemente chi ha trasformato la disinformazione in un’arma politica letale per la democrazia.