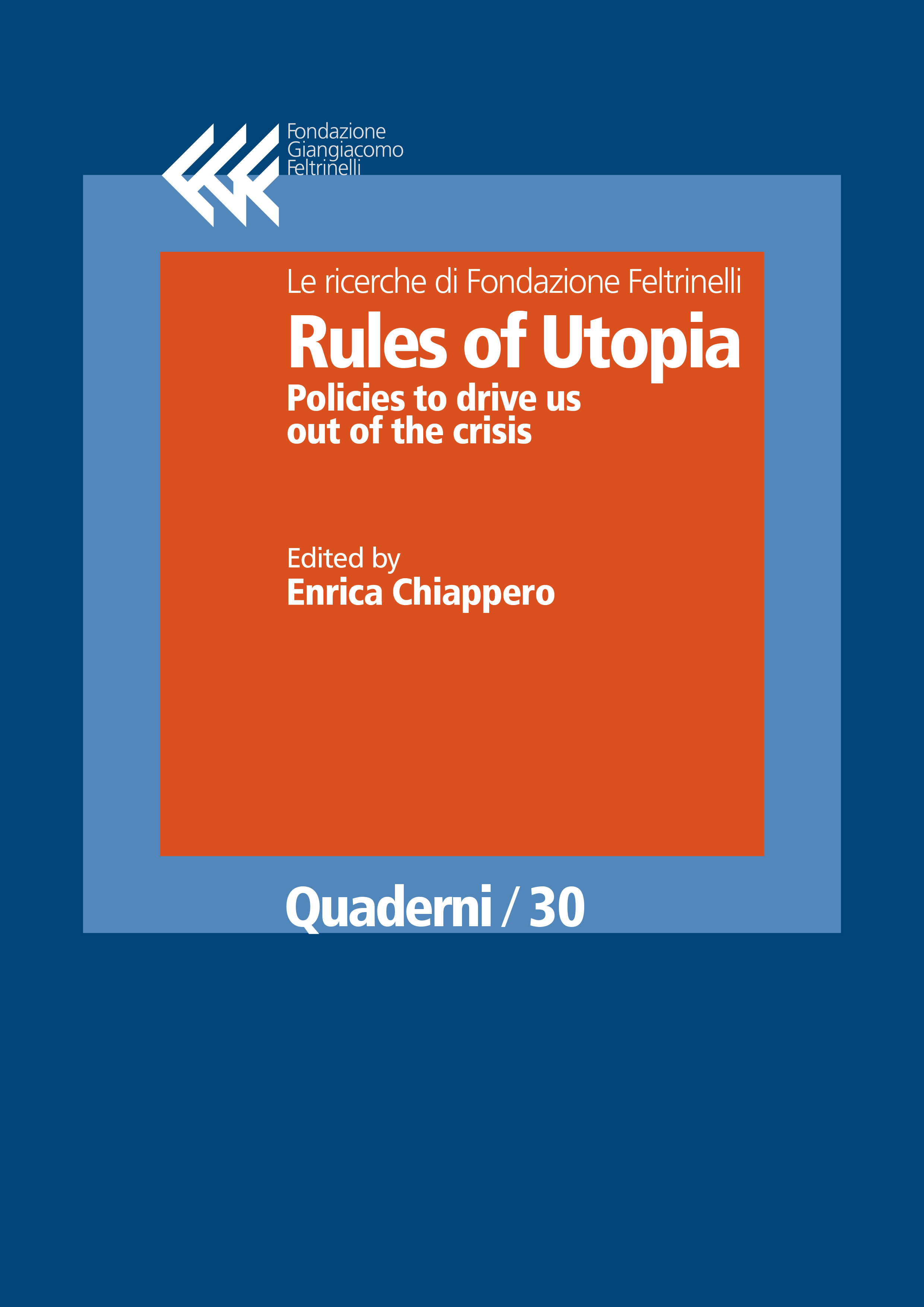Pubblichiamo un estratto del saggio di Donna Haraway Chthulucene, sopravvivere su un pianeta infetto, pubblicato in Italia da Not – NERO EDITIONS. Si ringrazia l’Editore per la gentile concessione.
Traduzione di Clara Ciccioni e Claudia Durastanti
Non si può continuare a deprezzare la natura svuotandola di ogni contenuto e risorsa, è un processo che non può durare ancora a lungo: continuare a estrarre risorse dal mondo contemporaneo nel tentativo di rimodellarlo continuamente sta diventando impossibile, dato che gran parte delle riserve della Terra sono state esaurite, bruciate, svuotate, avvelenate,sterminate ed esaurite. Grossi investimenti e tecnologie terribilmente creative e distruttive possono ritardare la nostra presa di coscienza rispetto a questo fatto, ma la natura a buon mercato è davvero finita. (…)

Nell’immagine, il Lago D’Aral (Kazakistan e Uzbekistan) dal 1954 ai giorni nostri. La parte orientale del lago, dopo essersi quasi prosciugata del tutto nel 2014, sta ricominciando lentamente a riempirsi di acqua.
Forse chiamare questo scandalo Antropocene è un modo per indicare la distruzione di luoghi e momenti di riparo per gli umani e tutte le creature. Come altre persone, anch’io credo che l’Antropocene sia più un evento limite che un’epoca, più un momento di passaggio che una fissità geologica. (…). L’Antropocene introduce delle discontinuità drastiche; quello che verrà dopo non sarà come quello che è venuto prima. Credo che il nostro compito sia rendere l’Antropocene il più interstiziale e insignificante possibile: dobbiamo unire le forze e condividere tutte le idee che ci vengono in mente per coltivare le epoche a venire in modo da ristabilire dei luoghi di rifugio.
Al momento la Terra è piena di rifugiati, umani e non umani, senza più rifugio.
(…) Per vivere e morire bene da creature mortali nello Chthulucene[1] è necessario allearsi con le altre creature al fine di ricostruire luoghi di rifugio; solo così sarà possibile ottenere un recupero e una ricomposizione parziale e solida della Terra in termini biologici-culturali-politici-tecnologici. Ma questa ricomposizione non avverrà se non saremo capaci di includere il lutto e il cordoglio per le perdite irreversibili (…). Abbiamo già avuto a che fare con un numero devastante di perdite, e ce ne saranno molte altre ancora. La prosperità non può derivare né dalla convinzione di essere immortali né dalla nostra incapacità di condivenire insieme ai morti e agli estinti.
Sono una compostista, non una postumanista; siamo tutti compost, non postumani. Il confine segnato dall’Antropocene/Capitalocene significa molte cose, compreso il fatto che l’immensa distruzione irreversibile è attualmente in corso, non solo per gli undici miliardi e rotti di persone che si ritroveranno sulla Terra verso la fine del XXI secolo, ma per un’infinità di altre creature. (Undici miliardi è un numero impensabile ma ponderato, che costituisce una previsione valida solo se i tassi di natalità mondiali resteranno bassi come adesso. In caso di aumento della natalità, può succedere di tutto). L’estinzione non è solo una metafora, il collasso del sistema non è un film catastrofista. Basta chiederlo a qualsiasi rifugiato di ogni specie.
Lo Chthulucene ha bisogno di uno slogan (…), io suggerisco il «Generate parentele, non bambini!». Generare e riconoscere le parentele è la parte più complicata e urgente di questa proposizione. Le femministe sono state le prime a sciogliere i presunti legami naturali e necessari tra sessualità e genere, razza e sesso, razza e nazione, classe e razza, genere e morfologia, sesso e riproduzione, persone che riproducono e persone che compongono (qui il debito specifico è con le melanesiane alleate con Marilyn Strathern e la sua parentela etnografica). Se vogliamo l’ecogiustizia multispecie, un tipo di giustizia che possa anche accogliere una popolazione umana diversificata, è tempo che le femministe prendano le redini dell’immaginazione, della teoria e dell’azione per sciogliere ogni vincolo tra genealogia e parentela, e tra parentela e specie.
Batteri e funghi non fanno che fornirci metafore, ma le metafore non bastano: le metafore fondate sulla natura non sono sufficienti. Qui c’è da fare un lavoro da mammiferi, insieme ai nostri collaboratori e co-lavoratori simpoietici biotici e abiotici. Dobbiamo generare parentele in sinctonia e in simpoiesi. A prescindere da chi e cosa siamo, dobbiamo con-fare, con-divenire, con-creare insieme gli «Earthbound» (ringrazio ancora Bruno Latour in modalità-anglofona per questo termine).
Noi, gli esseri umani di ogni luogo, dobbiamo rivolgerci alle urgenze intense e sistemiche che abbiamo davanti. Generare parentele significa generare persone, non necessariamente intese come individui o esseri umani. All’università rimasi colpita dal gioco di parole tra kin e kind formulato da Shakespeare nell’Amleto: le persone più kind, ovvero le persone più premurose, non erano necessariamente i membri della famiglia. Generare parentele – making kin – ed esercitare la premura verso l’altro – making kind – (intesi come categoria, cura, parentele senza legami di sangue, pa- rentele altre e molte altre ripercussioni) sono processi che ampliano l’immaginazione e possono cambiare la storia. Marilyn Strathern mi ha spiegato che all’inizio la parola relatives («familiari» in italiano, N.d.T.) indicava delle «relazioni logiche» e ha assunto il significato di «membri della famiglia» solo nel Seicento: questa ipotesi è tra le mie preferite in assoluto.
Allargare e ridefinire la parentela è un processo legittimato dal fatto che tutte le creature della Terra sono imparentate nel senso più profondo del termine, e già da tempo avrem- mo dovuto iniziare a prenderci più cura delle creature affini come assemblaggi e non delle specie una alla volta. Kin è un genere di parola che unisce. Tutte le creature condividono la stessa «carne» in maniera laterale, semiotica, genealogica.
1 Chthulucene è il titolo dell’edizione italiana di Staying with the Trouble, l’ultimo libro della filosofa statunitense Donna Haraway. L’autrice suggerisce questo termine per indicare l’era nella quale viviamo, dal nome del ragno californiano Pimoa Cthulu, e non da quello del mostro di H.P. Lovecraft. Antropocene è una definizione chiusa in sé e incapace di rendere conto della complessità eterogenea del mondo. Al contrario, Chthulucene richiama le concatenazioni fra umano, altro da umano e humus e la generatività rischiosa dei processi simpoietici. Quella dello Chthulucene è dunque l’era delle connessioni fitte, invisibili, sotterranee tra umano, oltre umano, inumano.