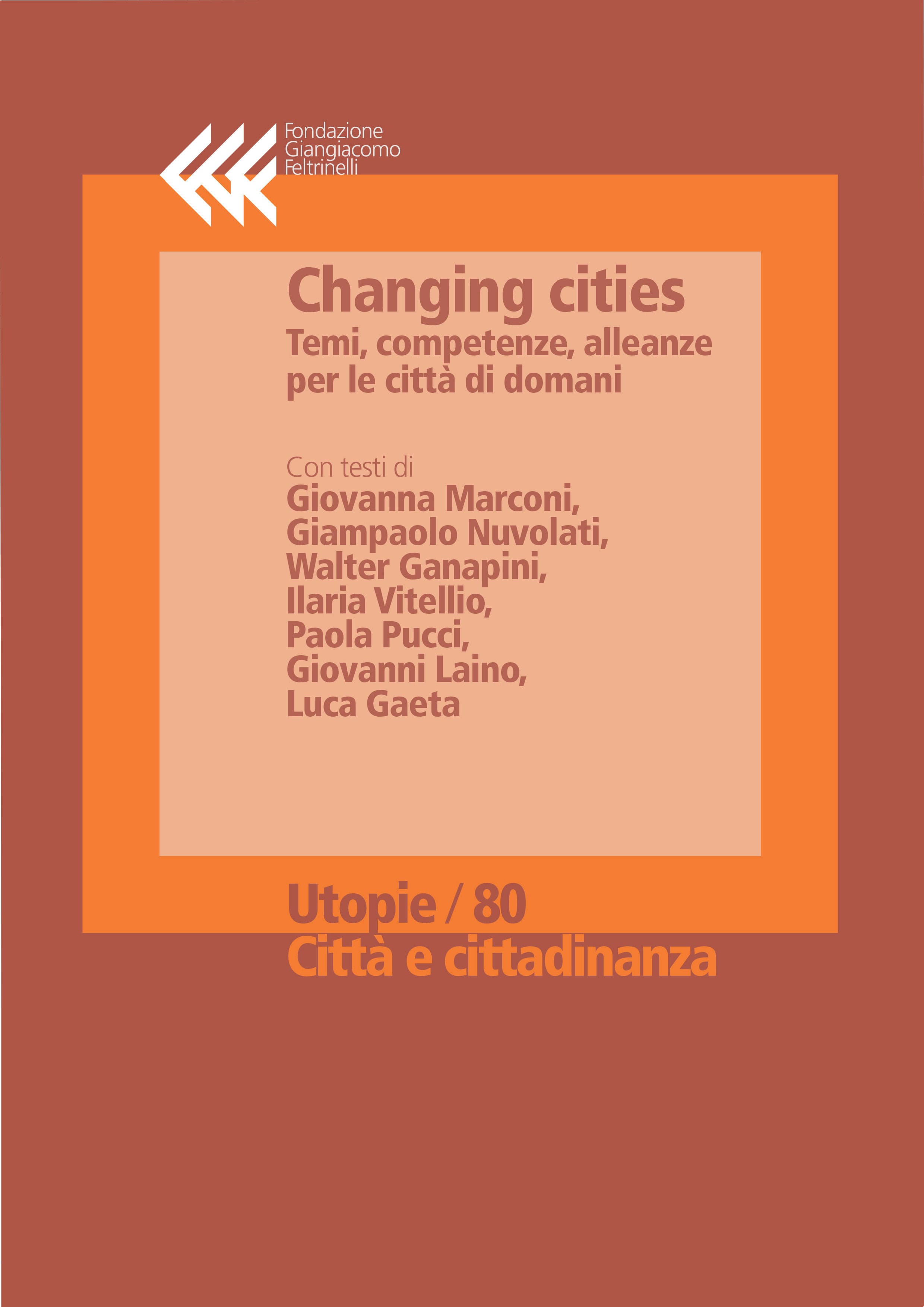foto: ilmessaggero.it
Milano è, in questi giorni, la prima grande città occidentale che di fatto chiude i battenti in seguito all’emergenza coronavirus. È un evento, a modo suo, senza precedenti: per una settimana scuole e università ma anche bar, esercizi ricreativi, luoghi culturali e di aggregazione come cinema e locali resteranno inaccessibili (questi ultimi la sera, dopo le 18) almeno fino a domenica 1 marzo. Le ragioni specifiche di questa serrata, radicale e improvvisa, iniziano a essere chiare: è necessario limitare la diffusione del virus riducendo il numero dei contagi, per far sì che il sistema sanitario nazionale sia in grado di arginarne gli effetti. Ma quali sono i risvolti, da un punto di vista culturale e sociologico, di questa settimana di clausura? Cosa vuol dire chiudere una città?
A un primo livello d’osservazione troviamo le scene di isteria collettiva: su tutte il contrabbando di mascherine e la caccia spasmodica all’Amuchina, entrambe ormai mitologici feticci della crisi da virus, rivenduti a prezzi stellari e finanche in maniera abusiva in giro per la città. Allargando lo sguardo troviamo poi i supermercati, presi d’assalto per fare scorta di provviste. Camminando per un grande supermercato di una nota catena, domenica pomeriggio, il giorno prima della serrata, si notavano già scaffali vuoti e disponibilità scarsa di prodotti come carta igienica, cibo in scatola e alimenti a lunga conservazione. Il supermercato, più di altri, rappresenta il luogo simbolo di questa crisi da coronavirus: in Rete si trovano immagini e meme di banchi frigo depredati, accompagnati da commenti più o meno sarcastici o critici se questa isteria collettiva sia realmente giustificata. Il supermercato è oggi a Milano la metafora di una socialità che si fa individuale e che nel momento della sua crisi individualizza il problema e la sua soluzione. Ognun per sé, sembrano dire quegli scaffali vuoti: bisogna accumulare scorte, e pazienza se per gli altri il cibo sarà finito. Il tutto in accordo con il più classico dei meccanismi del capitalismo: se da una parte c’è il panico collettivo, dall’altra c’è il profitto inaspettato di chi rimane aperto.
A un secondo livello, a questo collegato, c’è il lavoro. Come spesso accade, è attraverso il lavoro che leggere le dinamiche sociali si fa più complesso. Con scuole, università, cinema e locali chiusi, molti milanesi questa settimana non lavoreranno: “state a casa”, è il mantra. Le aziende, bontà loro, riscoprono i benefici dello smartworking, che molte invece purtroppo in tempi “normali” ancora avversano: lo smartworking ritrova centralità oggi in quanto è preferibile da parte delle aziende cedere un po’ di indipendenza al lavoratore piuttosto che interromperne del tutto la produttività. Limitare i contatti sociali non andando al lavoro è una delle strategie con cui si è pensato di fronteggiare questa emergenza: ma non tutti i lavoratori hanno questa possibilità. Se ciò è abbastanza comprensibile per chi svolge lavori che fronteggiano direttamente il rischio del contagio, come medici, personale sanitario e di servizio pubblico come gli autisti del tram e dei bus, ci sono poi i piccoli imprenditori e i freelance, che vedono alcune delle loro entrate a serio rischio se la serrata proseguirà a tempo indefinito – ma non hanno il cuscinetto di sicurezza di un impiego fisso, né tutele a proteggerli. Sorprende poi notare come i centri commerciali restino, invece, aperti. Come sottolinea la sociologa Annalisa Dordoni, autrice dell’ottimo libro “Sempre aperto”, non si comprende la differenza tra un bar o un cinema e un centro commerciale. L’apertura dei centri commerciali a fronte della chiusura delle attività culturali è un segno delle priorità della società dei servizi, sostiene Dordoni: prima le merci, poi le persone. Il centro commerciale è simbolo della più artificiale delle socialità, quella mediata dal consumo, individuale, neoliberale e competitiva, meno aggregativa e solidale, che nella crisi del coronavirus diviene l’unica possibile, l’unica consentita.
A un terzo livello, infine, ci sono i media e gli immaginari che questi producono. Con i cinema e i locali chiusi, infatti, si individualizza il consumo culturale: là dove i bar e i cinema resteranno chiusi, con ogni probabilità sarà Netflix a colmare questa lacuna. Dove c’era un aperitivo, o un evento, in queste sere ci sarà la televisione. La diretta di Sky Tg 24 di ieri sera, giorno 1 di clausura, era accompagnata da un’immagine statica di Piazza Duomo a Milano, deserta e buia. La città in questa immagine diviene metafora e immaginario della paura, per certi versi legittima e reale, e però amplificata a dismisura dai media, che dell’economia dell’attenzione fanno materia grezza di profitto. In un loop di segnali, la paura trasmessa dalle televisioni porta a guardare più televisione, a non fidarsi del prossimo, a invadere i supermercati. E in un’ideale saldatura tra vecchi e nuovi media, poi, queste dinamiche si riproducono come un contagio nei social media, dai gruppi Facebook alle chat Whatsapp, dove le camere dell’eco e le bolle di filtro condiscono l’isteria di massa con teorie del complotto, fake news e forme di aggressività varie.
Come diceva Mark Fisher, l’ansia è uno dei malesseri più tipici del tardo capitalismo, dove sorveglianza e individualizzazione dominano incontrastati. La città ne rappresenta il parco giochi, e ne incorpora le contraddizioni, in sinergia con le tecnologie digitali che queste contraddizioni amplificano e mediano. Nella Milano spettrale di oggi, vuota e chiusa, senza luci, gli spettri del coronavirus sono gli spettri delle paure di cui il capitalismo di oggi si nutre per continuare a esistere.
Quando una città chiude, inizia Black Mirror. Buona visione.