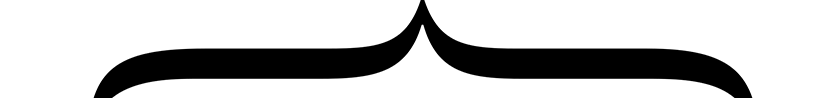La storia come un supermercato dove la politica si aggira e ne esce con carrelli colmi di oggetti, scelti a proprio piacimento, per utilità. Partiamo da questa immagine molto efficace, usata da Donald Sassoon durante il primo appuntamento del ciclo di seminari europei, svoltosi il 24 maggio in Fondazione Feltrinelli, sul tema dell’uso politico e utilitaristico del passato a fini politici.
Lo scoppio della guerra ha estremizzato questa modalità; l’abuso della storia è una componente cardine della narrazione della guerra in corso, una delle tante armi messe in campo da politici di vari schieramenti e su molte delle testate giornalistiche di primo piano. Risultato: un’opinione pubblica intossicata in un clima moralizzante e di estrema semplificazione della realtà.
Davvero viviamo in un contesto in cui le storiche e gli storici non hanno una riconoscibilità chiara e la storia viene impugnata alla stregua di una “clava politica”, usata per atterrare gli avversari?
Quel tipo di storia può ambire a essere antidoto e creare terreni di confronto, di analisi e di negoziazione dei significati?
La public history può essere il viatico per la costruzione di un senso di cittadinanza europea?
Il primo punto da affrontare è chiarire quale forma di cittadinanza stiamo prendendo in considerazione, perimetrarne il campo: pensiamo a un’idea di cittadinanza fluida e porosa, che tenga conto delle differenze storicamente determinate, delle fratture e dei rimossi che attraversano l’Europa come cicatrici imbarazzanti. Lo scontro tra memorie in opposizione ha spesso a che fare con i confini fisici e le linee di demarcazione simboliche/immaginarie che definiscono le “comunità”.
Potremmo visualizzare la storia europea come un paesaggio delle rovine: guerre; occupazioni; violenze etniche; deportazioni; il sommarsi di movimenti e governi reazionari; la polarizzazione politica e le sue spirali di violenza; il passaggio dei fronti di battaglia; le linee tracciate a tavolino che creano nuovi bordi tra un qui e un là.
Ma scelgo l’immagine delle rovine perché ha in sé qualcosa di positivo: le rovine sono lì, restano – come suggerisce Vito Teti – non fanno il suono muto delle macerie polverizzate. Potenzialmente sono “racconto in piedi”, traccia del passato ancora evidente e a cui è possibile dare voce.
Ma a chi va il compito di prendere la parola per rendere più complesso il “bricolage” delle memorie?
Come scrive Gabriella Gribaudi, è soprattutto dopo il secondo dopoguerra che cresce l’attenzione per le forme della soggettività, per il punto di vista dei singoli individui come soggetti portatori di storia, che si contrappone a visioni generali, più politicamente corrette, più pacificate: pubbliche.
I processi di rammemorazione sono in Italia strettamente locali e risiedono soprattutto nelle comunità: comunità in quanto gruppo di persone legate da un’esperienza particolarmente traumatica, comunità in quanto municipi.[…] Le comunità locali appaiono come i veri, spesso unici, luoghi della memoria del Paese: interpretano quella nazionale, conservano quella locale. Se ne fanno promotori sindaci, associazioni, gruppi di cittadini.
Nel piccolo del panorama italiano sono molte le iniziative virtuose di public history che vanno in questa direzione. Creano situazioni per conoscere ed esplorare in maniera partecipata alcuni passaggi storici divisivi e traumatici. Il mettersi in cammino, assumere un passo lento, attento ai dettagli, ben disposto all’ascolto delle voci meno altisonanti e anche dei silenzi più spessi. Così fa la cooperativa Il Germoglio, a Corleone, impegnata in iniziative di sensibilizzazione alla cultura dell’antimafia, organizzando passeggiate di contro-narrazione per riscoprire una Corleone differente, non schiacciata sull’immaginario cinematografico della patria di Cosa nostra.
Se la cittadinanza europea che vogliamo deve essere permeabile alle memorie, alle istanze, alle ferite e ai rimossi “degli altri” – fuori dalle logiche particolari dei singoli paesi, in una dimensione più ampia e sovra statuale – bisogna però essere disposti a mettere in discussione delle categorie interpretative.
Come dice David Forgasc: quando ci si spinge verso “i margini”, bisogna essere consapevoli che «nessun luogo è mai intrinsecamente marginale, periferico o remoto. Un luogo e i suoi abitanti sono sempre marginali, periferici o remoti in relazione a qualche centro situato altrove».
Per cui “il margine” in sé non esiste, prima che non sia lo sguardo di un osservatore – l’obiettivo della macchina fotografica del reporter, o la penna dello scrittore – a identificarlo come tale. Fare chiarezza su questo punto è importante per disinnescare rappresentazioni che incorporano e propagano relazioni di potere. Visioni della realtà che inducono a pensarla dentro degli schemi di gerarchia verticale, “alto-basso”, “dentro-fuori”, “cittadino-nemico esterno”, dentro le quali definiamo un ordine delle rilevanze delle nostre narrazioni, anche di quelle di memoria.
La public history può essere uno strumento utile a ridurre la distanza e il rischio di incomunicabilità tra le diverse culture? Un buon esempio lo offre il collettivo Tezeta, che organizza passeggiate narrative nel quartiere “africano” di Roma. Per loro, il senso di organizzare dei trekking UrbAfricani tra le vie intitolate alle conquiste coloniali italiane, sta proprio nel “ parlare di storia dell’Eritrea, di legami, lasciti e ferite del colonialismo italiano nella ex-colonia “primogenita”, e di migrazioni recenti e passate”.
Ma le disuguaglianze economiche, l’assenza di servizi, i pregiudizi stigmatizzanti che dipendono dal luogo in cui abiti, dal cognome che porti, dal colore della pelle che hai, sono dati di fatto tangibili, rispetto ai quali non basta muoversi sul piano delle rappresentazioni e delle contro narrazioni possibili. La questione è chiaramente politica e si pone su altri livelli, ma la politica dovrebbe dare più rilevanza a questo intervento sugli immaginari e alla capacità della storia di controverterli.
Concludo con un’ultima domanda: come fare in modo che i più giovani scelgano il passato come campionario di riferimenti, oggetti, esempi da cui partire per costruire un loro senso di appartenenza europea. Quand’è che le ragazze e i ragazzi iniziano a sentirsi europei? A partire dai manuali di storia? Più probabilmente in seguito all’erasmus o ad un viaggio interrail: un’esperienza che allarga il loro orizzonte coinvolgendoli praticamente.
Liliana Segre che invita Chiara Ferragni a farsi sponsor del binario 21 della stazione di Milano – Memoriale della Shoah – contiene una provocazione importante per la comunità degli storici, in un certo senso analoga a quella che la public history ha rivolto alla disciplina stessa (che forse coincide con la sua intuizione più florida e dissacrante).
Per farsi un’idea basta scorrere il programma della IV Conferenza nazionale di AIPH (Associazione italiana di Public History), appena conclusa presso l’M9 di Mestre, tra i panel: Urban game come pratica di public history; Giocare con la storia: usi e abusi della memoria storica nei videogiochi; “Prosit!”. La storia al pub (e non solo); Note di storia. La storia attraverso la musica; Passato senza storia: l’immaginario storico sui social network.
E’ una domanda che riguarda i linguaggi, i mezzi e le modalità per praticare la disciplina. Torniamo pure all’immagine della storia come scenario di rovine, traumi e cicatrici ma corriamo il rischio che, cuffiette nelle orecchie, i giovani gireranno lo sguardo dall’altra parte.
Se c’è una possibilità, per la storia, di attrarre il loro interesse e di diventare uno dei bacini da cui attingere riferimenti, esempi e valori europei, dipenderà anche dalla plasticità dei nostri linguaggi, dalla capacità di mettersi in ascolto e di innovarsi.