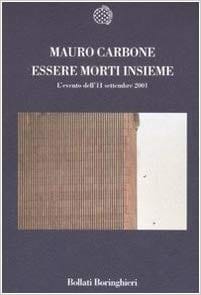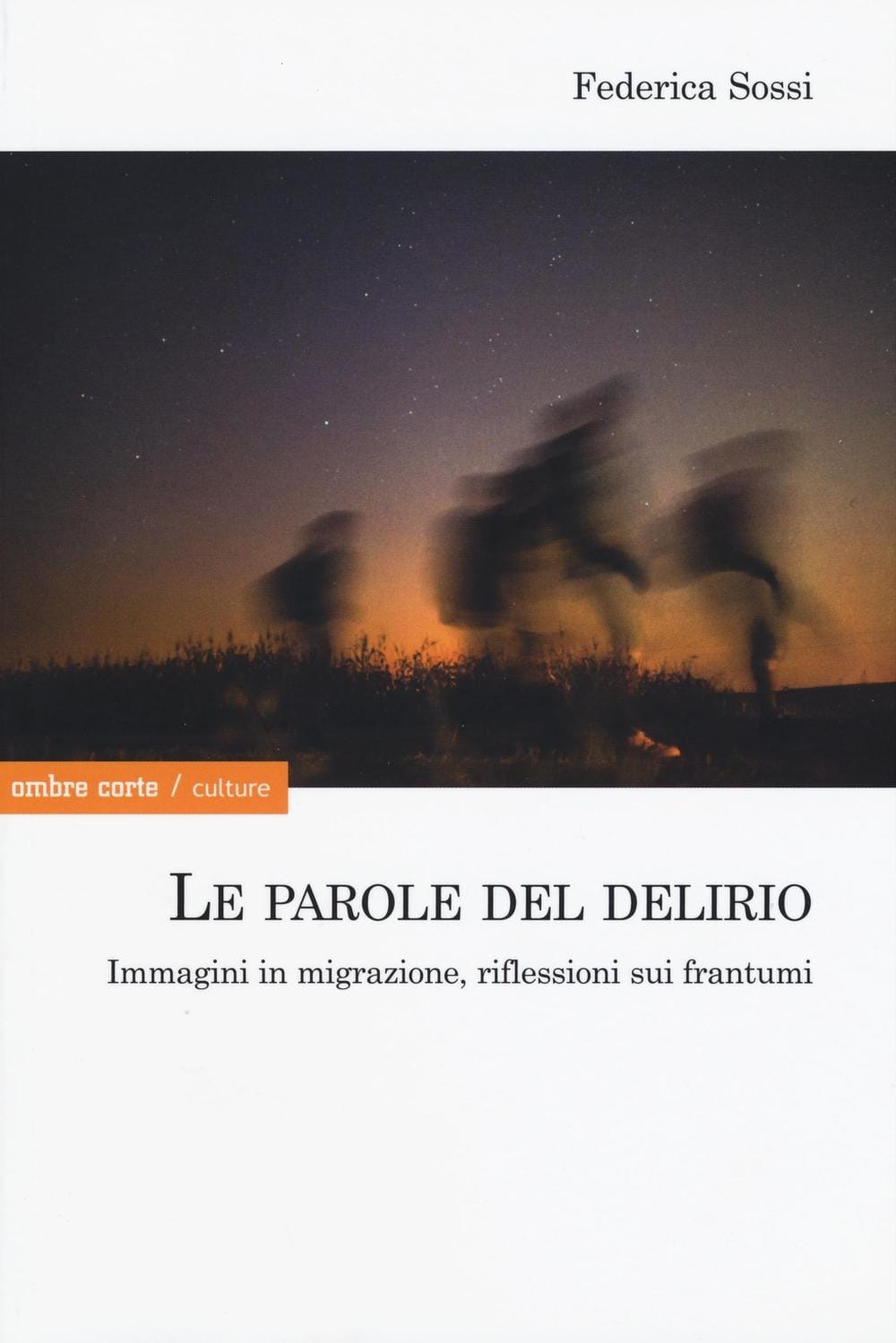In questa estate di porti chiusi, di pacchie finite, di un’Europa che si chiude su stessa per voltare le spalle al Mediterraneo, torna in mente un articolo del 2015 scritto da Santiago Alba Rico.
A Rousseau non piaceva il teatro, perché lo irritava l’idea di emozionarsi di fronte a situazioni sulle quali non si può intervenire. Il brutto della nostra reazione di fronte a Aylan, il bambino morto su una spiaggia turca, il bambino addormentato che non si risveglierà piangendo, non è che questa sia malata o insana: anzi, è moralmente ragionevole ed emotivamente adeguata allo stimolo. Il problema è che non siamo in teatro! Il problema è che il mondo stesso è diventato un teatro (…) nel quale non possiamo intervenire materialmente per cambiare qualcosa. Anche noi della sinistra indignata e accusatrice non sappiamo fare molto altro che sfoggiare ‘la buona coscienza’ su Facebook o su Twitter. Il mondo è un teatro (…) per la stessa ragione che faceva irritare Rousseau: quello che caratterizza il dramma rappresentato a un metro dal nostro naso, eppure su un palcoscenico irraggiungibile, è che non possiamo intervenire. Il mondo è un teatro perché, come in teatro, siamo tutti semplici spettatori.
A leggere Santiago Alba Rico, l’irritazione – l’imbarazzo, la vergogna? – di Rousseau sembra la nostra: noi, “consumatori” inermi di immagini di muri, stragi, fili spinati, corpi, sacchi. Come se il regime di iper-visibilità cui ci siamo assuefatti – la possibilità di vedere tutto – funzionasse da specchio amaro e rovesciato della nostra impotenza – il non poter far niente.
Ma non c’è qualcosa in quell’essere “tutti semplici spettatori”: un colpo, un urto, una spinta che, quasi nostro malgrado, possa riscattarci dall’inerzia? In questi nostri tempi di affanni e rancori privati, l’essere – insieme – spettatori scossi, turbati, commossi non apre uno spiraglio per essere strappati ai nostri trascurabili egoismi e messi in ascolto, in tensione, a servizio di vite che non sono la nostra?
Di vite che naufragano e noi con loro perché, nella bulimia di immagini di orrori e sofferenze cui oggi siamo abituati, arriva ogni tanto quell’immagine che cambia tutto: non quella che tutti guardiamo, ma quella per cui ci sentiamo d’improvviso guardati. Catapultati sul quel palcoscenico, coinvolti, implicati nella trama proprio con e per via di ciò che abbiamo di più “osceno”: la nostra vulnerabilità, la nostra finitezza, il nostro essere fatti della stessa carne.
In questa estate di muri, diritti e morti annegati, vorrei dire che l’accoglienza e l’asilo sono un dovere. Che le vite si soccorrono e si salvano. Che è giusto così. Vorrei dirlo, ma non ho un Dio, una Ragione, un Assoluto a cui appellarmi.
Allora mi restano, ci restano i corpi. Il nostro essere fatti di braccia, bocche, polmoni. Il nostro essere gli uni con gli altri, il nostro comune patire e sentire.
Pesco dalla memoria un’altra immagine. Si tratta di una fotografia scattata durante gli attentati di Londra nel luglio del 2005. L’immagine ritrae una donna con il viso coperto da una maschera di garza. Le sue mani sono appoggiate sulle guance per far aderire la maschera: come scrive Adriana Cavarero, “Enfatizzata dalla posizione delle mani, è soprattutto la somiglianza con il quadro di Munch (…). Per quanto casuale, l’analogia con Il grido evidenzia un aspetto peculiare della fenomenologia dell’orrore. Si tratta della corrispondenza tra l’impersonalità prodotta dalla maschera e quella che caratterizza la figura ectoplasmatica di Munch, priva di tratti fisionomici.”
Il volto della donna, coperto dalla maschera di garza, è irriconoscibile, anonimo, impersonale. Eppure quello schermo bianco, esangue, disumanizzante si fa smorfia di dolore, espressione di una sofferenza singolarissima e tragicamente comune. Quell’urlo ha perso ogni fattezza individuale, ogni connotazione personale: a gridare l’orrore della strage non sono i volti umanissimi e insanguinati ritratti in altre fotografie, bensì la ferita inflitta alla vita, la vulnerabilità del bios.
Ma la fotografia mostra un altro elemento: a fianco della maschera compare un giovane uomo che cinge il grido in un abbraccio. A sostenere quel vulnus impersonale c’è una persona perfettamente riconoscibile: un uomo che con un gesto concitato e scomposto com-prende il dolore. Lo prende con sé e se ne fa carico.

Attentati di Londra, luglio 2005
Tra il tutto e il niente, forse è questo che possiamo. Di fronte a quelle immagini di corpi feriti e di vite perse possiamo scoprirci “tutti spettatori” e sentire che fra noi – platea di anonimi sconosciuti – la distanza precipita. Commuoverci per muoverci insieme con e verso quel dolore e prendercene cura.
Non è solo un fatto di morale. Empatia, compassione, capacità di entrare in risonanza con gli altri sono radicate nella nostra esistenza sociale. In un’epoca in cui l’odio è mainstream, possono sprigionare una valenza politica oltre che etica: quella di trasformarci da spettatori a cittadini, da pubblico impotente a comunità capace di risposta, parola, azione.
Consigli di lettura
Mauro Carbone, Essere morti insieme
Susan Sontag, Davanti al dolore degli altri
Federica Sossi, Le parole del delirio