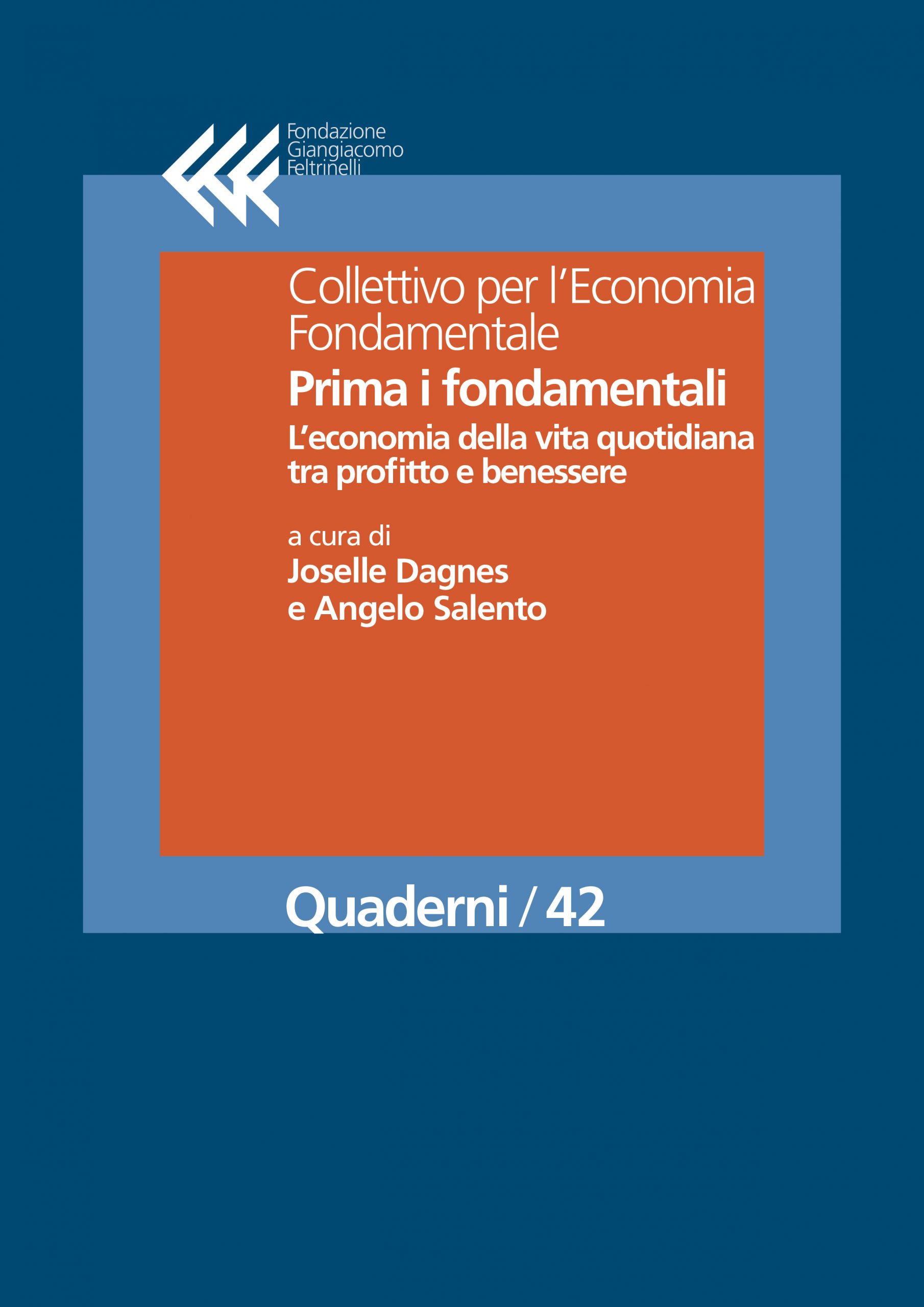Il “whatever it takes” di Mario Draghi quando era Presidente della BCE non è più quello di cui l’economia dell’Eurozona ha bisogno. Dobbiamo lavorare per una riduzione delle politiche monetarie espansive e una riforma comunitaria del Patto di Stabilità.
Per frenare l’aumento dell’inflazione, notevole in quasi tutto il mondo, serve la rapida cessazione delle politiche monetarie espansive e l’aumento conseguente dei tassi di interesse, da tempo molto bassi o negativi.
Alcuni obiettano che l’inflazione ha origine in aumenti dei costi (in particolare quello dell’energia) e nella contrazione delle produzioni dovuta alle difficoltà prima della pandemia e poi della guerra in Ucraina.
Quando l’inflazione deriva da minore offerta anziché da troppa domanda non va curata con strette monetarie.
La contro-obiezione è che l’aumento dei costi energetici e le interruzioni nelle forniture delle catene produttive internazionali possono essere state il fiammifero che ha acceso l’inflazione; ora però rischiamo l’incendio e il combustibile di aumenti sostenuti del livello dei prezzi è l’abbondanza di liquidità creata dalle banche centrali e, più in generale, il sostegno alla domanda aggregata di politiche monetarie e fiscali da tempo molto espansive. Se vogliamo fermare l’incendio occorre riassorbire liquidità e far svoltare quelle politiche.
Va anche detto che l’atteggiamento della politica monetaria è una determinante cruciale delle aspettative di inflazione. Perché chi influenza i prezzi non si attenda un’inflazione elevata le autorità monetarie devono segnalare, con un atteggiamento restrittivo, che non vogliono finanziarla. Gli economisti da tempo spiegano l’inflazione sostenuta – qualunque sia la causa che l’ha innescata – soprattutto con il fatto che essa è attesa da chi decide i prezzi ed è portato ad adeguarli all’andamento degli indici di inflazione.
Le due principali banche centrali del mondo, la Fed statunitense e la Banca centrale europea (BCE), sono da quasi un anno consapevoli di dover agire contro l’inflazione. Mentre la Fed ha preannunciato per tempo l’inversione delle politiche espansive che ha poi avviato nel corso del primo trimestre di quest’anno e programmato credibilmente per i prossimi semestri, la BCE ha esitato a lungo e solo ultimamente ha cominciato ad annunciare un deciso cambio di rotta.
In parte ciò è giustificato dal fatto che solo negli Stati Uniti l’inflazione è accompagnata da forte pressione della domanda aggregata sull’offerta, mentre in Europa la domanda è meno vivace e la crescita minore. Ma questo fatto va perdendo rilevanza perché anche da questa parte dell’Atlantico la crescita dei prezzi è facilitata dalla tanta liquidità e dalle aspettative che ancora a lungo i tassi rimarranno bassi e la liquidità abbondante, aspettative che la BCE ha continuato ad alimentare.
Va anche detto che fra i mercati finanziari statunitensi e quelli europei ci sono grandi vasi comunicanti e, per evitare che le differenze dei tassi di interesse abbiano effetti destabilizzanti sul cambio euro/dollaro (svalutando troppo l’euro se i tassi europei sono troppo più bassi troppo a lungo), le due politiche monetarie andrebbero ben coordinate, pur tenendo conto delle differenze fra le congiunture delle due aree monetarie. In realtà è probabile che le esitazioni della BCE siano state causate dal timore di aggravare con rialzi dei tassi la situazione dei grandi debitori, governi in prima linea.
La questione riguarda in particolare il debito pubblico italiano, la cui dimensione rispetto al Pil è molto maggiore di quella degli altri principali Paesi dell’eurozona. Il problema nasce prima ancora che dai prossimi aumenti dei tassi di interesse, che comunque graveranno solo gradualmente sul debito in essere, man mano che esso giungerà a scadenza e dovrà essere rinnovato, dall’esaurimento, già disposto dalla BCE, degli acquisti netti di titoli di Stato che da tempo alimentano il cosiddetto “quantitative easing” della banca centrale. La mancanza del suo supporto alla domanda di titoli potrebbe aggravarsi quando la BCE decidesse, come ha già fatto la Fed negli Stati Uniti, di non sottoscrivere più neanche titoli di Stato di importo pari a quelli che, da essa detenuti, giungono a scadenza.
In che misura un’inversione della politica monetaria rischia di compromettere la sostenibilità del debito pubblico italiano?
Va ricordato, innanzitutto, che questo non è solo un problema nazionale, ma riguarda l’intera eurozona. Se l’Italia non fosse più ritenuta pienamente solvibile i mercati eviterebbero i nostri titoli debitori fino al punto di mettere a rischio la partecipazione dell’Italia alla moneta comune.
Ciò è ben noto visto che è già successo nel 2012 quando alle speculazioni dei mercati l’allora Presidente della BCE Mario Draghi oppose il famoso “whatever it takes”, che fu essenzialmente la dichiarazione che l’integrità dell’eurozona è parte essenziale del mandato della sua banca centrale. È dunque opportuno che sia l’Europa che l’Italia prevengano situazioni in cui la sostenibilità del nostro debito possa essere messa ragionevolmente in dubbio.
Si tratta di una prevenzione che può aver luogo per molte diverse vie. Fra queste la più sana e naturale è il contenimento dei prossimi disavanzi dei nostri conti pubblici calcolati al netto degli interessi passivi.
Se sarà confermato il rientro dello shock pandemico e andrà contenendosi anche quello della guerra in Ucraina, le politiche di bilancio predisposte finora dal governo sembrano assicurare un contenimento sufficiente a non inficiare la reputazione di sostenibilità del debito del Paese. La stessa Commissione europea ha pubblicato previsioni che permetterebbero di veder scendere gradualmente ma adeguatamente il rapporto fra il nostro debito pubblico e il Pil italiano.
Da questo punto di vista il tema dei tassi e della politica monetaria si collega con quello della politica di bilancio.
Diventa allora cruciale anche la questione del Patto di Stabilità e Crescita, cioè della disciplina comunitaria delle finanze pubbliche che venne sospesa quando scoppiarono le esigenze straordinarie della pandemia e che dovrà prossimamente essere reintrodotta. Non è ancora chiaro quando il Patto sarà reintrodotto, ma è quasi certo che quando questo accadrà le sue regole saranno diverse da quelle che vigevano fino all’inizio del 2020.
Si discute molto su quale riforma sia opportuna, ma molto meno sul fatto che la riforma del Patto è necessaria e che deve rispondere alle diverse situazioni dei Paesi membri. Difficilmente ci verrà imposto di ridurre il debito pubblico troppo bruscamente, perché sarebbe controproducente: si fermerebbe la crescita del denominatore del rapporto debito/PIL aggravando il peso dei debiti in essere.
Detto ciò, è importante tener presente che non è nostro interesse rinviare la reintroduzione di un Patto ben riformato. Infatti la credibilità del Paese sui mercati finanziari non può che crescere quando è chiaro che le sue politiche di bilancio sono soggette a opportune regole comunitarie. Un nuovo Patto è dunque benvenuto soprattutto ora che il nostro indebitamento deve affrontare un periodo di graduale ma notevole rialzo dei tassi di interesse.