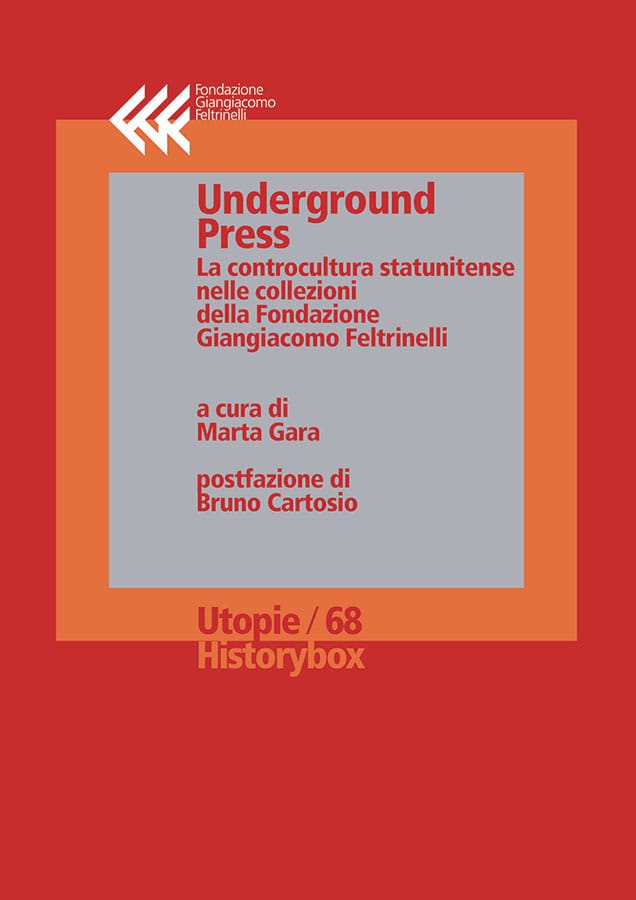Loretta Valtz Mannucci, Nixon, l’establishment e la “maggioranza silenziosa”, “Mondo operaio”, a. XXII, n. 11, novembre 1969, pp. 10-13, per la rassegna Dal no alla guerra in Vietnam al no alla guerra contro i Curdi: sul ruolo delle dimostrazioni popolari e sulle debolezze delle istituzioni
A che cosa preludono, si domandano i commentatori europei, le dimissioni di Gabot Lodge e del suo vice Walsh? Che finalmente Nixon si muova? La domanda stessa, purtroppo, non può che sottintendere risposte fuorvianti. Nixon non è mai stato “immobile”. Egli ha perseguito anzi con molto impegno la direzione strategica già indicata nel periodo tra il ritiro di Johnson e le elezioni presidenziali, da tutto quello stuolo di esperti e sapienti economici ed accademici che costituiscono sia l’istituzione burocratica della presenza (o, se si preferisce, del “ramo esecutivo”) che il cosiddetto “establishment militare-industriale”. Le dimissioni si aveva sentore già da qualche mese rientrano in un quadro di manovre diplomatiche puramente tattiche. Come nel caso della “nuova” Hnea verso l’America latina, si tratta di creare occasioni per ribadire una certa immagine di fronte all’opinione pubblica, in patria e nei paesi alleati: un’immagine, si intende, che renda più facile la posizione dei gruppi di potere. Nel caso di Cabot Lodge e di Walsh si tiene presente soprattutto il fatto che la maggioranza del pubblico americano, ivi compresi i soldati al fronte, giudica le trattative di Parigi una farsa. Mutando la rappresentanza si dà un’impressione di rinnovamento, di freschezza di volontà e di posizioni; si guadagna tempo.
Il dato di fatto fondamentale da non perdersi di vista resta quello dell’interesse americano. Esso rimane unico. Al di là delle scelte semantiche, delle “alleanze per il progresso” e della “partnership”, della “consulenza” Nato, dello stile personale, l’intero establishment americano, in quanto tale – e come ogni establishment di grande potenza che la storia ricordi – partecipa ad un’unica visione dell’interesse nazionale, necessariamente derivata dagli interessi concreti che formano la base del suo potere. Il resto è mitologia. Gli USA difendono – e anzi definiscono – “la civiltà occidentale” e “i valori democratici” secondo sé stessi. Il timore espresso da quello che “Newsweek” definisce “un alto personaggio europeo”, che dal fatto che “la politica estera statunitense si comincia a fare nelle piazze anziché nel governo” derivano implicazioni “profondamente gravi” per l’Europa, denota una singolare tendenza all’autoinganno o all’ipocrisia.
A parte il fatto che “la piazza” resta saldamente – piaccia o no – saldamente ancorata al sistema, nessun segno autorizza a sperare o temere che manifestazioni di piazza o una ben che minima considerazione per la sostanza dell’opinione pubblica si siano mai intromesse nelle decisioni riguardanti la politica estera. Da sempre le decisioni sono state prese ai massimi livelli, per poi essere comunicate nei modi più adatti a farle condividere (e questo vale per l’intervento americano nella seconda guerra mondiale come per la faccenda del golfo del Tonkino ). Assodato ciò, ne consegue con assoluta naturalezza che non ci sono implicazioni nuove per l’Europa. Il che non toglie, naturalmente, che siano “profondamente gravi” le implicazioni che da sempre comporta la politica estera americana, in Europa come altrove. Le pressioni di alcuni settori politici “atlantisti” sugli americani, la loro “approvazione” della saggezza, della prudenza, del ritegno di Nixon o di Johnson o di Kennedy, non hanno che effetti marginali sulle decisioni che riguardano l’Europa.
Gli Stati Uniti resteranno in Europa fintantoché il loro interesse lo richiederà e nei modi che meglio servono questi interessi. Nel giorno in cui il loro interesse non lo richiedesse, se ne andrebbero o trasferirebbero gli oneri della loro presenza sugli altri componenti del loro sistema: in questo senso la migliore “garanzia” per una certa Europa è, come ben sanno coloro che ne fanno parte, il sempre più simbiotico rapporto con il mondo economico e finanziario americano, le partecipazioni incrociate, i fondi di investimento, le società miste, e così via. Ciò è vero particolarmente là dove questi gruppi si rivolgono a quei paesi del terzo mondo dove una presenza dichiaratamente americana può essere meno bene accolta. Ai massimi livelli di questo rapporto è superato perfino il problema di un “predominio” americano all’interno della comunità come dimostra l’accordo tra Rockfeller e Rotschild per fondere finanziarie che ognuno dei due aveva costituito per “aiutare lo sviluppo dei paesi sottosviluppati”.
Se l’autorevole personaggio, di cui non viene per sua fortuna fornito il nome, avesse poi bisogno di riprove che tutto va come sempre, le potrebbe trovare nell’accoglienza fatta, dai rappresentanti americani alla recente riunione dei vice ministri degli esteri della Nato, alla proposta delle nazioni del Patto di Varsavia di convocare una riunione che riveda i rapporti tra i due sistemi di difesa. La freddezza americana, equivale ad un veto, trova un “pendant” nel secco invito rivolto dall’URSS ai paesi europei a non intromettersi nelle discussioni di Helsinki.
Né sarebbe lecito supporre che la maggioranza di coloro che partecipano alle manifestazioni contro la guerra nel Vietnam – i Moratorium Days – siano estranei o contrari all’assetto generale della società americana. Essi per lo più non osteggiano il modo in cui è strutturato, distribuito e gestito il potere politico ed economico. Essi dissentono dal modo in cui è applicato ora ad un problema specifico. Richiedono alla leadership esistente un’iniziativa maggiore per risolvere ciò che secondo i sondaggi viene visto contraddittoriamente come una situazione senza vie di uscita, ma tuttavia intollerabile. Non tentano, in breve, di fare politica, ma chiedono che una politica venga fatta. Con rare eccezioni i dissenzienti che ora scendono in piazza non muovono critiche di fondo al modo di essere della società americana (come avveniva invece nelle manifestazioni degli anni scorsi). Non vedono alcun necessario rapporto tra questo assetto generale della loro società e la guerra stessa. Molto spesso non ritengono nemmeno che sia stato un errore impegnare il paese nel Vietnam. Ritengono piuttosto – come Robert e Ted Kennedy e McNamara – che il prezzo economico, politico, psicologico è diventato eccessivo rispetto ai benefici ricavabili. Oppure com McCarthy, Fulbright e MacGovern ritengono che questa particolare guerra rechi un danno morale alla nazione.
Tornando a Washington da Saigon subito prima delle elezioni presidenziali, l’ambasciatore americano Bunker aveva detto che il governo sudvietnamita non aveva ragione di preferire un candidato all’altro, dal momento che entrambi vedevano l’interesse americano allo stesso modo. I dissensi, era sottinteso, sono un affare interno, roba nostra: non· crediate di poterci speculare sopra, poiché r1i guardano solo i metodi del potere americano, e non il suo contenuto. La stessa dichiarazione hanno fatto molto lealmente tutti gli uomini politici americano, da Robert Kennedy a Humphrey a Rogers. Nixon lo ha ancora ribadito nel discorso sul Vietnam, affermando che solo gli americani possono perdere in America la guerra.
In che senso Nixon intenda “perdere la guerra” si deve ricavare da altri atteggiamenti naturalmente; ma grosso modo si può pensare che egli non si preoccupi di quella minoranza che Agnew, con la sua piena approvazione, chiama “chiassosa”. Né i suoi componenti, con le loro richieste di ritiro, né il ritiro stesso, già deciso, possono costituire per Nixon un “perdere la guerra”. Nixon invece si rivolgeva dichiaratamente alla “maggioranza silenziosa”, ai 48 milioni di individui che hanno votato per lui o per Humphrey; ai membri del ceto medio-inferiore precariamente agganciati al1a caviglia della società del consumo, esposti ai venti del suo volo inflazionistico, ai fedeli del mito americano. Egli ha bisogno che questo gruppo, su cui poggia la stabilità del sistema attuale di potere, stia calmo. La calma, l’ordine – ha dichiarato tempo fa un economista uso a dar consigli ai presidenti – sono essenziali all’andamento dell’economia capitalista.
Il clima di maggiore “tranquillità”, che alcune pubblicazioni di massa come “Time” o “Newsweek” da tempo notano in questo settore della popolazione, deriva direttamente dall’attività di Nixon e di Agnew. Questa tranquillità, promossa con discorsi, provvedimenti, nomine e atteggiamenti personali ben calibrati, ha stabilizzato la situazione interna al di qua di una aperta radicalizzazione. Sulle elezioni locali e statali che si sono svolte all’inizio di novembre “Time” ha osservato: “Quasi ovunque è stata una buona giornata per i moderati; l’elettore americano si è dimostrato meno fazioso e più giudiziosamente pragmatico… di quanto si pensasse”. Il paese, ha detto Nixon nel suo discorso di insediamento, ha bisogno di riposare, di richiamarsi ai valori tradizionali: il clou stava proprio nel concetto di “riposo”, poiché il richiamo ai valori tradizionali (della frontiera, dei padri fondatori, del lavoro, ecc.) risuona ormai da più di dieci anni. Ha scritto ancor “Time” nel numero del 24 gennaio 1969, dedicato al “risanamento della nazione”:
“Se possiamo parlare di un consenso morale che sta emergendo negli USA oggi, esso pare imperniarsi sul desiderio di un senso di partecipazione e di comprensione nella vita dell’individuo in rapporto alla società che lo circonda. I sostenitori di George Wallace, come i seguaci di McCarthy e di Robert Kennedy, condividevano una protesta comune contro quella che avvertivano come propria impotenza a controllare il loro governo persino la loro stessa esistenza… Il loro desiderio, spesso semplicemente nostalgico, riguarda una società nella quale le dimensioni della vita consentano un’azione individuale pertinente”. All’inizio di ottobre la rivista “Saturday Review” commentava: “Il presidente Nixon, con il suo fare stranamente blando e poco insistente, ha ridato una certa calma alla nazione… non vi è dubbio che egli riflette l’umore attuale del paese”. In questo quadro va vista la lunga vacanza estiva in California, i weekends in Florida a pescare. In questo quadro va anche visto ciò che alcuni hanno definito l’“integralismo verbale” di Agnew e l’itinerario prevalentemente rurale, tra Sud e Mid-west, da lui instacabilmente battute da gennaio in poi. “Laggiù nel cuore del Paese”, commentava un senatore repubblicano, “ci sono milioni di persone che credono Agnew un eroe. Ecco un uomo, dicono, che dice le cose come stanno: potete credermi, lo constato ogni giorno nelle lettere che ricevo”. Se Nixon dicesse il genere di cose che Agnew dice, osserva “Newsweek”, si inimicherebbe gruppi molto forti: i sindacati, i mezzi di comunicazione, i negri. Provocherebbe la radicalizzazione delle parti. L’America provinciale, la “maggioranza silenziosa”, “sente che Nixon è in realtà come Agnew, sebbene come presidente non possa dire queste cose. Attraverso Spiro Agnew si fa sapere a questa parte del Paese che essa non è stata tradita”. Nel Sud i sondaggi mostrano Agnew ormai alla pari di Wallace nell’opinione pubblica, mentre nel Paese nel suo complesso circa il 20 per cento degli interpellati lo vedono con “grande favore”. “Agnew”, riassume “Newsweek”, “sta dicendo al pubblico ciò che l’uomo medio sta dicendo al suo vicino di casa da sei mesi”. Si tratta, come giustamente fa notare un esperto californiano di sondaggi, di qualcosa ancor più importante del Vietnam. Si tratta, come abbiamo osservato in queste pagine l’anno scorso al momento della elezione presidenziale, della difesa del mondo americano così com’è, difesa che comporta la fiducia della “maggioranza silenziosa” nelle istituzioni e la sua identificazione con le persone che le dirigono.
L’impostazione del secondo Moratorium Day (ricalcata sull’iniziativa della rivista “Life”, che ha pubblicato le foto di tutti gli americani morti in una settimana in Vietnam) risponde a questa necessità di rinsaldare le basi della fiducia e dell’identificazione facendo il gioco proprio della politica estera ufficiale americana, e cioè un ritiro americano – in tempi non precisati ma, a quanto assicura Nixon, “già decisi” – che proceda di pari passo con la “vietnamizzazione” della guerra.
Bunker, con l’apprezzabile realismo che pare sempre caratterizzare le sue partenze da Saigon, ha dichiarato qualche settimana fa che chiunque fosse tornato da Washington come ambasciatore, lui o un altro, “l’unico interesse suo sarà che cambi la nazionalità dei morti”. Atteggiamento, questo, confermato dai risultati dei sondaggi condotti prima del discorso di Nixon e dalle reazioni successive ad esso. Ben settantasette interpellati su cento hanno espresso opinioni favorevoli al discorso di Nixon, e così la vasta maggioranza di coloro che hanno scritto in seguito ai membri del Congresso o al presidente stesso. Il risultato immediato è stata la sospensione a tempo indefinito dell’inchiesta senatoriale sulla guerra, che doveva iniziare proprio in quei giorni. Un consigliere vicino a Nixon ha detto che “si potrà mantenere questa maggioranza per un periodo da quattro a sei mesi senza mutare la nostra linea”. Nixon stesso, nel dire che la reazione dell’opinione pubblica ha reso molto più facile raggiungere la pace, fa capire che per lui “perdere la guerra” significa semplicemente perdere la sintonia tra la base e il vertice del potere.
Con un gioco delle parti meno scoperto di quello in cui si destreggia Agnew, Nixon fa la faccia dura nei confronti del Moratorium Day; ma essi con l’associare borghesi di mezza età alle manifestazioni (mutamento sottolineato da “Time”, da “Life” e così via) rendono più rispettabile l’idea del ritiro totale delle truppe di combattimento americane già deciso e consentono che questo ritiro avvenga con maggiore sollecitudine, mentre distolgono l’attenzione del pubblico dal fatto della guerra. Se i vietnamiti si battono tra di loro, a quella distanza, diventano fatti loro; la presenza di armi americane e di truppe “non-combattenti” (compresa, pare, l’aviazione) diventerà poco visibile al “pubblico medio”.
Ancora meno visibile sarà l’attività bellica nel Laos e nella Cambogia e la massiccia presenza americana nella Tailandia. Ba11, diplomatico di orientamento liberal che sta sulla breccia ai massimi livelli da un ventennio, ammetteva recentemente in una lettera a “Time” che il ritiro delle truppe americane significherà la “vittoria comunista”, ove comunisti continua a significare Nord Vietnam per la persistente convinzione che sostiene che un’invasione da parte del Nord sia all’inizio della spirale bellica. Ball si preoccupa molto di questo, poiché “il popolo americano non è ancora preparato” ad affrontare questo risultato, sebbene “ormai” il Vietnam non abbia più importanza strategica. Il dilemma di Ball, come d’altronde di tutto l’establishment che formula la politica estera, è come evitare di rendere troppo pubblica la misura della presenza militare americana in quella zona asiatica: presenza raggiunta precisamente attraverso l’intervento nel Vietnam, presenza il cui conseguimento è stata forse non l’ultima ragione di quell’intervento stesso.
Il dopo-Vietnam, ha detto uno dei professori partecipanti alla riunione sulla futura politica estera americana che abbiamo avuto occasione di citare mesi fa su questa rivista, sarà caratterizzato da una tendenza del governo ad assumere un low profile, ad indirizzare i suoi interventi attraverso canali poco visibili, possibilmente internazionalizzati o semi-privati. La segretezza, ha ribadito Kissinger, è stata una delle armi più valide della diplomazia ottocentesca, e ha consentito la creazione e il mantenimento di un equilibrio tra le potenze. Il pubblico ancora fermo su tattiche o slogan superati può diventare scomodo. O, per dirla con Agnew: “È ora che si spazzi via la retorica… che si lasci perdere la finzione che in un Paese di 200 milioni di individui tutti siano qualificati a decidere che cosa debba fare il governo”.
Durante il suo viaggio asiatico Nixon ha più volte dichiarato che in futuro gli USA si limiteranno a garantire le coste dei paesi asiatici, a qualche aiuto tecnico o di consulenza, ove sia richiesto. Le dichiarazioni sono state accolte dai “regimi amici” con sangue freddo, una “comprensione”, persino un fiero senso di orgoglio nazionale davvero consolanti. Tanto consolanti da destare il sospetto di ben altre assicurazioni “riservate”, il cui contenuto si intravede già di tanto in tanto, come nel caso della “riconsegna” di Okinawa ai giapponesi.
Per chi pensasse che una presidenza Humphrey, pur restando entro i parametri di un newdealismo da sempre refrattario a proporre veri mutamenti sostanziali nei rapporti di potere, sarebbe stato più “progredito”, sarà bene citare qui una sua recente dichiarazione. Humphrey rispondeva ad una domanda di “Life” sulle conseguenze per la “reputazione” e “il rispetto di sé” degli Stati Uniti, di un eventuale ritiro massiccio dal Vietnam senza precedente accordo diplomatico con l’altra parte. Humphrey aveva già reso chiaro, nel rispondere ad una precedente domanda, che per “altra parte” intende soltanto Hanoi e per Sud Vietnam soltanto il governo di Saigon.
“Dobbiamo rendere chiari gli scopi della nostra presenza in Vietnam. Siamo andati là per fermare un’aggressione, per aiutare a proteggere all’autodeterminazione. Abbiamo raggiunto ambedue questi fini. L’aggressione non è riuscita e non riuscirà se i sudvietnamiti verranno addestrati bene ed equipaggiati per l’autodifesa. È ciò che si sta facendo. In secondo luogo, ci sono state delle elezioni. I sudvietnamiti sono stati quindi protetti in modo da garantire l’autodeterminazione. Abbiamo contribuito a rafforzare un governo e un’economia. Perciò un ritiro sistematico di truppe durante il 1970 non rappresenterà una sconfitta o l’abbandono del nostro impegno verso un alleato che può ormai provvedere alla propria difesa. Dobbiamo capire che la lotta nel Sud Vietnam non è la nostra guerra. Siamo andati per aiutare i sudvietnamiti. È quello che abbiamo fatto e così dobbiamo presentare la nostra missione al popolo americano e al mondo”.