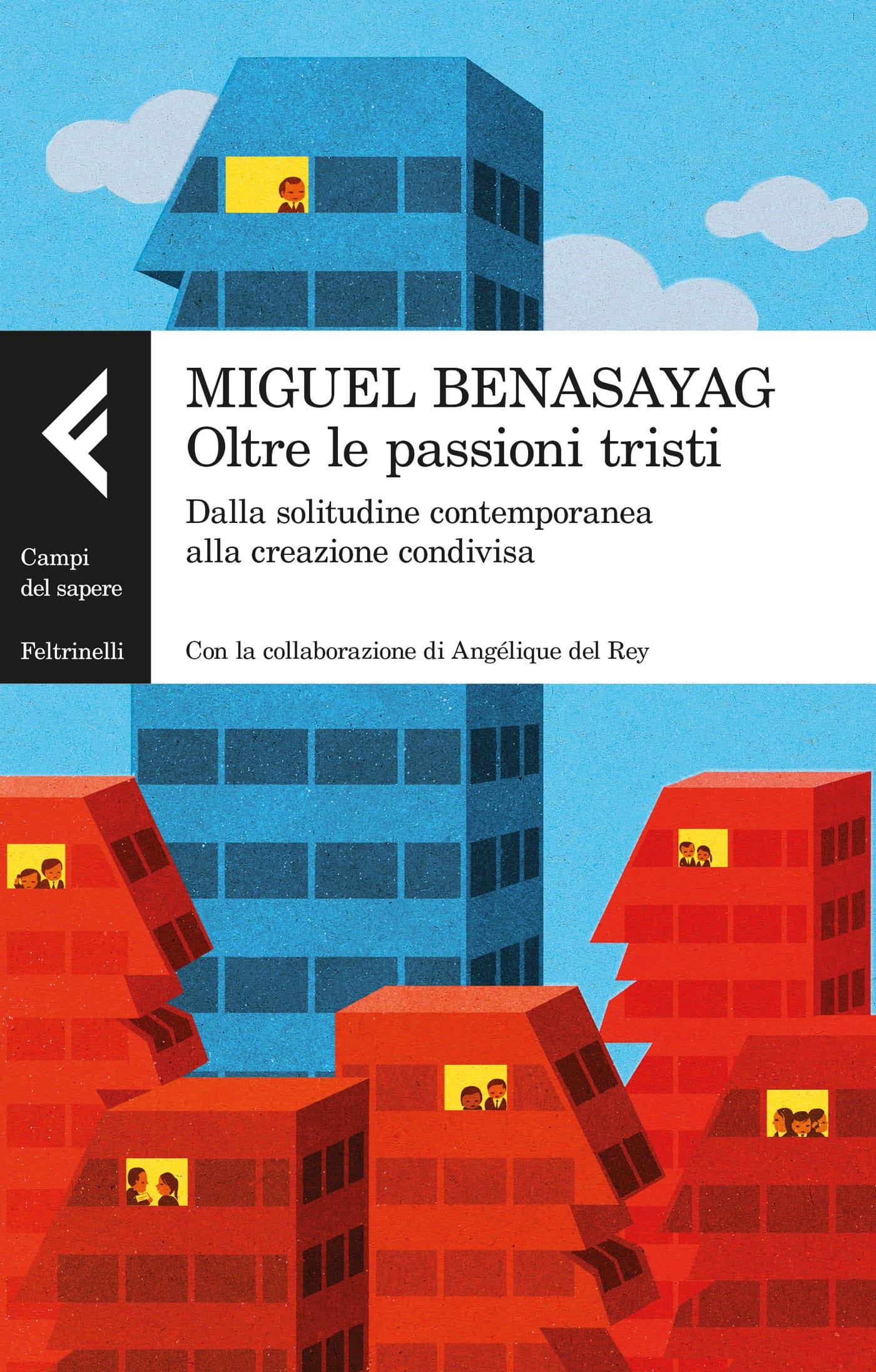Di seguito un estratto del libro di M. Benasayag, Oltre le passioni tristi. Dalla solitudine contemporanea alla creazione condivisa, Feltrinelli Editore 2015. Si ringrazia l’autore e l’editore per la gentile concessione.
Trentenne, Henri – che come quelli della sua generazione si considera brillante – mi consulta nel 2010 per un problema di mancanza di motivazione causa di ripetuti fallimenti. Fin dalla prima seduta, Henri si interroga sulla sua possibilità di essere cantante, attore o autore drammatico di successo… Interrompo l’interminabile elenco e gli chiedo se sa cantare; mi risponde che non ha mai provato e che non conosce la musica. Mi spiega quindi che gli rincresce di non avere la volontà di imparare a suonare un po’ la chitarra. La sua immagine virtuale mentre suona la chitarra, immediatamente collegata a un grande successo sociale ed economico, gli sembra attraente. Nella vita diventata supermercato, comprerebbe volentieri quel prodotto: e, tuttavia, gli rincresce che non esista un modo più “simpatico” per possedere quelle competenze, quei “moduli”. Perché per lui, come per la maggior parte dei giovani della sua generazione, essere cantante o attore è innanzitutto l’espressione di una serie di “competenze” che si potrebbero acquisire, ovvero comprare: Henri si vive come una sorta di hardware sul quale poter installare qualunque tipo di software.
Di fronte a un paziente come Henri, messo a confronto con un comportamento di fallimento permanente, è utile interrogarsi sulle cause endogene del suo stato, derivanti dalla sua storia personale. Lungi da me, in effetti, l’idea di negare i fattori legati in modo particolare alla vita personale e famigliare del paziente. Sono tuttavia convinto che il suo caso rifletta, come quelli di molti altri giovani e meno giovani […], il movimento brutale e radicale della postmodernità, nella fattispecie la decostruzione, o la distruzione, dell’interiorità dell’uomo (o della donna) della modernità.
[…]
Questa disarticolazione dell’individuo della modernità potrebbe apparire come una pura dispersione. In effetti, il modo in cui la medicina modulare tratta la sofferenza contemporanea sembra corroborare la realtà di questa disintegrazione: una molecola per la depressione, un’altra per l’iperattività e via di seguito. Tutto sembra indicare che la decostruzione del modello specifico di individuo della modernità ci mette di fronte a funzionamenti sparsi, trattati in modo isolato, al punto che l’articolazione della totalità appare come una dimensione separata dal funzionamento. Unificato attorno alla figura psichica e corporea, l’individuo moderno era studiato e compreso come una serie di meccanismi convergenti, dinamici ed evolutivi.
La medicalizzazione della vita non si rivolge ormai più a quel tipo di unità, ma si preoccupa di meccanismi e di processi trans-individuali: tutto è questione di statistiche, rischi, profitti, costi, percentuali e possibilità, che determineranno la diagnosi e la cura, venendo a confermare il fatto che nessun punto di vista totalizzante (o per lo meno centralizzatore) può comprendere il fenomeno del vivente. Ma ciò non è che apparenza. In realtà, quando i nostri contemporanei si lamentano (a giusto titolo) di non essere considerati come unità singolari, ma trattati come degli aggregati e dei meccanismi, non denunciano che una metà del dispositivo. Questa disgiunzione dell’unità biologica e dell’unità psichica è in effetti riordinata, ristrutturata attraverso l’appropriazione di quei moduli da parte dei macro-organismi economici e produttivi (che sono le grandi multinazionali e le organizzazioni sovragovernative che costituiscono il cuore della globalizzazione, come l’Ocse, il Fmi o l’Unione europea).
L’essere umano, che a forza di scomporre e rendere trasparente la natura ha finito per scomporre se stesso, è oggi catturato, “a pezzi”, dalla macroeconomia come “risorsa umana”. Un termine che esprime molto chiaramente l’accostamento razionale all’essere vivente attraverso “moduli” utili all’economia. Per esempio, solo alcuni funzionamenti utili del cervello interesseranno una certa impresa che catturerà solo quelle parti, evitando l’interferenza di altre parti del corpo e della singolarità della persona. Si può credere che l’operaio alla catena di montaggio taylorista rappresentasse già l’attuale modello delle “risorse umane”. In realtà, il contesto epocale rendeva possibile il fatto che all’alienazione della forza-lavoro corrispondesse una riunificazione della persona come proletario e membro di una classe sociale. La macroeconomia accelera invece quella disgiunzione per utilizzare, in ogni ecosistema, ciò di cui ha bisogno rifiutando tutto il resto.
La produzione dell’“uomo delle competenze” (che accumula competenze) implica il passaggio da uno che, grazie alla sua storia personale, possiede certe capacità, a un “uomo senza qualità”, superficie vuota che deve fare continuamente tabula rasa della sua singolarità per diventare un “processore di informazioni”, ovvero una quantità di energia amorfa, che può e deve conformarsi agli esoscheletri disposti dalla macroeconomia. Occorre comprendere questa “de-territorializzazione” della vita nella sua profonda e inquietante radicalità. Un’infinità di esempi pone in evidenza il fatto che i bisogni della macroeconomia producono degli “stampi” per l’energia “risorse umane”, una produzione non sostenibile né per l’uomo né per il resto dell’ecosistema. Noi tutti lo sappiamo, ma non siamo disposti a riconoscerlo: in questo modo, il vivente perisce senza che nessun meccanismo di autoregolazione incentrato sulla difesa del vivente possa proteggerlo dalla nuova strutturazione del mondo secondo i diktat delle nuove capricciose divinità dell’Olimpo economico.