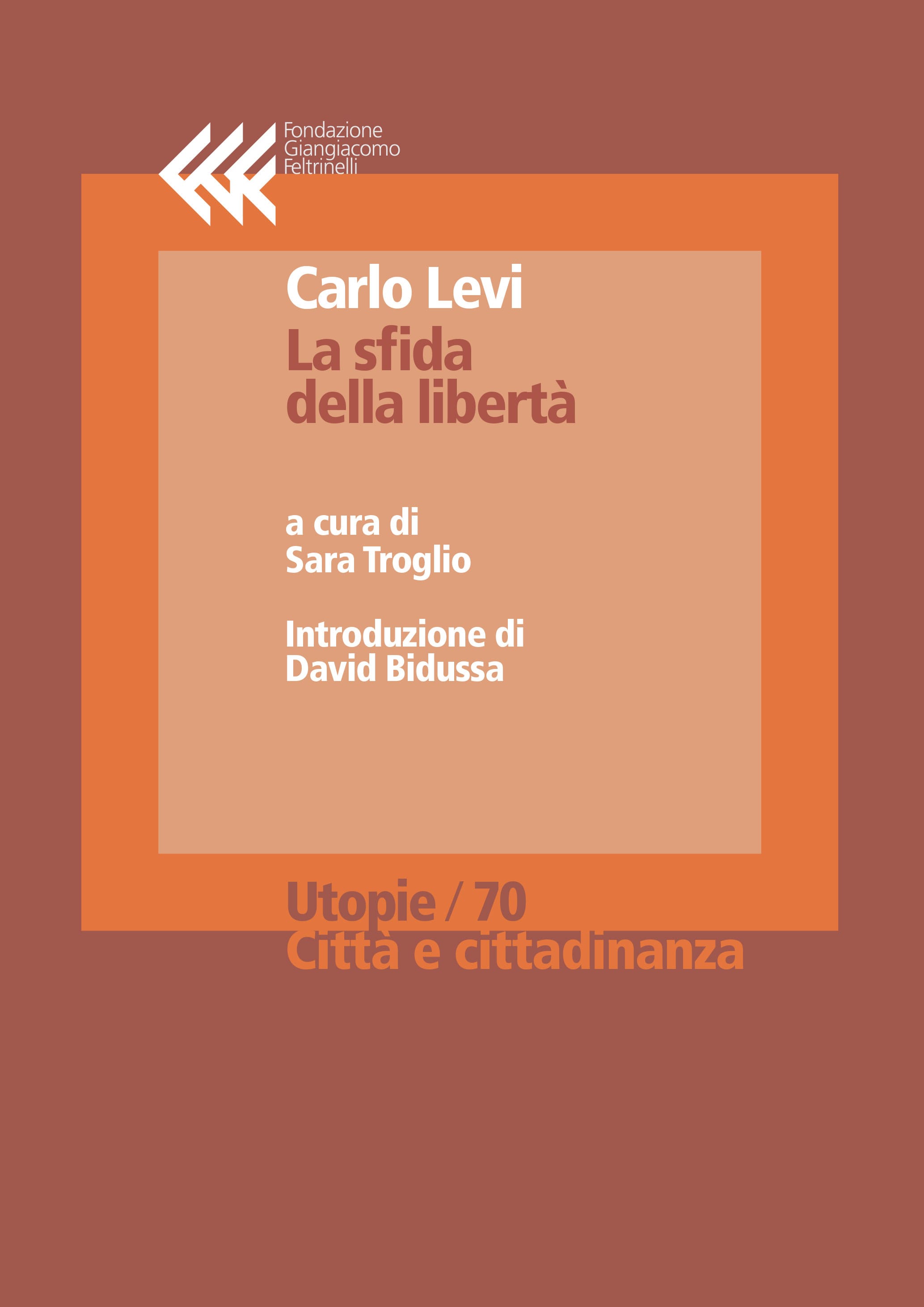La situazione di «isolamento connesso» (ognuno a casa sua, ma tutti tra noi non dispersi, facilmente raggiungibili; certamente ansiosi di dire che “ci siamo”: alzi la mano chi non ha, almeno una volta usato #iorestoacasa), inaugura un nuovo tempo o conferma delle linee prima ancora che comportamentali, emozionali, sensitive, si potrebbe dire, che già c’erano?
Ci sono due tipi di percorsi di riflessione che si possono introdurre: il primo riguarda un’analisi dei modelli comportamentali propri dei tempi dell’emergenza; il secondo riguarda le questioni di comportamenti che diventeranno strutturali, o che si ripresenteranno come nuovo senso comune, come irreversibili una volta che sia risolta l’emergenza e si profili un lento ritorno alla normalità.
Qui provo a proporre due punti che si riferiscono al primo percorso. In merito al secondo forse è ancora troppo presto dire qualcosa. Oppure, forse, non è opportuno precipitarsi a proporre diagnosi.
Dunque i nostri modelli comportamentali ora.
Ci son almeno due questioni che ci riguardano nel nostro tempo presente.
La prima: ora che abbiamo a disposizione molto tempo per noi, prendersi cura di sé rende felici?
La seconda: l’obbedienza è una virtù?
Considero la prima.
Dunque, abbiamo molto tempo per noi. La disponibilità a riflettere è più estesa o ci sembra che riflettere corrisponda a un “tempo morto”? Diversamente: avere la sensazione di vivere in un non tempo rallentato come si concilia con il lavoro a distanza? Perché è indubitabile che l’abitudine ci porta a far equivalere la nostra condizione quotidiana di «quarantena» al tempo di non lavoro, ad associare questo tempo “non scelto” al tempo della vacanza, ovvero a una dimensione di “fuga dalla nostra quotidianità”.
Ora tutti noi sappiamo che la nostra condizione quotidiana rappresenta o aspira a rappresentare il percorso esattamente opposto: l’attuale condizione deve tentare in tutti i modi – con convinzione, con pazienza, ma forse anche con rabbia – di connettere questo tempo sospeso, come tempo della quotidianità, ovvero di farlo coincidere – comunque conciliare – con il tempo di lavoro.
In quel tempo di lavoro, secondo modalità che non sono consolidate, non c’è solo la sfida di velocizzare l’aggiornamento (potremmo dire, parafrasando una stringa pubblicitaria che un tempo ci ossessionava “ce lo chiede la pandemia”), ma forse se smettiamo di guardare solo noi stessi, e valutiamo concretamente che cosa questa condizione ci consente di vedere, scopriamo anche altre cose che danno un senso a un agire che alcuni magari valutano compulsivo, come a non voler prendere atto che meglio fermarsi. Riprendo qui quanto ha scritto Enrico Terrinoni, traduttore, Professore di Lingua e letteratura inglese all’Università di Perugia, per raccontare la sua prima lezione a distanza:
“La nostra paura, con l’allontanamento dalle classi, era di aumentare questa distanza per via del tramite telematico.
E invece… Già alla prima lezione a distanza ho percepito una vicinanza di tipo diverso, un qualche abbattimento delle barriere. Parlare da casa a giovani che sono a casa loro, nel loro habitat, circondati probabilmente da affetti e luoghi familiari, mi ha dato l’impressione di riuscire a stabilire un contatto quasi più intimo, meno mediato”.
È importante non dimenticare questo aspetto, anche se insieme bisogna chiedersi se l’apparente eguaglianza di condizioni di disagio di partenza non si traduca anche in nuova disuguaglianza (in termini di dotazioni private che ciascuna famiglia ha, di risorse informatiche e di connessione che ciascun studente possiede,…). Non riguarda se si obbedisce alla legge o se si trasgredisce, ma implica che cosa s’intenda con il termine “esser parte di una comunità”.
Questione essenziale, connessa con il secondo tema: quello del comportamento collettivo. Ovvero con il tema dell’obbedienza e con l’osservanza anche rigida delle norme.
Nessuno lo dice esplicitamente, ma quello che si avanza è se rimangono ancora gli spazi possibili alla disobbedienza o, se invece, in nome del bene supremo, dell’essere partecipi alla realizzazione del bene generale non sia il caso di mettere da parte la disobbedienza, accantonarla definitivamente.
All’origine sta un punto di scelta, un punto che la storia culturale classica ha fissato in due figure canoniche: da una parte Antigone, dall’altra Socrate.
Antigone, la figura che per antonomasia disobbedisce e fa della disobbedienza una virtù, disobbedienza civile così come lo delinea Hannah Arendt, ma anche come lo invoca Lorenzo Milani. Il tema che legittima la disobbedienza in quel caso parte dal presupposto che il governo ha mancato in un punto e che per riportare l’azione sul terreno di ciò che è il bene pubblico, occorre sollecitare un’azione attiva da parte del cittadino che nel momento in cui viola la legge in realtà non ne propone un’interpretazione a suo vantaggio, ma sottolinea il fatto che il potere è venuto meno a un suo dovere (nella storia italiana lo sciopero dalla rovescia di Danilo Dolci a Partinico il 30 gennaio 1956 non era altro che questo: un richiamo alla messa in atto dell’Articolo 4 della Costituzione).
In questo caso il tema è non riconoscere la legittimità di chi decide. Accanto sta il problema della dignità di chi sa di avere di fronte un potere forte, ma non si piega. Vista da questo lato la legittimità della disobbedienza è essenzialmente dire “io conto”, non solo “io ci sono”.
Socrate, invece, è la figura che evoca l’obbedienza. Il testo a cui mi riferisco è lo scambio di riflessione tra Socrate e Critone nell’opera omonima che Platone ci consegna. Il passaggio è nel Capitolo 12 laddove Socrate dice:
“Ma erano questi i nostri patti, Socrate, o non piuttosto che tu avresti rispettato le sentenze che la tua patria avrebbe emesse?»
E se noi, a queste parole, mostrassimo di meravigliarci, forse, esse potrebbero dirci: «Non stupirti di questo che abbiamo detto, Socrate, ma rispondici, perché, proprio tu, conosci bene il sistema di far domande e di replicare. E allora, che cosa rimproveri a noi e allo Stato, tu che tenti di distruggerci? Che forse non devi a noi, prima di tutto, la tua nascita? Non fummo noi a regolare l’unione di tuo padre e tua madre che poi ti generarono? Rispondi, hai qualcosa da ridire contro quelle leggi che regolano i matrimoni? Non ti vanno forse bene?» Io dovrei rispondere che non ho proprio nulla da rimproverare.
In entrambi i casi il problema è riconoscere se ci sia un primato della legge cui si può rispondere non riconoscendo chi legifera perché non si riconosce legittimità alla sua figura e dunque non ci si sente vincolati, oppure si considera che il funzionamento della legge prescinde da chi governa, perché il principio che ha messo in atto la legge, e il fine, soprattutto, sono condivisi.
In questo secondo caso solo obbedendo si dà possibilità di avere futuro. Ciò non significa ritenere che la riduzione di libertà, il suo regolamento drastico fondato sui limiti della libertà al tempo presente costituisca il fondamento di una società buona e felice, ma è visto come la condizione necessaria per provare a immaginarne e ad averne uno pagando un prezzo che sia il meno sconveniente di tutti perché fondato sul principio preventivo capace di dare condizione preliminare, perché ancora ci sia futuro, per il maggior numero possibile di persone senza discriminare, o «senza scegliere».
In questo caso l’obbedienza assomiglia moltissimo alla sottoscrizione di un patto il cui principio non è la lealtà rispetto alla legge o l’obbedienza, ma la responsabilità collettiva, cui non è estranea ancora una condizione della pratica della disobbedienza civile: quella di non sopire l’attitudine a farsi domande. Ovvero di chiedere prove. Non c’è la firma in bianco di una delega, ma la richiesta di un patto per domani.
In questo caso la pratica di obbedienza è di nuovo l’adesione a un patto di convenienza. Non nasce da una scelta ideologica fondata sull’entusiasmo o volta a sedare il sospetto, ma è la sottoscrizione di un vincolo. A monte delle norme che chiedono a tutti noi di obbedire ci sono molte cose: l’affidamento a ciascuno di noi perché le cose possano funzionare; la condivisione dei dati su cui quella scelta è maturata e dunque la possibilità, obbedendo, di capire e non solo di eseguire. Forse, anche per questo, oggi si potrebbe dire, pur non dimenticando il passato e dunque con cautela, anche se con determinazione consapevole che l’obbedienza è (anche) una virtù.