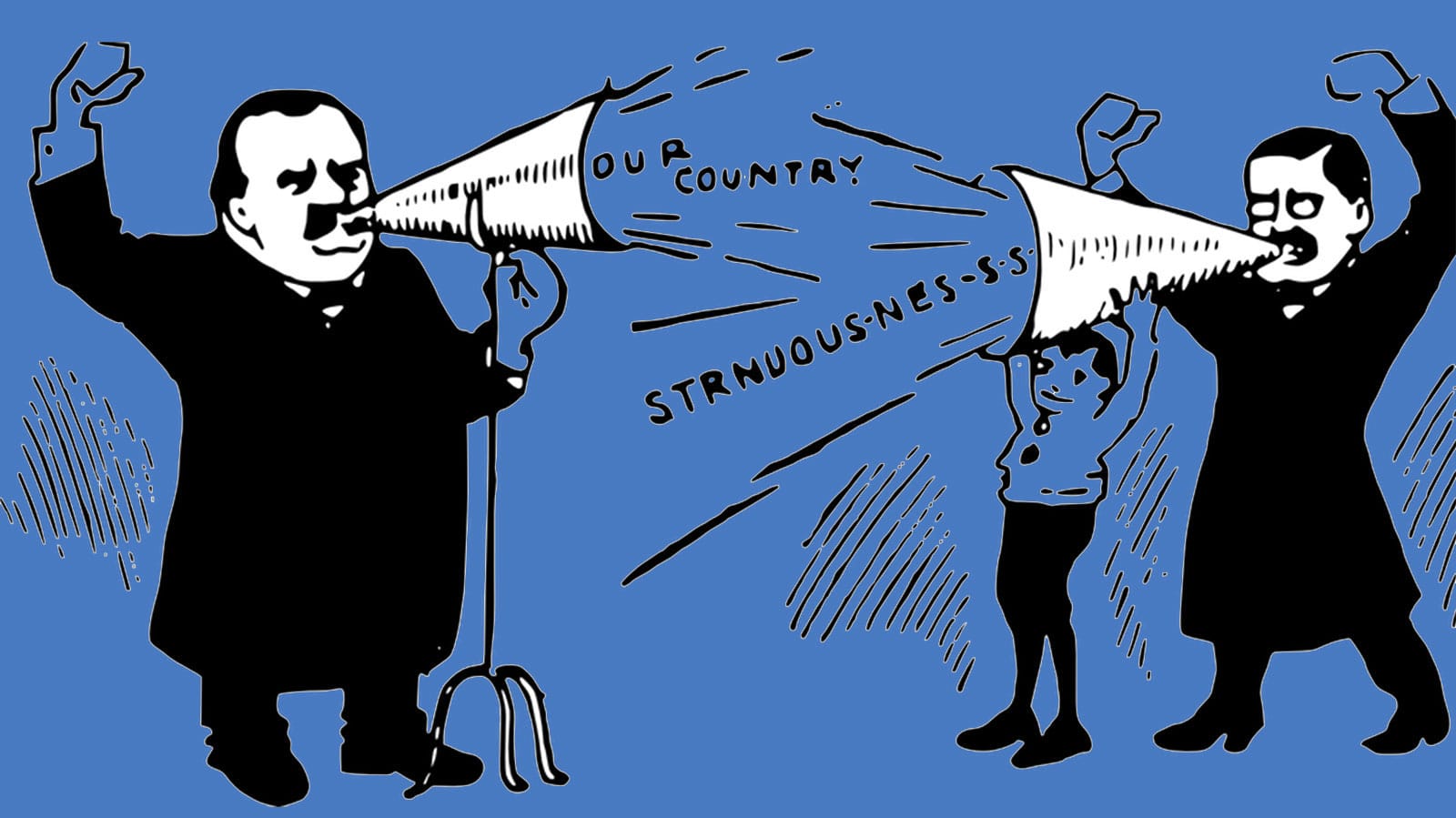La recente pandemia legata alla diffusione del Coronavirus in Cina è un episodio paradigmatico: in un mondo sempre più interconnesso, eventi geograficamente remoti sono in grado di raggiungere in pochi giorni una dimensione globale. La risposta delle popolazioni e delle autorità coinvolte è anche essa indicativa dell’epoca in cui ci troviamo. Da una parte, l’episodio ha creato tensioni e sono emersi episodi di xenofobia contro turisti cinesi, accusati di diffondere il morbo. Politici di destra hanno chiesto di chiudere le frontiere di “aria, terra e mare”. Centri di ricerca, autorità sanitarie di vari livelli istituzionali hanno invece cercato di coordinarsi per trovare una soluzione positiva all’emergenza. Questo caso ci mostra come l’interdipendenza globale sia essa stessa fonte di nuovi problemi e, allo stesso tempo, una possibile soluzione, e può insegnarci qualcosa rispetto alla situazione politica europea.
I conflitti politici che stanno investendo l’Europa e i suoi Stati nell’ultimo decennio hanno, infatti, raggiunto un’estensione ed un’intensità tale per cui non si può più parlare di problemi di ordinaria amministrazione. La geografia di questi conflitti è di per sé stupefacente: dal sovranismo in chiave euroscettica, ai movimenti di indipendenza nazionale (si pensi alla Catalogna o alla Scozia), alle proteste anti-immigrati nelle periferie europee, si fatica a individuare una radice comune a questi fenomeni.
Sembra che l’Europa si trovi in sofferenza cronica: il conflitto politico non è soltanto acuto, ma anche prolungato nel tempo; soprattutto, non se ne vede la fine. Nel dibattito pubblico, molti si sono chiesti perché l’Europa si trovi in condizioni simili. Le risposte a questa domanda generalmente mettono in luce il ruolo che eventi esterni hanno giocato nell’innescare i conflitti: la crisi finanziaria ed economica del 2008, la crisi del debito del 2011, la crisi dei rifugiati del 2015, il cambiamento di politica estera statunitense dall’elezione di Donald Trump. Tutti questi aspetti sono rilevanti e ci aiutano a capire perché l’Europa si trovi in questa situazione di conflitto acuto, ma non spiegano perché non riesca a uscirne. Per capire questo, dobbiamo guardare alle ragioni profonde che hanno permesso a questi conflitti di radicarsi nel sistema politico europeo. Dobbiamo, in altre parole, rovesciare la domanda e chiederci perché gli Stati europei non siano sempre in queste condizioni. Del resto, la storia europea degli ultimi settant’anni è punteggiata da crisi economiche, risentimento sociale dovuto a fenomeni migratori interni ed esterni (basti pensare ai “roghi” neonazisti che colpirono la comunità turca in Germania ad inizio anni novanta), rivolgimenti internazionali, e situazioni fiscali esplosive. Perché, in passato, l’Europa mostrava più resilienza e capacità di risposta a questi problemi?
Nel cercare di dare una risposta a questa domanda, dobbiamo guardare a quelli che erano gli elementi di stabilità nel sistema di Stati-nazione. Già David Hume, nei “Saggi morali e politici”, guardava meravigliato a come “i molti”, i ceti popolari, fossero governati dai “pochi”, le élite dei governanti. L’elemento che stabilizzava il governo dei pochi non poteva essere la forza, per una questione puramente numerica. I governanti, secondo Hume, non avevano dalla loro parte che un sistema di credenze, a cui i governati si sottomettevano volontariamente rendendo stabili le istituzioni di governo. Questo sistema di credenze, secondo il politologo francese Yves Mény, si è andato strutturando sempre di più negli ultimi due secoli, creando una forma istituzionale straordinariamente stabile e resiliente, quella dello Stato-nazione. La ricetta del successo dello Stato-nazione si compone di tre elementi. Il primo è quello della sovranità popolare: la fonte del potere sovrano è il popolo, da cui ogni legge viene fatta discendere. Il popolo, però, è un elemento estremamente instabile: leader politici potrebbero intercettare il malcontento popolare rivendicando di rappresentarne la “voce”, istigando i “molti” contro le élite di governo. In questo senso, un secondo elemento che serve a dare la necessaria stabilità alla volontà del popolo sovrano è lo Stato, e l’insieme di istituzioni che lo compongono. Queste hanno, tra le altre cose, lo scopo di limitare la sovranità popolare: il popolo è sì sovrano, ma la sua volontà deve rispettare un insieme di regole che la imbrigliano e la frenano. Per ultimo, vi è il concetto di “nazione”. Fornisce, da una parte, un limite all’espansione delle istituzioni dello Stato, che cominciano ad identificarsi con i confini della comunità nazionale; dall’altra, fornisce una direzione alla volontà del popolo: questa deve seguire gli interessi della nazione, che dovrebbero essere interpretati da élite di governo. I tre elementi, presi separatamente, sono esplosivi: il popolo può diventare populista, lo Stato può diventare autoritario, il culto della nazione sfocia nel nazionalismo. Presi assieme i tre si stabilizzano a vicenda, e col tempo, creano un terreno fertile per la democrazia rappresentativa, che permette al corpo dei cittadini di partecipare indirettamente alla formazione delle decisioni di governo. Nelle giuste condizioni economiche, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, questo ha permesso di avere sistemi politici relativamente stabili e benessere economico diffuso ad ampi strati della popolazione. L’inizio del processo di integrazione europea, con il trattato di Roma del 1957, assecondava questo regime e allo stesso tempo permetteva agli Stati europei di creare cooperazione nello sviluppo economico che andasse oltre la sfera nazionale. Cos’è cambiato rispetto a questo quadro?
A partire dalla fine degli anni settanta, le economie degli Stati europei sono diventate progressivamente sempre più integrate ed interdipendenti. Se già la globalizzazione dei mercati stava iniziando a ridurre le possibilità dello Stato-nazione di governare autonomamente la sua sfera economica, in Europa questo processo è stato accelerato da decisioni come la creazione del mercato unico (1986) e della moneta unica a partire dal 1992. Sia chiaro: queste decisioni servivano a tutelare gli interessi degli Stati europei in un ambiente economico internazionale che stava diventando sempre più tumultuoso e anomico. Ma un’unione economica e monetaria senza un’unione politica e sociale ha finito per intaccare l’autonomia decisionale degli Stati nazionali e dei popoli europei. L’amalgama di Stato-nazione-popolo consentiva di delimitare il potere politico, e dare indirizzo alle decisioni di politica pubblica attraverso la volontà popolare. Con l’apertura dei mercati e l’integrazione monetaria, scelte di politica economica estremamente significative sono sfuggite al controllo dello Stato-nazione europeo. Questa “fuga” di potere politico ha preso due direzioni. Da una parte, molte delle decisioni di politica economica sono state delegate a istituzioni sovranazionali, come la Banca Centrale Europea. Nel contempo, l’accresciuta interdipendenza economica ha fatto sì che molte decisioni, come quelle sul debito, debbano rispettare regole volte a garantire la stabilità fiscale dell’Unione Europea. In questo senso, gli Stati sono chiamati a bilanciare i loro interessi con quelli degli altri Stati Membri, riducendo l’ambito in cui il “popolo” può prendere decisioni sovrane. Slogan come “non c’è nessuna alternativa” “ce lo chiedono i mercati”, hanno recentemente sottolineato questa realtà politica.
Dall’altra parte, sempre maggiore potere politico ed economico si sta spostando verso ambiti di governo regionale (o sub-statale). Lo Stato-nazione in passato offriva protezione (militare ed economica) e possibilità di sviluppo ai territori che lo componevano, esercitando così una forza d’attrazione che lo rendeva estremamente coeso al suo interno. Con l’integrazione dei mercati, la libertà di movimento offerta dall’Unione Europea, e non ultimo, il lungo periodo di pace tra Stati europei, lo Stato-nazione ha perso mordente nel suo ruolo di intermediario. Con la scomparsa dei confini e dei dazi nazionali, molte regioni che prima erano integrate quasi esclusivamente nell’economia dello Stato-nazione hanno ora accesso diretto ai mercati di altri Paesi europei, e sono diventate nodi centrali nella fitta rete di commerci che si è instaurata all’interno del Mercato Unico. Gli investimenti pubblici nelle regioni periferiche passano sempre più da strumenti finanziari e politiche europee — basti pensare alla politica di coesione dell’UE, che negli anni della crisi ha rappresentato l’80% degli investimenti pubblici in Paesi come Portogallo e Ungheria. Questo contesto ha costituito un terreno fertile per movimenti secessionisti in ogni parte d’Europa.
Entrambi questi fenomeni, governance economica europea da una parte e nuovo regionalismo dall’altra, stanno trasformando profondamente il modo di funzionare degli Stati europei. Politologi come Liesbet Hooghe e Gary Marks hanno parlato di “governance multilivello” per catturare il senso di queste trasformazioni. Da una parte, la “governance” consisterebbe nel fatto che molte delle decisioni non coinvolgono più il potere di coercizione dello Stato ma sono basate su accordi risultanti da negoziazioni internazionali. Queste negoziazioni ed accordi sono “multilivello”, coinvolgono cioè un numero sempre più complesso di attori: una “lasagna” di livelli istituzionali che vanno dall’ambito comunale, a quello regionale, nazionale ed europeo e che devono negoziare tra di loro per implementare (e a volte decidere) le politiche pubbliche. Se prima la legge dello Stato bastava a tenere insieme l’ordine territoriale, oggi il quadro è molto più complesso. Nel contempo, la democrazia nazionale non basta più per prendere decisioni politiche significative.
All’interno di questo quadro, la “sospensione dell’incredulità” che è necessaria a credere a concetti come “popolo sovrano”, “nazione” — già chiamata dal politologo Benedict Anderson “comunità immaginata” —, per non dire “Stato” (specie nei territori periferici), è sempre minore. Non sembra un caso che un partito come la Lega, in precedenza secessionista, in tempi recenti si sia riscoperto “sovranista”: facendo leva sul bisogno di stabilità economica e politica da parte di larghe fasce dell’elettorato, i sovranisti cercano di soffiare nuova vita in concetti che in passato avevano garantito un ordine stabile e duraturo. Come il caso del Coronavirus ha mostrato esemplarmente, la politica populista, davanti a fenomeni complessi, cerca la soluzione più intuitiva: chiudere le porte cittadine, individuare gli untori. Si cerca in questo modo di tenere il “male” fuori dalla comunità, cercando di ricostruire i margini che globalizzazione ed integrazione dei mercati hanno spazzato via. Ma si tratta pur sempre di una restaurazione. Come non ci si bagna mai due volte nello stesso fiume, così lo scorrere della storia ha mutato le condizioni che garantivano la stabilità e la relativa autonomia dello Stato-nazione. Il passato può offrirci una migliore comprensione della situazione in cui ci troviamo, ma le risposte ai problemi correnti andranno trovate guardando in avanti, considerando come una comunità allargata, per quanto debba far fronte a problemi più complessi, dispone anche di risorse cognitive ed organizzative per farvi fronte.
In collaborazione con
L’articolo si inserisce nel contesto del progetto SOLID finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca con il programma H2020, grant n. 810356