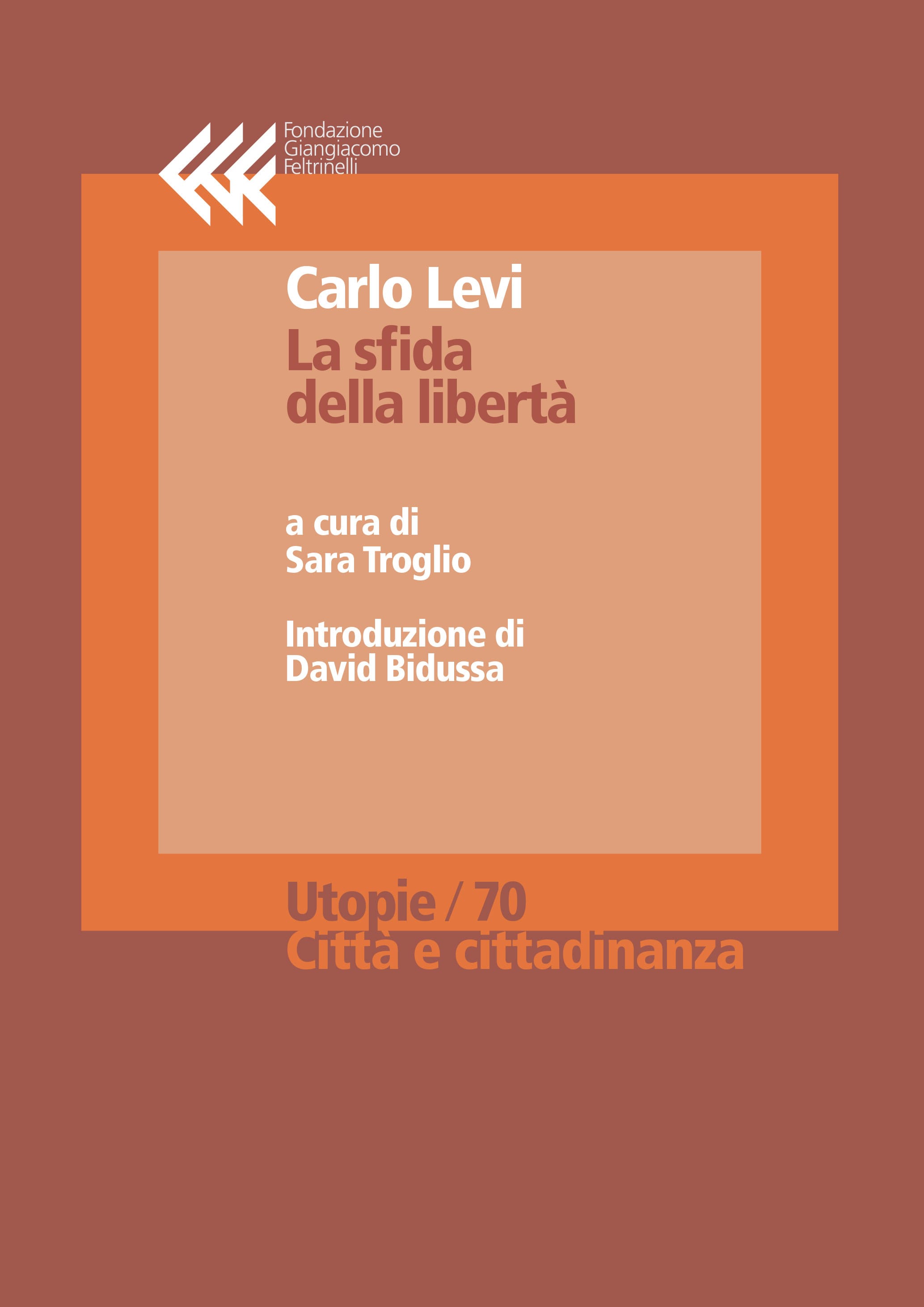Di seguito si propone l’introduzione di David Bidussa all’eBook La sfida della libertà a cura di Sara Troglio, tratto dal testo di Carlo Levi Paura della libertà pubblicato nel 1946.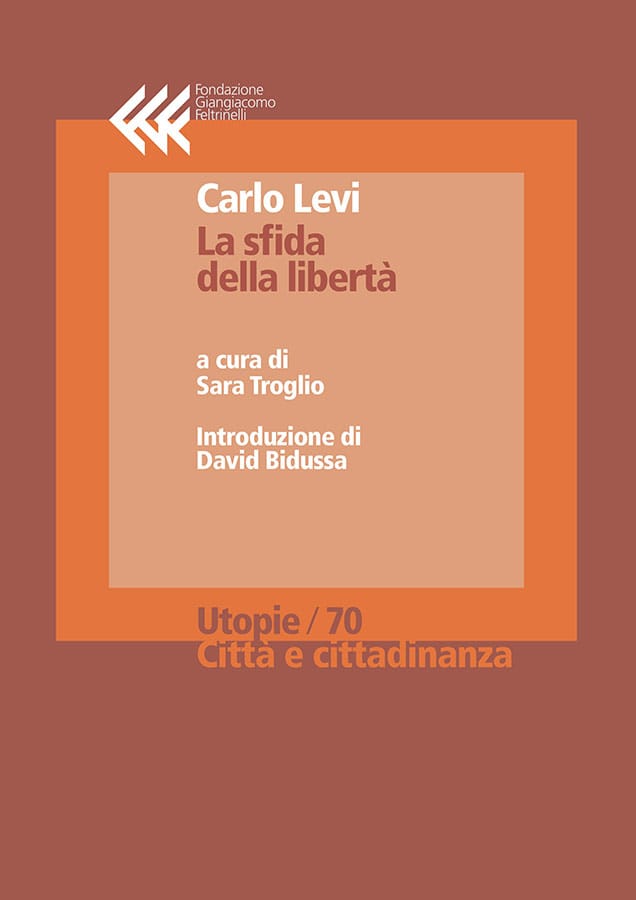
Quando l’uomo è ridotto a massa bruta e amorfa,
quando è spenta la libertà, non vi è posto per lo Stato.
Esso perse ogni esistenza reale,
e divenne un idolo mostruoso,
il vitello d’oro a cui ci si rivolge adorando quando si è stanchi.
Carlo Levi 1944
1 – La prosa morale e civile non ha mai avuto una grande fortuna nella discussione pubblica italiana. Ci sono testi che a lungo sono rimasti sotto traccia: spesso solo un’operazione culturale volta all’uso pubblico del loro contenuto ha fatto sì che essi improvvisamente emergessero per imporsi come testi contemporanei, come strumenti capaci di esprimere efficacemente – con le parole, le metafore e l’immaginario che mettono in moto – le ansie, i dubbi, i temi del momento.
È accaduto così, per esempio, a Saggio sullo stato presente dei costumi degli italiani, di Giacomo Leopardi. Testo inedito fino a che non è stato proposto in una prima raccolta di pagine sparse di Leopardi nel 1906, rimanendo a lungo nel limbo e imponendosi come lettura imprescindibile solo alle soglie degli anni della crisi della Prima Repubblica. Lo stesso è accaduto per Della dissimulazione onesta, di Torquato Accetto, scritto intorno al 1640 e rimasto in clandestinità fino al 1928 quando Benedetto Croce lo propose in un’edizione numerata per gli amici come test di prova per inserirlo poi nel 1930 nella sua raccolta dedicata ai trattati di morale del Seicento nella serie «Scrittori d’Italia» di Laterza. Testo che «torna a inabissarsi» negli anni del fascismo-regime, per riproporsi nell’Italia della crisi del fascismo tra 1942 e 1943. Gli anni dell’impegno lo sommergono di nuovo, fino alla crisi della Prima Repubblica, quando torna ad essere un libro del nostro tempo a partire dal 1994.
Lo stesso si può dire per Paura della Libertà di Carlo Levi. Carlo Levi lo scrive nel 1939 per pubblicarlo nel 1946. Nel 1964 ne propone una nuova edizione, che come la precedente non ha molta fortuna. Nel 1975, in seguito alla sua morte, Giulio Bollati, uno che sulla prosa morale e civile in Italia ha scritto pagine di grande spessore [Bollati 1997], lo ripropone nella collana “Reprints Einaudi”, ma anche allora rimane nel limbo. Un libro che «cade tra le seggiole», ancora una volta. Forse la scommessa della nuova edizione di questo testo [Levi 2018], su cui invita a riflettere Riccardo Gasperina Geroni [2018] o parallelamente, anche se con diversi percorsi interpretativi, Giorgio Agamben, daranno a Paura della libertà una nuova chance. Non è detto, perché alla fine un autore difficilmente riesce a scalzare il senso comune che lo vuole cantore di un mondo verso cui rimane il fascino del primitivo, dell’incontaminato (altro mito profondamente radicato nella nostalgia di passato che innerva il pensiero corrente). Paura della libertà è un testo che si colloca agli antipodi di questo sentimento. E anche per questo forse risulta così eccentrico rispetto al senso comune che vuole Carlo Levi coincidente con Cristo si è fermato ad Eboli. La conseguenza è che Paura della libertà è un libro che è rimasto marginale nello scaffale dell’italiano medio, anche di quello politicizzato.
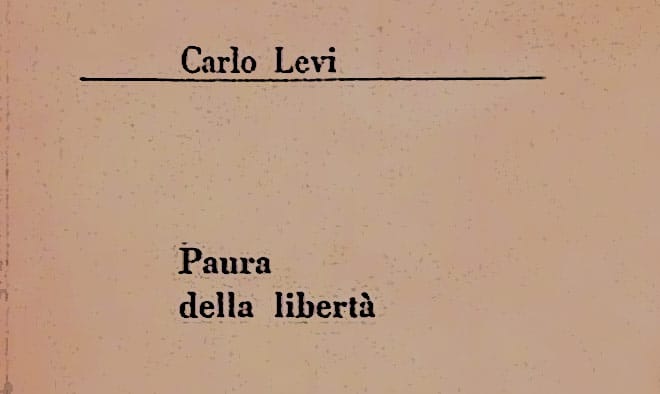
Paura della libertà, Carlo Levi, 1946
2 – Nell’inverno 1939-40, alla fine dell’Europa, con alle spalle il mare e di fronte un continente sempre più nazificato, Carlo Levi si confronta con la Storia, seguendone il filo fino “al punto inesistente da cui nasce ogni cosa” [Levi 1975, p. 10].
Come scrive nel 1946, quando finalmente decide di pubblicare quelle note che appartengono a una stagione ora lontana, quello stato d’animo non era stato un inganno e quelle note e riflessioni non appartenevano a un tempo finito. Quel testo, invece, è uno stimolo, un modo per tornare a fare i conti con una condizione che riguardava il prima, ma che la nuova situazione di fine dell’oppressione non ha cancellato. L’atto di liberazione non è la libertà, ma solo la sua premessa, come molti anni dopo avrebbe scritto Hannah Arendt [Arendt 1983, pp. 25-26] Quella condizione, per divenire libertà, deve fare i conti con ciò che all’origine del fascismo ha generato la domanda di schiavitù.
“In quel punto della vita dove non si può più guardare indietro, mi trovavo solo su quella spiaggia deserta, in un freddo autunno, pieno di vento e di piogge. Se il passato era morto, il presente incerto e terribile, il futuro misterioso, si sentiva il bisogno di fare il punto” [Levi 1975, p. 10]. Il tema non è solo quello del bilancio, ma anche quello della diagnosi. Ciò che emerge è una dimensione del vissuto della politica non più come missione, bensì come condizione di sudditanza, come macchina in cui la personalità e il profilo individuale tendono a eclissarsi per affermarsi solo come gerarchia di figuranti.
Nel 1946 non si trattava di prendere le distanze dalla una diagnosi errata – quella di aver perso per sempre il mondo di ieri, ma di recuperare quella «disperazione» per pensare profondamente al domani. “Per difendersi – scrive Levi nel 1946 – gli uomini dovevano accettare questa aridità della strage, abbandonare le case e le famiglie, buttarsi dietro alle spalle tutto quello che erano stati… ” [ibidem]
Del resto, che quella riflessione non rappresenti l’esito di una disperazione, ma indichi una condizione profonda con cui fare radicalmente i conti al momento del crollo del fascismo, è dimostrato da come Carlo Levi insista su questo tema allorché si trova nella condizione di intervenire pubblicamente nella discussione politica, nei giorni stessi della liberazione.
“La paura della libertà è il sentimento che ha generato il fascismo”, scrive nel novembre 1944 nel quotidiano “La Nazione del Popolo” in un editoriale dal titolo appunto Paura della libertà [Levi 2004, p. 75]
E poche settimane prima, aveva scritto
Il nazismo (e il fascismo, suo corrotto e compromesso equivalente nostrano) fu uno scoppio di forze irrazionali, in un mondo troppo meccanizzato. Il suo motivo fondamentale fu la paura elementare, la paura dell’uomo, che è nell’uomo, la paura della libertà. Dopo un secolo di «progresso», una stanchezza mortale si impadronì degli uomini; e una guerra mondiale li mise, impreparati, a contatto col perduto, oscuro mondo del sangue e della morte. La libertà parve realmente ritrarsi dalla vita europea, imbarbarita o isterilita. Il concetto di popolo, che è infinita differenziazione creativa, si mutò in quello di massa, che è primitiva indistinzione passiva. Lo Stato si fece Stato di massa, vale a dire rinnegò la propria esistenza; si fece totalitario, cioè si staccò dagli uomini, e non tollerò la persona umana. [Levi 1944. I corsivi sono nel testo]
3 – Ha ricordato Alfonso Berardinelli come la prima caratteristica dello storico sia la presbiopia. Per cui “Le cose, da vicino, non sempre si capiscono. Se ci si allontana e lo sguardo si allunga, più che le folla degli eventi, appaiono i fenomeni di lunga durata. Gli storici degli avvenimenti sono ispirati dalla passione politica. Gli storici della «lunga durata» si appassionano all’antropologia, ai caratteri dei popoli, ai paesi” [Berardinelli 2013].
Paura della libertà è un testo che soddisfa pienamente questa condizione. Perche pone due diverse questioni. La prima: che ce ne facciamo di uno sguardo sulla storia? La seconda: come si scava nel passato e con quali strumenti?
Procediamo con ordine.
Prima questione: avere uno sguardo sulla storia per Fondazione Giangiacomo Feltrinelli – riprendo e cito quanto ha scritto Massimiliano Tarantino in occasione della II conferenza di AIPH, è chiedersi che cosa sia e perché sia rilevante la storia pubblica.
Ci sono molti percorsi per rendere la storia un sapere non solo condiviso, ma appunto pubblico, ovvero una risorsa che non è solo una sequenza di dati o di fatti, ma un modo di leggerli, di scavare intorno, di ricostruire la scena, il vissuto, i sentimenti, in breve il senso del vivere in un tempo, magari anche lontano dal nostro, ma che ci racconti di come quel vivere sia stato un processo per dare senso al presente di allora. Entrare in contatto con quei sentimenti, anche talvolta con sensazioni che non condividiamo è uno dei modi per comprendere le nostre difficoltà di oggi, di intraprendere un percorso in cui scavare nelle proprie emozioni – di gioia, di timore, di panico, di smarrimento, o di sorpresa – è un percorso in cui facciamo emergere i molti percorsi in cui uomini e donne, individualmente o insieme, anche confliggendo, hanno dato di volta in volta senso al proprio vivere, ma anche compreso dove stavano gli inganni, le incomprensioni, gli errori.
Questo modello, prosegue Tarantino – per noi è la Storia Pubblica, nella sua sfaccettatura di memorie, nella sua condivisione di saperi e conoscenze, nella sua costruzione e decostruzione continua: sempre sulla base del principio che essere cittadini significa conoscere e partecipare, non desistere dall’idea che si possano cambiare le cose.
Tutto questo sforzo tende ad un unico, ambizioso obiettivo: quello di riannodare i fili che legano l’oggi in cui siamo immersi allo ieri che ci ha preceduti, per dare alla vita sociale e alla proposta politica una profondità e una limpidezza di sguardo necessaria al suo svolgersi.
Seconda questione: come si scava nel passato e che cosa si va a cercare?
Per far questo, riteniamo che ci siano testi, e scene da interrogare non per saperne di più, ma per capire meglio come altri prima di noi abbiano affrontato una condizione di crisi, riscoprendo a quale filiera appartengano le nostre domande e i nostri punti interrogativi d’oggi, provando a comprendere se quelle diffidenze, siano un prodotto del nostro tempo, una «novità» o se, invece, presentino «assonanze», «facciano rima» con il presente vissuto da altri prima di noi.
Il tema della scoperta o della ri-scoperta della dimensione politica si innesta infatti intorno alla questione dell’autonomia. E’ un tema che Levi sottolinea nel 1932 nei “Quaderni di GL” in un intervento steso con Leone Ginzburg [Levi 1932b], che riprende nella chiusa di Cristo si è fermato a Eboli, [Levi 1990, pp. 219-223] e che ripropone nel 1960 dopo i fatti di Reggio Emilia. [Levi 1960].
Il problema per Levi non è la riforma dello Stato, ma la fondazione del cittadino libero. Questo tema, peraltro, nella riflessione politica di Levi non costituisce una novità, ma è già lucidamente presente fin dagli anni ‘30 nelle sue riflessioni sul carattere coercitivo dell’attività sportiva come controllo del potere sul corpo dei “cittadini/sudditi” [Levi 1934a]. L’ombra lunga di questa riflessione è quella che sta nel capitolo «Masse» di Paura della libertà.
Sarebbe, dunque, un errore considerare Paura della libertà solo una riflessione astratta
Tutta la riflessione sulle autonomie, ma anche sulla comunicazione cinematografica, sul deficit linguistico del cinema italiano [Levi 1934a], sulla dimensione dello sport come pratica inclusiva e distruttiva della personalità, come scenario falsificante [Levi 1934b], nonché sull’intellettuale di regime quale emerge dalle note dedicate a Malaparte [1932a], che egli sembra stendere in forma rapsodica e «sparsa» nel corso degli anni ’30, trova improvvisamente un luogo riflessivo in quel quaderno di appunti, scritto con la disperazione del promemoria per una generazione che non si conosce e per un futuro in cui si spera ma di cui non si intravede inizierà a prendere forma.
La percezione di Carlo Levi in quegli anni – in presenza di un regime che gode di un largo consenso e che si accredita come potente – è che il fascismo, a dispetto di ciò che propaganda e ripete, non sia che l’epifenomeno della crisi. Di una crisi, tuttavia, che più che i segni del disastro economico, ha quelli della dimensione sacrale e sacrificale della politica e dello Stato: della sacralizzazione della «ragion di Stato».
Le riflessioni di Paura della libertà nascono da questo scenario, ma non parlano solo di allora. Dialogano anche con il nostro smarrimento d’oggi.

Manifestazione politica, Podemos, 2017
4 – Capiremmo ben poco di quelle pagine se non le collocassimo in un contesto complesso. Quando Levi stende le sue note in una sorta di finis terrae che potrebbe accomunarlo alla condizione di Benjamin in fuga disperata verso la Spagna nel settembre 1940, la scena del mondo è estremamente confusa. Lo spazio della critica e della riflessione autonoma a sinistra si è di fatto azzerato. Sono i mesi del patto Molotov-Ribbentrop, del fallimento della Conferenza di Evian che evita di prendere una soluzione sul problema dei milioni di profughi che iniziano a circolare in Europa – vittime dei propri totalitarismi che li vogliono «schiavi», «cittadini di Serie B», quando non pensano già di sterminarli – dello smarrimento seguito alla firma del patto di Monaco: uno smarrimento morale, prima ancora che politico come non manca di sottolineare Victor Serge [1999, p. 427 e sgg.].
È indubbio che nella stagione dell’incertezza, nell’illusione del «rinvio», secondo un’immagine di grande efficacia sintetizzata da Sartre, Carlo Levi trasponga in Paura della libertà la sensazione di una grande solitudine, di un’assoluta fine della civiltà, di un trionfo della barbarie cui pochi sono in grado di sottrarsi.
Paura della libertà ha i tratti della radiografia lucida intorno all’alienazione collettiva e alle condizioni – culturali, psicologiche, mentali ed emozionali – dell’Europa in un momento altamente drammatico della sua storia. Un testo che è composto nei mesi incerti della «drôle de guerre», nell’inverno tra il 1939 e il 1940, quando Europa significa «Nuovo Ordine Europeo» scandito al ritmo dell’espansione del nazismo su tutto il continente e le parole “autonomia” e “federalismo”, almeno nel contesto della Francia – costruzione politica fondata sull’idea e sulla pratica del centralismo amministrativo – acquistano i toni e gli aspetti della nostalgia passatista, dell’ordine gerarchico patriarcale, del fascino etnocentrico per il culto localistico.
E tuttavia quelle pagine non sono solo il termometro del terrore e della nuova barbarie. Carlo Levi ha meditato lungamente queste immagini in cui esprime l’arcaicità dei rapporti umani e la subalternità degli individui a un sistema. In esse si riflettono gli scenari e i sistemi di relazione di una società quale quella che egli descrive, sei anni dopo e in tutt’altra condizione, nelle pagine di Cristo si è fermato a Eboli. Non solo, esse traducono, o ritraducono, temi e argomentazioni che circolano nella cultura della crisi che poggia sulla sacralizzazione della forza, sulla vittimizzazione di se stessi e sul riversamento su un nemico le responsabilità del proprio tempo. Una condizione che costruisce una convinzione che si irrora di una religione della morte, che trova sicurezza nella possibilità di garantire il proprio presente e avere una chance di futuro solo se su altri si scarica il costo della crisi. Una politica della ricerca della salvezza che ha come presupposto imprescindibile la criminalizzazione del dissenso, la costruzione di muri, la convinzione che il domani sicuro non sia per tutti. Una scelta che implica affidare se stessi allo Stato totalitario, laddove con questa espressione, scrive nell’ottobre 1944, intende “il più potente degli idoli [perché lo Stato totalitario] è figlio dello spavento, annulla la persona nella «massa», e gli uomini l’adorano per dimenticarsi, per liberarsi di sé e della propria individuale paura” [Levi 1944b]. Una condizione scrive all’inizio di novembre 1944, questa volta riecheggiando e autocitandosi implicitamente da Paura della libertà,che indica che cosa sia essere servi.
Per chi ha l’animo di un servo, la sola pace, la sola felicità è nell’avere un padrone; e nulla è più faticoso e veramente spaventoso del’esercizio della libertà. Questo spiega l’amore di tanti schiavi per Mussolini: questa mediocrità divinizzata, necessaria per riempire il vuoto dell’animo e colmarne l’inquietudine con un senso di riposante certezza. Per chi è nato servo, abdicare a se stesso è una beatificante necessità [ora in Levi 2004, p. 75. Il corsivo è mio].
5 – C’è un aspetto di Paura della libertà che non emerge immediatamente e che merita, invece, di essere sottolineato in un’epoca di apparente disincanto per la dimensione politica pubblica quale quella che noi oggi viviamo.
Nella descrizione del rapporto tra cittadino e Stato – ma più correttamente si potrebbe dire tra potere e suddito – che Levi pone indubitabilmente al centro di quelle sue pagine, si colloca la denunzia di un eccesso della politica proprio sulla base e in forza di una sua spoliazione, ovvero in relazione e in conseguenza di una depoliticizzazione dell’individuo. Non è l’unico paradosso su cui Levi lavora, ma è uno dei tanti ossimori che è bene tenere a mente. È il filo tenue, ma tenace su cui si innesta la riflessione sul tema delle autonomie e su cui si esprime la continuità forse più autentica tra il quadro opprimente di Paura della libertà, le pagine di Cristo si è fermato a Eboli e il resoconto amaro de L’Orologio.
Ma per certi aspetti è anche il filo che si consegna a noi, qui e ora.
La paura è un grande tema politico. Noi siamo usciti dal XX secolo ritenendo che il racconto dell’orrore fosse il viatico migliore per costruire cittadini più consapevoli, anzi per fare in modo che uomini e donne divenissero primariamente cittadini consapevoli.
Se consideriamo la nostra quotidianità si dovrà rilevare, forse con amarezza e non senza un certo disagio, che l’orrore e la sua narrazione non insegnano nulla. È la paura, invece, questo grande tema barocco su cui si costruisce la dimensione della politica quale noi oggi la conosciamo, che costituisce la macchina generativa del potere. Un potere che proprio mentre denuncia i mali della politica e tenta di accreditarsi attraverso l’offerta di protezione salvifica, riconferma il carattere alienante ed espropriatore della decisione politica. Non è forse questo il linguaggio che quotidianamente caratterizza il nostro tempo ora? È la paura, il collante che va rimosso per liberare la politica, diversamente per restituire lo scettro al cittadino. Ma anche per invitarlo a divenire nuovamente cittadino.