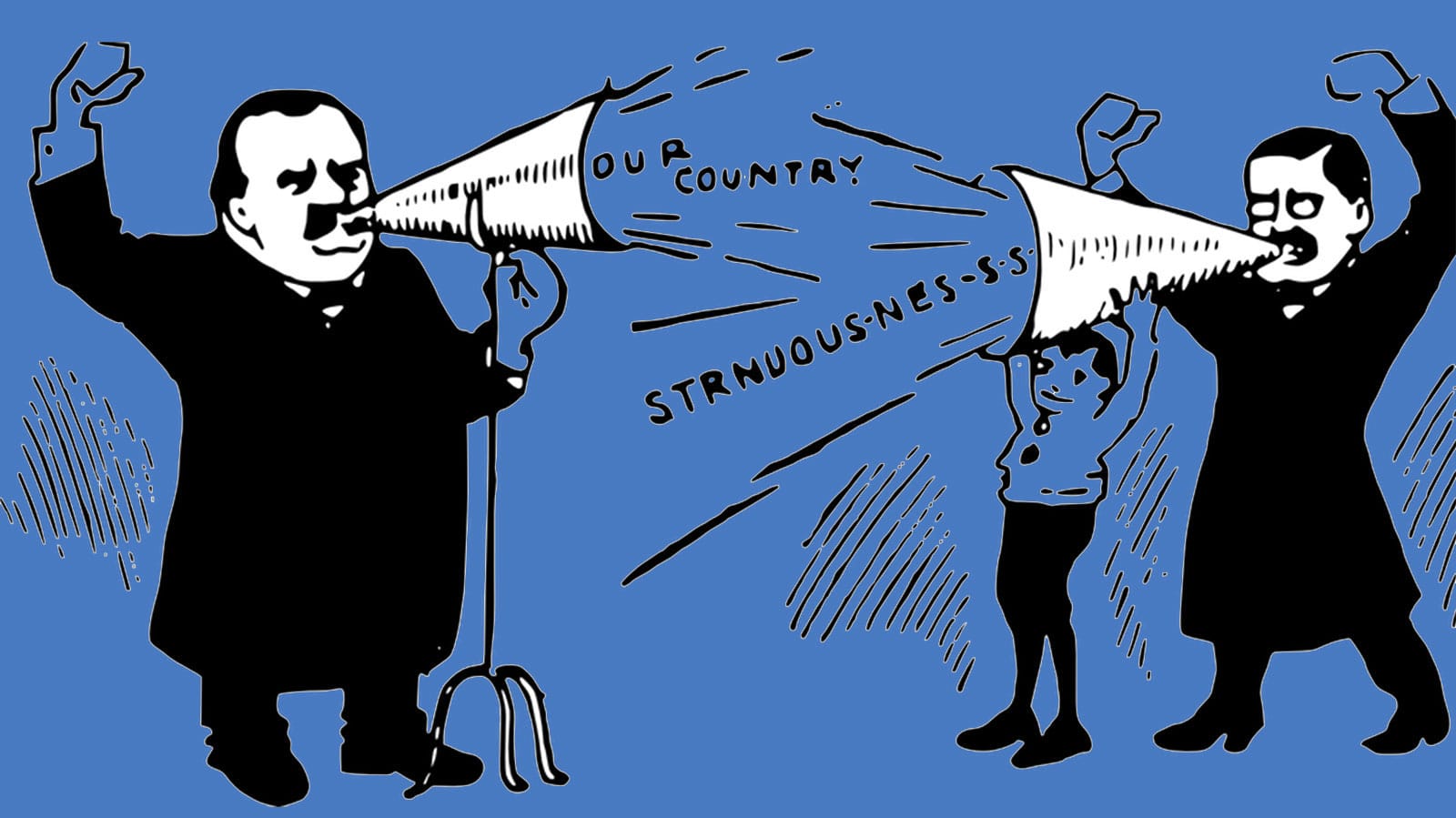Nella discussione sulle motivazioni che hanno spinto una fetta rilevante dell’elettorato a spostarsi su posizioni più radicali, e in particolare a volgersi a formazioni riconducibili al populismo di destra sono emerse soprattutto due ipotesi diverse. La prima si concentra sui fattori socioeconomici e individua nelle conseguenze economiche della globalizzazione, nell’aumento delle diseguaglianze sociali, nella crisi del ceto medio le cause principali di un processo di radicalizzazione politica che ha premiato in generale i leader e i partiti populisti e, in modo più specifico, le formazioni populiste di destra. Una seconda ipotesi ha insistito invece in modo più marcato sulle determinanti sociopsicologiche e culturali, ossia sulle modalità con cui i processi di globalizzazione sono percepiti.
L’ipotesi che si concentra sulle componenti socioeconomiche è stata naturalmente articolata secondo varie modalità, ma in generale gli osservatori che hanno proposto una spiegazione di questo genere hanno sostenuto che sia l’insicurezza economica – come prodotto delle crescenti diseguaglianze di reddito – a spingere soprattutto i “perdenti della globalizzazione” ad abbandonare i partiti centristi e a spostarsi su posizioni radicali. Secondo Hans-Peter Kriesi e altri studiosi, il processo di globalizzazione ha per esempio determinato la formazione di un nuovo cleavage politico, che distingue vincenti e perdenti della globalizzazione. I partiti della destra populista secondo Kriesi sono stati in grado di costruire un’offerta politica e una spiegazione ideologica capace di attrarre i perdenti delle trasformazioni economiche e delle diversità culturali (Kriesi 2008, p. 19). A essere attratti maggiormente dalle formazioni radicali di destra sarebbero dunque, secondo questa ipotesi, soprattutto elettori provenienti dagli strati sociali più bassi (Arzheimer e Carter 2006), dalle fasce di popolazione non occupate (Van der Brugg et al. 2000; Lubbers et al. 2002) e dotate inoltre di minori livelli di istruzione (Arzheimer 2009; Bovens e Wille 2010).
Un esempio in questa direzione è fornito dalla lettura avanzata da Marco Revelli, il quale, nel tentativo di comprendere le cause profonde del successo di Donald Trump nella corsa presidenziale del 2016, ha esaminato la mappa elettorale degli Stati Uniti e in particolare le zone che hanno sostenuto con maggior forza la candidatura del miliardario newyorkese. Alla luce di questa analisi, ha sostenuto che il voto per Trump non sarebbe stato l’espressione di “rivolta dei poveri”, bensì una “vendetta dei deprivati”, ossia di “quelli che hanno perso qualcosa”, e cioè di coloro che ritengono di avere smarrito “il proprio primato di maschio, un pezzo del proprio reddito, non importa quanto alto questo fosse, il proprio status sociale, il riconoscimento del proprio lavoro, il rispetto per la propria fede, il proprio paese e il suo ruolo nel mondo, la sua potenza, la sua egemonia” (Revelli 2017, p. 64). Il “populismo 2.0” è d’altronde per Revelli “uno stato d’animo”, “la forma informe che assumono il disagio e i conati di protesta nelle società sfarinate e lavorate dalla globalizzazione e dalla finanza totale […] nell’epoca dell’assenza di voce e di organizzazione” (Revelli 2017, p. 10). E la “vendetta dei deprivati” sembrerebbe dunque fornire una chiave interpretativa capace di spiegare, oltre all’esito delle presidenziali americane, il risultato del referendum sulla Brexit, le fortune del Front national francese e l’ascesa di Alternative für Deutschland, nonostante in tutti questi casi la paura nei confronti dei flussi migratori diventi preponderante rispetto a ogni considerazione puramente economico-sociale. Ma il punto forse più significativo dell’indagine di Revelli è che le aree geografiche in cui il populismo 2.0 tende a ottenere maggior seguito sono le stesse in cui il movimento operaio aveva concentrato la propria forza.
La lettura avanzata da Revelli è senz’altro confermata da molte analisi che hanno evidenziato come i partiti della destra populista abbiano un significativo radicamento tra i settori popolari e nelle zone di vecchio insediamento industriale poi investite da processi deindustrializzazione. Si tratta di una tendenza sottolineata da anni da politologi che hanno mostrato come alla base del successo dei nuovi partiti della destra radicale in Europa siano la contrazione della classe operaia causata dalla deindustrializzazione e lo spostamento dei partiti di sinistra verso le nuove classi medie. Il caso emblematico da questo punto di vista è rappresentato dal Front national, che a partire dagli anni ottanta si è radicato soprattutto tra i ceti popolari (Genga 2015). È significativo che anche nei momenti di maggior flessione delle proprie performance – come nelle elezioni presidenziali del 2007 – la forza del Fn sia sempre risultata concentrata negli strati popolari, ossia tra operai e impiegati (Perrinau 2007, p. 172). Ma si tratta comunque di una tendenza che non si è modificata nel tempo, sebbene il consenso elettorale sotto la guida di Marine Le Pen si sia allargato anche ad altri strati sociali (Marchi 2017). E un discorso analogo vale anche per lo Uk Independence Party (Ukip), che ha trovato il suo elettorato tra la popolazione anziana, scarsamente istruita e non benestante, oltre che nella working class (Ford e Goodwin 2014; Pareschi 2016).
Anche l’ipotesi centrata invece sulla dimensione psicosociale, e cioè sulla reazione culturale alla globalizzazione, ha conosciuto molte declinazioni. Una prima variante si focalizza sull’insicurezza imputata ai crescenti flussi migratori, sull’intolleranza nei confronti di migranti, minoranze etniche, richiedenti asilo e lavoratori stranieri (soprattutto musulmani), come cause del sostegno al populismo di destra. È stata avanzata in Italia, per esempio, da Luca Ricolfi, che ha chiamato in causa un “cocktail” di preoccupazioni legate alla crisi economica e alla paura del terrorismo. In altre parole, secondo questa spiegazione è la percezione di insicurezza a gonfiare le vele del populismo. “Dietro l’ascesa dei partiti populisti c’è una crescita imponente della domanda di protezione, che a sua volta deriva dalla sempre più vasta diffusione di sentimenti di insicurezza, preoccupazione, paura”, sentimenti “che i partiti populisti prendono estremamente sul serio, e cui rispondono con la loro promessa di protezione” (Ricolfi 2017, p. 165). Una seconda variante più raffinata di questa medesima ipotesi si focalizza invece su una più complessa “reazione culturale” ai processi di globalizzazione. Ad anticipare questa interpretazione era stato, ormai quasi un quarto di secolo fa, Cristopher Lasch, il quale, oltre a riabilitare la vecchia esperienza del People’s Party di fine Ottocento, aveva ravvisato nella graduale emersione di un nuovo populismo – che difendeva la famiglia tradizionale e che si opponeva all’aborto in nome di valori religiosi – la reazione politica e culturale dei ceti medi a quella che chiamava la “rivolta delle élite”, e cioè alla progressiva “secessione” dalla società americana di un’élite sempre più cosmopolitica, secolarizzata e ossessionata dallo stile di vita salutista e dalle regole del “politicamente corretto” (Lasch 1994; 1995). Dopo i terremoti politici che hanno scosso molti sistemi democratici occidentali, questa lettura è stata ripresa da vari studiosi (seppur con un’ottica diversa). Per esempio Ronald Inglehart e Pippa Norris hanno sostenuto che l’avanzata contemporanea dei populismi andrebbe spiegata come effetto di una sorta di cultural backlash, ossia come una reazione culturale all’avanzata di quel cosmopolitan liberalism che si prefigge come obiettivi la tolleranza dei diversi stili di vita, la difesa del multiculturalismo, la protezione dell’ambiente, l’uguaglianza di genere, il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Più in particolare, secondo Inglehart e Norris il sostegno a formazioni populiste, connotate da posizioni anti-establishment, autoritarie e nativiste, non va infatti ricondotto a motivazioni di carattere economico-sociale: si tratta invece di “un fenomeno sociopsicologico”, da ricondurre alla reazione nostalgica di settori dell’elettorato che si oppongono alla “rivoluzione silenziosa” e dunque allo spostamento delle società occidentali verso i valori post-materialistici. Le formazioni populiste di destra sarebbero cioè in grado di canalizzare politicamente la reazione al cosmopolitismo libertario. Sulla scorta di una simile lettura, i migliori predittori della scelta a favore di formazioni populiste di destra sarebbero i livelli di istruzione, l’età e il genere. In altre parole, il supporto più energico ai partiti populisti giungerebbe dalle generazioni più anziane, dalla popolazione maschile, dai settori con livelli di istruzione più bassi e in generale connotati da atteggiamenti tradizionalisti, che si oppongono ai valori progressisti per quanto concerne la sessualità, la religione, il multiculturalismo, il cosmopolitismo e la tolleranza rispetto agli stranieri (Inglehart e Norris 2016).