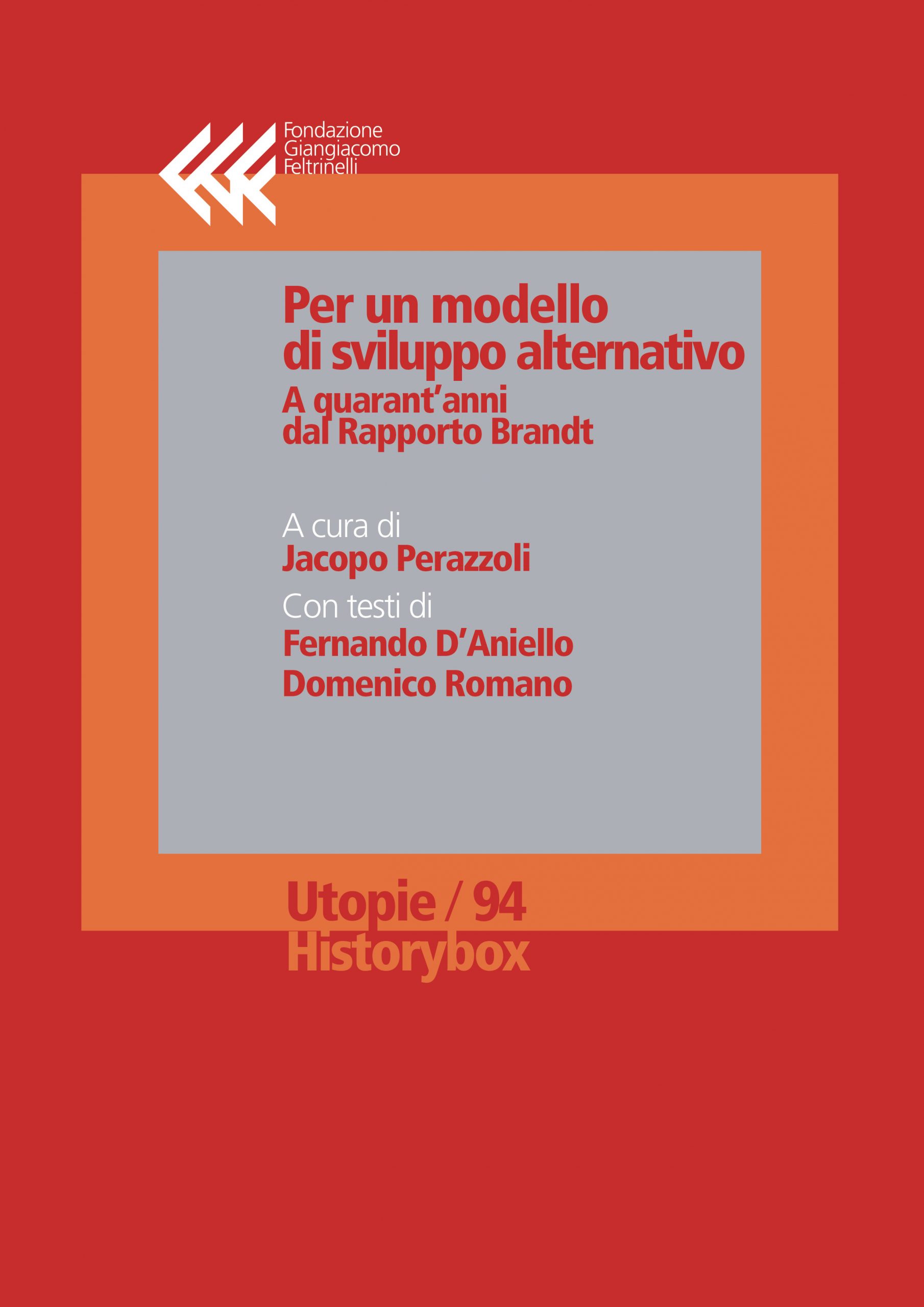Calendario Civile / #10maggio1933
La “cancel culture” non esiste. È un grande ombrello denigratorio formulato dalla destra conservatrice e integralista statunitense per designare un insieme molto eterogeneo di proposte relative all’uso del linguaggio e a contenuti intellettuali e figurativi fra loro estremamente diversificati. Ad accomunare queste proposte è solo il fatto che vengono (anche se non sempre) avanzate da membri di minoranze discriminate e sono finalizzate al riconoscimento di maggiori o migliori diritti, dignità, spazi pubblici; nonché alla difesa della propria voce quando non della propria incolumità fisica. Agli occhi di coloro che hanno formulato e imposto al dibattito pubblico il lemma cancel culture attraverso i media – su You Tube si possono vedere gustosi filmati di Donald Trump che ossessivamente ne ribatte l’uso in diverse occasioni pubbliche –, le proposte culturali delle minoranze punterebbero a “cancellare” le posizioni degli avversari. Ovvero di membri di maggioranze che si ritengono a rischio di “cancellazione” per opera di istanze perpetrate da minoranze che – nelle fantasie delle presunte vittime – opererebbero secondo lo stereotipo classico del complotto già in passato attribuito a lebbrosi, ebrei, eretici e streghe.
Per queste ragioni penso che il termine “cancel culture” andrebbe sempre utilizzato tra virgolette, recando intrinsecamente un disvalore che – laddove il lemma è assunto come meramente descrittivo – inaccortamente si integra nel dibattito entro cui il termine è evocato. Come “eretico” o “giustizialista”, anche “cancel culture” porta con sé il giudizio moralmente negativo impresso dell’istituzione che quel termine lo ha introdotto. Come nessun “eretico” si è mai auto-definito eretico – è semmai il tribunale inquisitoriale a definirlo tale –, così nessun “cancellatore culturale” accetterebbe mai questo epiteto. Il fatto che oggi, in Italia, siano stati emanati bandi universitari per finanziare studi sulla “cancel culture” dimostra solo quali mostri può generare, anche per opera più o meno inconsapevole di studiosi che dovrebbero essere abituati all’esercizio della critica culturale, l’uso ingenuo o acritico del linguaggio e delle categorie interpretative.
Se si accettano queste premesse, si può mettere in luce un paradosso politicamente e intellettualmente molto fertile.
La pratica dei roghi dei libri è avvicinabile – piuttosto che alle manifestazioni pubbliche di una inesistente “cancel culture” – alle pratiche messe in atto da coloro che hanno introdotto nel dibattito pubblico l’uso di questo lemma.
Dopo che per diversi anni, nella più classica strategia populista, Donald Trump ha accusato alcuni suoi oppositori di volerlo “cancellare” e di volere “cancellare” le posizioni sue e della sua parte politica, egli ha storicamente agito da vero e proprio cancellatore. Ciò prima di tutto negando legittimità legale all’elezione del suo avversario Joe Biden, accusato di non meglio identificati “brogli” allo scopo di delegittimarlo. E in secondo luogo, come ha ipotizzato il Congresso statunitense, incitando all’insurrezione i suoi sostenitori (molti dei quali senza dubbio si considereranno dei “cancellati”) nell’assalto a Capitol Hill: questo sì un episodio per violenza, efferatezza, presupposti politico-culturali, importanza storica, raffrontabile ai tragici eventi del 10 maggio 1933.
Il presunto cancellato che si dimostra, nei fatti, reale cancellatore è il punto centrale della relazione circolare che dovremmo instaurare tra la data del 6 gennaio 2021 (l’assalto di Capitol Hill) e il 10 maggio 1933. Nella radice culturale del nazismo e di altre forme di totalitarismo è ben presente la vena profonda del vittimismo nei riguardi di tutti quelli che David Bidussa chiama suggestivamente gli “indesiderabili”, i “sospetti”. Questi vengono “ereticizzati” attraverso l’accusa del complotto volto a danneggiare, indebolire, “cancellare” lo spirito, la nazione maggioritari. Il vittimismo dei vincitori – lo abbiamo più volte visto in atto anche nell’Italia berlusconiana – è uno strumento formidabile di aggregazione del consenso e di mantenimento delle asimmetrie di potere vigenti, ai danni di ogni alterità.
Simmetrico rispetto allo stereotipo del complotto dei “cancellatori” è quello – altrettanto interessante ragionando nella stimolante prospettiva, implicitamente proposta da Bidussa, di una storia comparata delle guerre al libro – del complotto dei “censori”. A livello di riflessione culturale alta si continua, mi sembra, a perpetuare il grande equivoco per cui libere pratiche editoriali odierne di modifica linguistica e terminologica di testi – o di mancata pubblicazione o ripubblicazione di determinati testi, o parti di testi – sarebbero una forma di “censura”. Tale “censura” originerebbe, secondo questi assunti, da prepotenza “cancellatrice” (di minoranze, ça va sans dire), da moralismo, da pruderie, da snobismo intellettuale.
Anche in questo caso bisognerebbe meglio riflettere sull’uso delle parole. “Censura” – termine che a sua volta parrebbe avvicinare queste pratiche ai roghi dei libri – è fuorviante: non esistendo in questi casi né leggi, né polizie e tribunali politici, né indici di libri proibiti, né pene previste per i trasgressori di inesistenti divieti. I fenomeni cui si fa riferimento sono invece – ritengo – di due ordini: uno economico e uno politico. Sul piano economico, liberi imprenditori dell’editoria, della stampa o della formazione scolastica o universitaria scelgono – senza alcuna costrizione legali – di non rischiare di perdere fette di mercato che vedono come protagonisti studenti danarosi e lettori forti, sensibili (si può essere d’accordo o meno) a determinate istanze politico-religiose, morali, culturali. Sul piano politico, vediamo qui in azione importanti segmenti dell’industria culturale-accademica-editoriale occidentale a vocazione comunicativa globale, ben intenzionati a preservare o accrescere la preminenza globale finora conquistata da certi paesi (Stati Uniti e Gran Bretagna in primis) anche con le armi del colonialismo e del postcolonialismo.
Sarebbe interessante chiedersi che legame c’è tra le logiche del sistema editoriale-accademico-culturale del passato e le nuove istanze del presente. Come mai per secoli i testi scritti da donne sono scomparsi o sono stati frutto di appropriazione maschile? Per quali ragioni nell’Ungheria odierna si vogliono vietare per legge (e questa sì è censura) libri di supposta “promozione dell’omosessualità”? Per quali fini un certo integralismo religioso – quello che oggi negli Stati Uniti sovrappone David di Michelangelo e pornografia – è stato manipolato o apertamente sostenuto da candidati Presidenti della Repubblica o del Consiglio, oppure dagli eserciti e delle diplomazie delle potenze occidentali, a ogni livello e latitudine?
Un certo mondo del passato sta presentando il conto a noi, nel presente. E una nuova storia delle guerre al libro, veramente di lungo periodo e davvero globale, dovrebbe, penso, ripartire da qui.