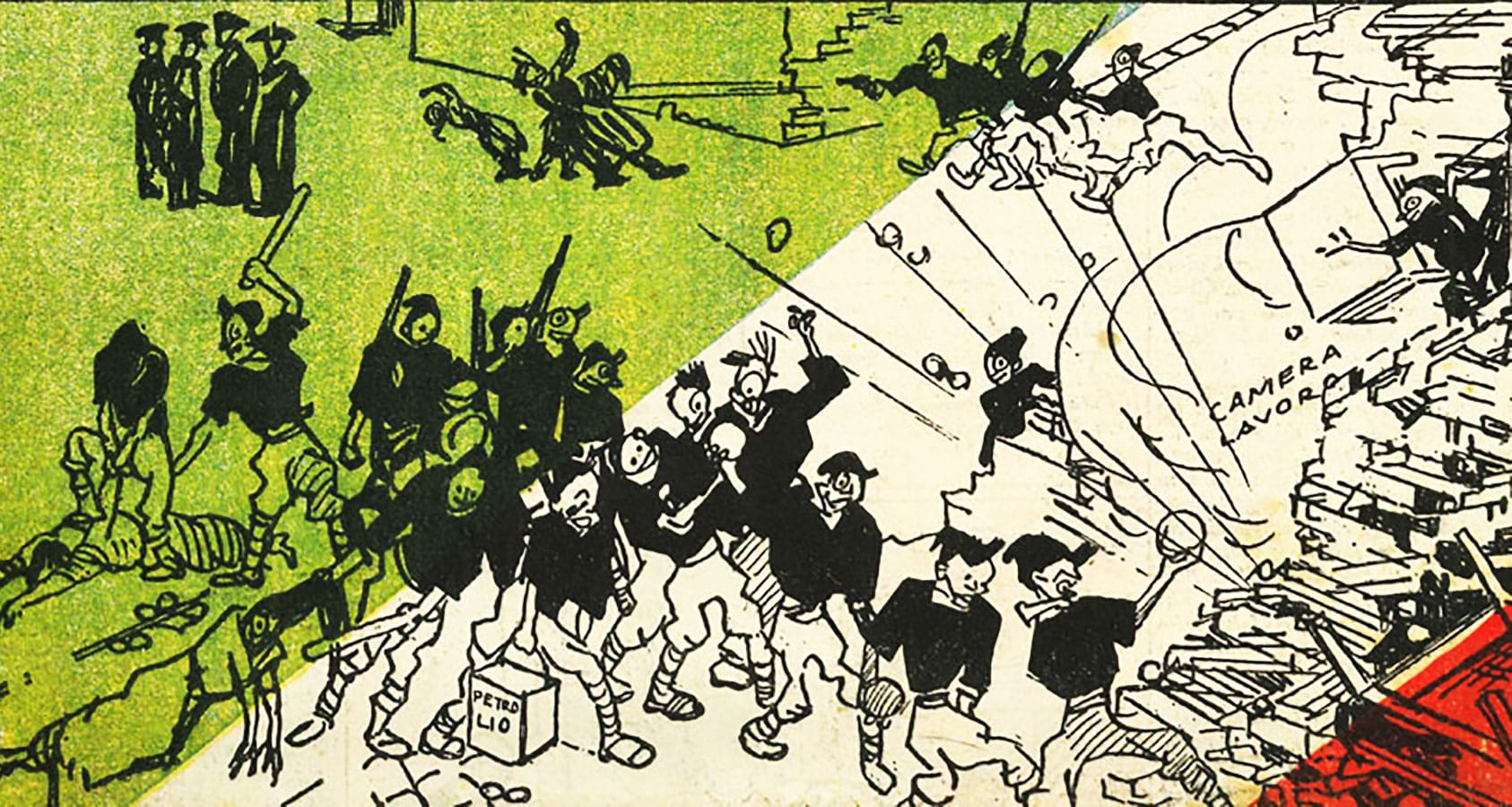Vale la pena tornare a confrontarsi con Albert Camus in questo sessantesimo dalla sua morte. E in un tempo in cui Albert Camus non sembra suscitare particolari passioni. Anzi questa condizione, lungi dal farcelo apparire come una figura che si può tranquillamente archiviare, mi sembra costituire un’opportunità per riprenderlo in mano senza partigianerie.
In un’epoca arroccata sulle certezze, Albert Camus esorta continuamente a non arroccarsi, ma a rimettere in discussione se stessi. Condizione mentale, prima ancora che politica o culturale, cui difficilmente Camus è venuto meno.
Due esempi, credo, lo dimostrano con chiarezza.
Primo esempio. Nel 1939 Albert Camus recensisce su “Alger républicain”, Vino e pane di Ignazio Silone. Il passaggio del libro che sceglie di commentare è quello in cui Pietro Spina, il protagonista e l’eroe della storia (nell’edizione francese il suo nome è Pietro Sacca) riflette sul rischio di teorizzare troppo sui contadini e, quindi, di comprenderli di meno.
“È qui – scrive Camus- che possiamo valutare quest’opera come rivoluzionaria. Perché un’opera simile non è affatto quella che esalta le vittorie e le conquiste, ma quella che svela i conflitti più angoscianti della rivoluzione. Più questi conflitti sono dolorosi e più saranno attivi. Il militante convinto troppo in fretta sta al vero rivoluzionario come il bigotto sta al mistico. Perché la grandezza di una fede si misura con i suoi dubbi”.
Secondo esempio. A metà degli anni ’50, quando la sua solitudine è massima e tutte le reti di amicizia consolidate nel tempo della Resistenza e della speranza di una nuova Europa (in primis quella con Jean-Paul Sartre si sono consumate), in occasione dei 350 anni dalla pubblicazione del Don Chisciotte di Cervantes Camus preparò un articolo dal titolo La Spagna e il donchisciottismo in difesa della causa repubblicana e contro il regime di Franco. Se Don Chisciotte nella sua lucida follia parte alla ricerca di un’armonia originaria, perduta, rappresentata da quei valori cavallereschi che decide di incarnare in un’epoca in cui erano ormai decaduti, i repubblicani spagnoli con il passare del tempo somigliavano a tanti Don Chisciotte, impegnati in una causa ormai dimenticata e relegata ai margini della Storia.
Ma sono proprio le cause perse della sua generazione, dalla Spagna all’Europa alla politica mediterranea, a spiegarci l’origine dei nostri mali attuali, insiste Camus. Il suo Don Chisciotte, assomiglia molto all’immagine di Sisifo che ha consegnato nelle sue considerazioni ne Il mito di Sisifo.
“La rinuncia altera e leale alla vittoria rubata, il testardo rifiuto delle realtà del secolo, l’inattualità, insomma eretta a filosofia, hanno trovato in Don Chisciotte un ridicolo e regale portavoce. Ma è importante notare che questi rifiuti non sono passivi. Don Chisciotte si batte e non si rassegna mai. «Ingegnoso e temibile», rappresenta la lotta eterna. Un rifiuto che è il contrario di una rinuncia”.

Una condizione che è presente nella sua riflessione almeno da due punti di vista e su due temi “caldi” in cui oggi noi ancora con difficoltà riusciamo a prendere la misura.
Il primo riguarda la dimensione della responsabilità dell’intellettuale, qualcosa che è molto diverso dalla categoria di impegno, molto spesso sovrapponibile alla dimensione della presenza. La responsabilità non si risolve, infatti, nella dimensione del protagonismo o dell’esserci in pubblico, ma nella capacità anche, e forse soprattutto, di saper sopportare la propria solitudine. Una dimensione che ha il vago sapore del richiamo che Max Weber consegna alla vigilia della sua morte sulla responsabilità del politico nelle righe che chiudono il suo La politica come professione.
Dall’altra la consapevolezza, come scrive nell’ottobre 1955 nella Lettera a un militante algerino, che nello scontro che si apre con il processo di decolonizzazione non sia sufficiente risolvere tutto nell’abbandono delle colonie e nella consegna al nazionalismo dei colonizzati, ora finalmente liberi, della gestione della cosa pubblica e del loro destino.
L’esperienza del colonialismo, infatti, non si risolve solo nelle due figure dei colonizzatori e dei colonizzati come due entità astratte naturalmente opposte e mai “contaminate”.
L’esperienza del colonialismo e dell’imperialismo tra XIX e XX secolo è anche, come tutti gli esponenti politici accorti delle lotte di liberazione nazionale sanno con chiarezza e consapevolezza, la storia di una cultura ibrida, di un meticciato culturale che è anche la costruzione di una generazione di appartenenti al mondo dei colonizzatori che avvertono come propria terra e come propria storia quella della colonia, che non per questo sono contrari alla indipendenza e al riconoscimento della libertà delle ex-colonie, ma che hanno anche la percezione che nel frattempo si è creata una nuova sensibilità culturale che si colloca in qualche dimensione altra rispetto ai due figuranti opposti (quello dei coloni e quello dei colonizzati) e che quella esperienza, quella sensibilità che “sta in mezzo e altrove” è una risorsa e non un ostacolo.
La sfida rappresentata da quella dimensione che è il percorso di non pensarsi “frutti puri”, una condizione su cui con acutezza anni fa ha richiamato l’attenzione James Clifford. Non essere frutti puri, ma soprattutto avere la consapevolezza di quella condizione, vuol dire sapere di essere il risultato di un meticciato sociale, culturale, linguistico, e mentale. Soprattutto significa avere gli strumenti per resistere alla tentazione, sempre all’orizzonte per ciascuno, di subire il fascino della non contaminazione.
Non solo. Quella dimensione travolta dai neonazionalismi in atto nei territori sia delle ex-potenze coloniali, come delle ex colonie ora potenze emergenti, è lì a dirci che quel processo non è stato risolto allora, e periodicamente torna, con i suoi fondamentalismi culturali e i suoi etnicismi politici, a riempire l’agenda di questo nostro tempo, senza avere gli strumenti e l’inquietudine di superarli, ma solo di riproporli.
Appunto perché una soluzione e una via di uscita stanno nel riconoscimento preliminare di una impossibilità di risposta solo facendo conto sulla propria presunta autosufficienza.