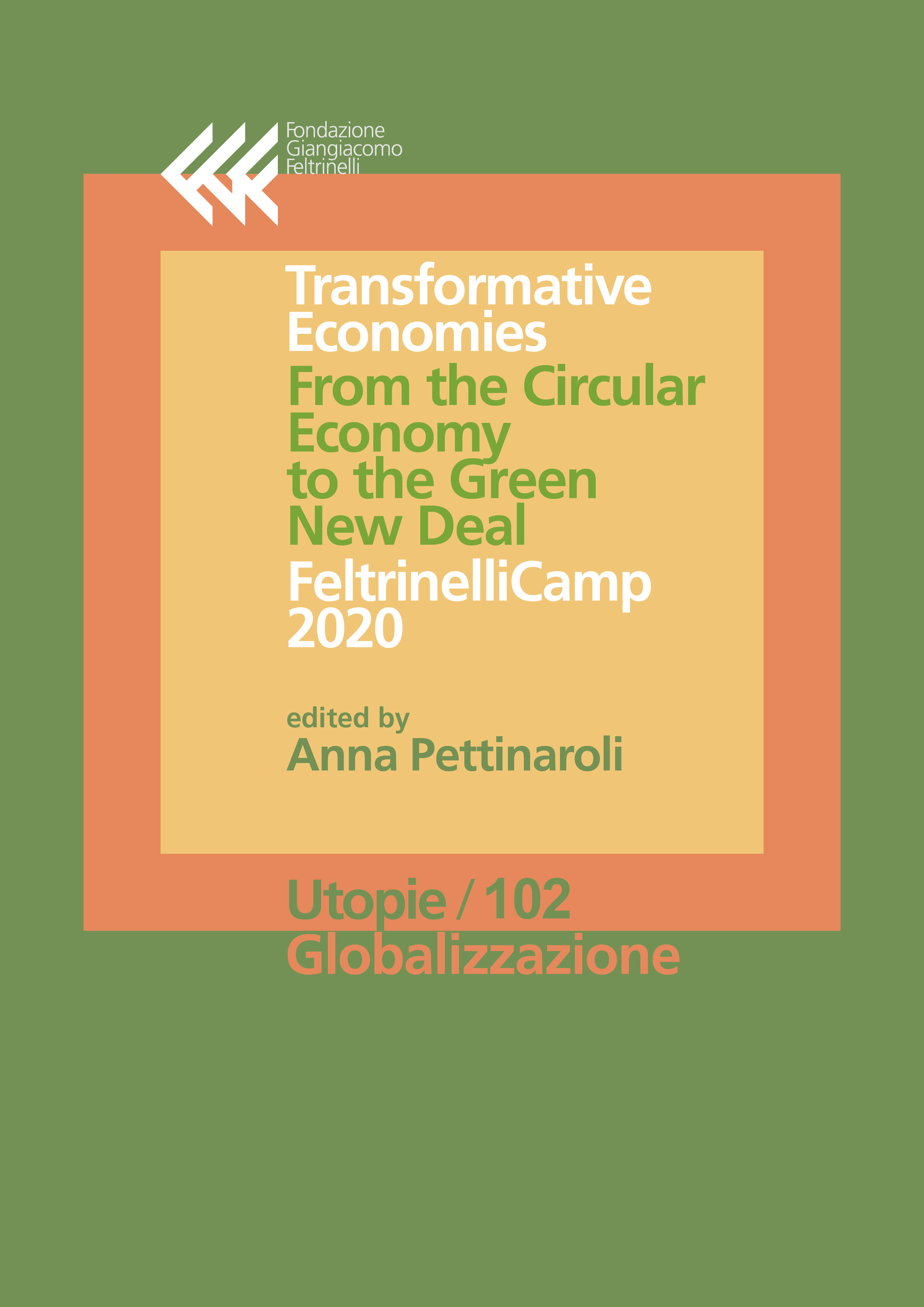Se ci attenessimo a quanto leggiamo ogni giorno sui prodotti esposti sugli scaffali dei supermercati, la crisi climatica e l’inquinamento da plastica non si spiegherebbero.
Negli ultimi decenni, l’impegno dei brand nei confronti della sostenibilità ha occupato spazi sempre più consistenti sulle etichette dei prodotti, con dichiarazioni ambientali sempre più ambiziose. Tra chi sostiene di usare percentuali di riciclato pari al 100% e chi si professa completamente “ecologico” o “carbon neutral”, passando per chi dichiara di utilizzare non meglio specificati “materiali sostenibili”, nel marketing, il verde non passa mai di moda.
Da quando, a partire dai primi anni ’90, la sostenibilità ambientale ha cominciato a occupare l’interesse (e le preoccupazioni) dei consumatori, i brand hanno risposto con incoraggianti prese di posizione che oggi si dimostrano, nella migliore delle ipotesi, fuorvianti. Quello che inizialmente era nato come green marketing pensato per indirizzare al meglio le scelte degli acquirenti, oggi sconfina nel greenwashing, lasciando il passo ad una comunicazione che sfrutta le inquietudini dei consumatori e capitalizza la crescente domanda di prodotti e comportamenti a basso impatto ambientale attraverso affermazioni imprecise, poco chiare e difficilmente verificabili.
Che il greenwashing sia una pratica fin troppo diffusa lo dimostrano i dati di uno studio della Commissione Europea del 2020. Secondo la ricerca, il 53,3% delle asserzioni ambientali esaminate in UE sono vaghe, fuorvianti o inconsistenti, mentre il 40% è del tutto privo di fondamento.
Come a dire: metà dei prodotti che compriamo credendo di fare del bene al pianeta, potrebbero non fare poi tanto bene.
Se l’abito non fa il monaco, a maggior ragione, l’etichetta non fa il santo, anzi. Negli ultimi anni, le accuse di greenwashing hanno riguardato in larga parte le multinazionali considerate co-responsabili della crisi climatica. Tra queste spicca Coca Cola che, prima ancora di diventare il discusso sponsor della COP27, era stata citata in giudizio dall’Earth Island Institute per le sue campagne “Every Bottle Back” e “World Without Waste”, ritenute ingannevoli considerando che la multinazionale guida la lista nera dei 10 inquinatori da plastica a livello globale, seguita da Pepsico e Unilever. Analoghe accuse sono state mosse ad aziende come ENI e H&M. Parallelamente, molti brand, a cominciare da Ikea, EasyJet e Gucci, stanno ritirando le proprie affermazioni sulle compensazioni di CO2, recentemente entrate nel mirino di associazioni e legislatori.
Eclatante, infine, il caso segnalato dal progetto Greenwash promosso dalla Changing Markets Foundations, secondo cui l’azienda di abbigliamento di Kim Kardashian scrive “I’m not plastic” sulla sua confezione di biancheria intima, salvo poi aggiungere, in caratteri molto più piccoli, che il materiale in questione è di tipo 4, ossia plastica LDPE (polietilene a bassa densità).
Se è vero che il greenwashing è arrivato a toccare il settore della moda e si sta diffondendo anche a diritti civili e ad altri temi sensibili prendendo, a seconda dell’occorrenza, il nome di pink, blue, social washing o, in generale, woke-washing, la maggiore preoccupazione resta legata al greenwashing nell’industria della plastica. Preoccupazione più che ragionevole se si pensa che, stando ad un report di Ellen MacArthur Foundation e McKinsey, di questo passo nel 2050 ci potrebbero essere più plastiche che pesci nei nostri mari.
Tra le principali cause della scarsa popolarità dei polimeri: l’impatto ambientale dei combustibili fossili impiegati per ottenere materiale vergine e gli infiniti tempi di degradabilità dei rifiuti plastici abbandonati in natura. Eppure, per la sua versatilità e gli elevati standard igienico-sanitari, la plastica resta un materiale indispensabile nei settori più diversi. Al punto che spesso si sostiene che il problema non è la plastica, ma il modo in cui questa viene gestita.
Secondo un rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Unep), l’inquinamento globale da plastica potrebbe essere ridotto dell’80% entro il 2040 semplicemente eliminando imballaggi inutili e promuovendo filiere a ciclo chiuso e sistemi di economia circolare, capaci cioè di reintrodurre i rifiuti nel sistema produttivo per trasformarli in nuovi prodotti. Buone pratiche che dichiarazioni ambientali di prodotto false, fuorvianti o infondate finiscono inevitabilmente per rallentare.
Per promuovere la transizione verso un’economia circolare, nel 2019 il Parlamento Europeo ha varato una direttiva che impone un contenuto minimo di riciclato pari al 25% nelle bottiglie in PET entro il 2025. Asticella che si alzerà al 30% entro il 2030. In aggiunta, l’UE sta discutendo una nuova direttiva sui “Green Claims”, con l’obiettivo di chiarire in che modo le aziende dovranno provare la veridicità delle dichiarazioni ambientali sui loro prodotti.
Possibili soluzioni alla verificabilità di quanto dichiarato stanno già arrivando dal mondo tech. Tra queste, quelle presentate da Circularise o R-cycle, che offrono i cosiddetti “passaporti digitali di prodotto”. A queste si aggiunge anche Certified Recycled Plastic, un programma tecnologico che traccia su blockchain caratteristiche, origine e conformità normativa dei materiali lungo l’intera filiera del riciclo, dal rifiuto al prodotto finito. Dando la possibilità ai consumatori di conoscere la “storia” dei prodotti attraverso la scansione di un QR code applicato sulle etichette.
Rispetto ad altre pratiche di marketing ingannevoli, il greenwashing ha un costo sociale di gran lunga maggiore, poiché non incide solo sui consumatori e sulle imprese, ma anche e soprattutto sull’ambiente.
Da ultimo, il greenwashing costituisce la maggiore minaccia per la sostenibilità, facendoci credere che le cose stiano cambiando quando in realtà non è affatto così.
La risposta al greenwashing deve venire prima di tutto dalle istituzioni comunitarie e nazionali, che hanno il dovere di fornire direttive chiare per rendere l’operato dei brand davvero sostenibile, vincolando le aziende a dichiarare solo quanto sono effettivamente capaci di dimostrare. A ben vedere, però, anche i consumatori possono fare molto, esigendo dai brand soluzioni attendibili per verificare in qualsiasi momento la veridicità delle affermazioni ambientali.
È giunto il momento di agire in maniera coordinata per spingere i grandi colossi industriali ad adottare comportamenti e dichiarazioni a tutela dell’ambiente di cui possiamo davvero fidarci, prima che sia troppo tardi.