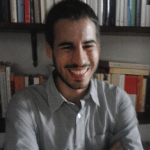1.
In un saggio di strabiliante lucidità, pubblicato per la prima volta nel 1970 nei Mélanges in onore del sessantesimo compleanno di Claude Lévi-Strauss, e rifluito poi nel secondo tomo dei celeberrimi Problemi di linguistica generale (1974), Émile Benveniste ha stabilito una volta per tutte la differenza fondamentale che separa una polis da una civitas.
I due “modelli” della città sono organizzati attorno a un programma squisitamente linguistico: quello di descrivere la relazione tra un termine di base e un derivato. La questione della derivazione è impostata a partire dalla nozione di “città”, nella sua versione latina: civitas. Il problema potrebbe essere rapidamente liquidato se ci si accontentasse della spiegazione ordinaria: civitas costituirebbe null’altro che la forma astratta derivata dal sostantivo civis. Tuttavia, anche ammessa, in via preliminare, l’equivalenza tra civitas e “città”, resta da stabilire quale sia il significato di civis, considerato il “termine di base” da cui essa deriverebbe. È dunque proprio sulla traduzione, che sotto le spoglie del civis ci obbliga a riconoscere quelle del “cittadino”, che occorre attardarsi. Di più: secondo Benveniste essa va messa integralmente in discussione.
Questo il nocciolo dell’argomento: continuare a tradurre civis con “cittadino” vorrebbe dire considerare questo nome derivato da quello di “città”. Ciò è insensato, giacché è la seconda – la città – a derivare dal primo – il cittadino. Assumere che civis stia per “cittadino” implicherebbe averne già pregiudicato il senso lasciandolo pre-dire a ciò che da esso dovrebbe in verità conseguire, cioè la città. La spia di questo pasticcio è riconosciuta da Benveniste nella consistente varietà di occorrenze in cui il sostantivo civis è abbinato a un pronome possessivo (civis meus, cives nostri). Il valore di questo nome non potrà perciò riposare su una designazione oggettiva, su un’identità autonoma e consistente, ma potrà essere guadagnato soltanto dalla e nella relazione che lo espone. Civis è cioè un termine dotato di valore reciproco, mutuale: si è civis soltanto per un altro civis. Sarà perciò che, conseguentemente, Benveniste proporrà di tradurre civis con “mio con-cittadino”. Sono la relazione, la dipendenza, la reciprocità e la mutualità – e non già un’identità, una sostanza o un’essenza – a definire il significato di civis. Pigiando con discrezione sul pedale della generalizzazione, potremmo dire che civis significa nient’altro che il rapporto o la relazione tra cives. Le implicazioni di questa sbalorditiva dimostrazione sfoggiano un rango metafisico e politico impossibile da tacere. La città, la civitas dovrà essere infatti convenientemente ridefinita come l’insieme o la mutualità dei con-cittadini. Se essere civis indica innanzitutto la capacità di stabilire rapporti, allora civitas designerà in prima istanza l’aver-luogo dei rapporti tra cives. A complicare lo stesso processo di derivazione, compare l’aggettivo civilis. Non un sostantivo dunque, ma un puro modo di essere – relazionale, reciproco, comune –, una singolare maniera di stare assieme, che si applica a un soggetto plurale: quei cives, quei con-cittadini, l’insieme dei cui rapporti è detto civitas.
All’estremo opposto di questa configurazione del rapporto di appartenenza starebbe la polis greca. In questo caso, giusta la lezione di Benveniste, è piuttosto il sostantivo polites a essere derivato da quello di base polis. Sicché essere cittadino in Grecia vorrà dire partecipare della città, assumere il posto che essa ci assegna, onorare i doveri che essa ci comanda e godere dei diritti che eventualmente ci elargisce. Se dunque la polis è quel tutto da cui le parti dipendono e a cui fanno in ultima istanza capo, la civitas è un puro aver luogo di rapporti, una configurazione dello stare assieme di più, la forma di una genuina mutualità, la composizione di una innumerabile molteplicità di relazioni. L’una – corpo separato, totalità auto-sussistente – prescinde dalle parti che, trascendendo e metaforizzando, essa rappresenta; l’altra – insussistente, insostanziale – non coincide altro che con quelle infinite relazioni che la co-istituiscono. La storia della politica occidentale si è fondata sul paradossale equivoco di aver scelto una scorza romana – quella della cittadinanza – per descrivere la polpa di un’esperienza greca – quella della politica. In virtù di questa paradossale inversione è dalla civitas – confusa con la polis – che facciamo discendere le qualità del civis – spacciato per polites. Ciò che in questa operazione viene fatalmente cancellato è un altro modo di istituire, ordinare e trasformare i collettivi. Esso è in tutto e per tutto alternativo a ciò che continuiamo a chiamare “politica”. Il sapere e la tecnica che assicurava la composizione e la trasformazione dei rapporti nella civitas – che, alla lettera, la faceva esistere – era lo ius, il diritto. Detto non a caso civile: il medio o il medium capace di fare avvenire e poi di trasformare qualcosa come una città, lo spazio comune tra i cives e il piano dei loro inanticipabili rapporti. Questi – le parti – saranno sempre più del tutto – la città –, che non è dunque il loro insieme, la loro somma o addizione, il Tutto o l’Uno da cui dipendono e in cui davvero si realizzano. Il ius è – agli antipodi della sovranità e della sua necessità logica di produrre sintesi e riduzioni – un sapere metonimico, un verboso operatore di molteplicità.
Se la nefasta confusione indicata da Benveniste governa ancora tanto profondamente l’inderogabile pulsione che ci conduce a riconoscere soltanto al “pubblico”, al “generale” e all’“uguale” la palma del politico, ciò dipende dall’aver trasformato quel sapere dei rapporti – lo ius civile, il diritto dei cives – che, esponendoci gli uni alle altre, faceva una città, in un diritto privato di cui possiamo intuire il ruolo e la funzione soltanto come antipode del diritto pubblico, il diritto della polis e non dei polites. La nostra mitologia politica di moderni – che a ben vedere è poco più che una frustrata nostalgia – dipende interamente dall’aver trasferito il mito greco della legge sull’esperienza romana del diritto. Ancora oggi ci intestardiamo a pensare che la politica sia lo spazio della trascendenza, dell’essenza, dell’identità e dell’unità e non già, come la tradizione del diritto civile continua silenziosamente a suggerirci, una tecnica della materialità, della composizione e dell’istituzione, della trasformazione e del conflitto.
2.
Quando, nel suo ultimo romanzo – Lo stradone –, Francesco Pecoraro scrive che “la città fisica è la conchiglia deforme che la città sociale, come un gigantesco mollusco semideficiente, costruisce per sé e così si rappresenta. La città demmerda è un’incerta, auto-celebrante, messa in figura della gente demmerda che ci abita e che la costruisce. Niente di più, ma neanche niente di meno”, sta indicando null’altro che la drastica separazione tra urbs e civitas di cui non cessiamo di fare quotidiana esperienza nella metropoli. Il tenore di questa considerazione non può essere tradotto in piagnisteo moralistico, ma lucidamente – politicamente, verrebbe fatto di dire – afferrato e tradotto. Diremo allora che il diritto – civile – non è altro che l’operazione che permette, ripetutamente e contingentemente, di trasformare l’urbs in civitas. La città è il teatro di queste incessanti, eterogenee operazioni di composizione, produzione e trasformazione del comune con cui essa coincide: un’assemblea in cui decidiamo sempre daccapo cosa fare di noi stessi.
È perciò che appare difficile non riconoscere uno strano pleonasmo nell’espressione – fortunatamente sempre più in voga – “beni comuni urbani”. La città è infatti il comune per eccellenza; ma non già un patrimonio da custodire, un museo da ammirare, quanto piuttosto una ricchezza materialmente prodotta, un inesausto e plurivoco “parlamento”. Nella metropoli contemporanea – la civitas capitalista, lì dove produzione e riproduzione si sono rese indiscernibili – il comune è il nome tanto di un’esperienza che di un’attività. Chissà che la politica che essa ancora attende non possa scegliere di indossare la forma di un nuovo diritto. Un diritto il cui nome ci manca e che non regolerebbe condotte già date e disposte – i prevedibili compiti di un polites – ma incarnerebbe il principio di intensità che le istituisce. Un diritto che costituirebbe insomma il principio di organizzazione e di istituzione di quelle condotte cooperanti con cui la città, la metropoli, coincide da parte a parte. Né pubblico né privato, esso meriterebbe forse proprio il nome venerabile di diritto civile e dunque, insieme con quello, il compito che fu già il suo: forgiare le forme capaci di animare e istituire una vita comune. Il comune, d’altronde, cesserebbe così di essere scambiato per una cosa da appropriare o una causa con cui identificarsi, ma tornerebbe a coincidere con ciò che da sempre non ha smesso di essere: una prassi da istituire ogni volta di nuovo.