Testo a cura di Luciano Ventura (1950)
Cesare Beccaria, che scrisse a 26 anni la sua unica opera di diritto, non era un tecnico della legislazione; gli studi che maggiormente lo interessavano riguardavano soprattutto la letteratura e l’economia. Forse anche per il suo distacco dagli ambienti forensi, egli seppe vedere con drammatica chiarezza che cosa veramente significassero, per gli uomini semplici, il diritto e la procedura penale del tempo. 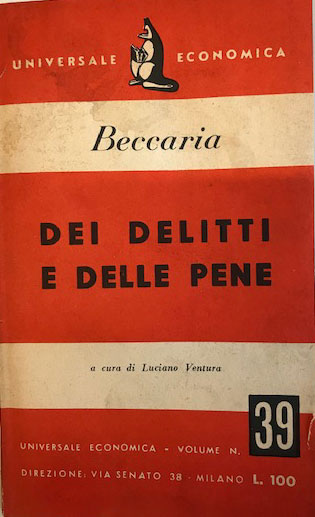
Il libro Dei delitti e delle pene fu pubblicato nel 1764, mentre cambiamenti radicali si stavano compiendo in Italia e in Europa. L’apertura di nuovi mercati extraeuropei, il perfezionamento dell’organizzazione della produzione, la grande ripresa degli scambi commerciali, avevano sviluppato nuove e impetuose forze nel seno della società feudale. Lo slancio della nuova realtà economica era però frenato dalle vecchie strutture politiche, che assicuravano il dominio di una classe improduttiva e irretivano l’attività degli uomini con ogni sorta di ostacoli e di imposizioni; esse erano sorrette solo dall’interesse di poche famiglie, che esercitavano su zone più o meno vaste il loro potere dispotico, prosperando sulla miseria generale. I deboli governi di ben nove diversi stati italiani non potevano limitare che assai scarsamente l’arbitrio dei signorotti locali, perché proprio questi costituivano la loro base.
La lotta contro la vecchia società che crollava era guidata dalla giovane borghesia, costituita dagli elementi dirigenti sella produzione: proprietari di manifatture, banchieri, commercianti. A questa lotta erano legati tutti gli starti sociali che nel sistema feudale vedevano solo angherie e miseria.
La grande rivolta contro il feudalismo morente non poteva non investire le istituzioni di diritto e di procedura penale, che costituivano il mezzo di oppressione più diretto nelle mani della classe dominante e presentavano, spinte all’estremo, l’arretratezza, la corruzione, il disprezzo dell’uomo, propri a tutto il sistema.
Alla radice del diritto penale del medioevo era la concezione del delitto come offesa al principe o al feudatario. Il reo poteva, per alcuni delitti, essere liberato dietro pagamento di una somma di danaro; il giudice non era altro che un servo del signore, che considerava il processo come un suo affare privato, e unico obbiettivo del giudizio era quello di provare la colpevolezza dell’imputato, per permettere ai potenti di liberarsi dai nemici o di impinguare le proprie rendite; l’incertezza e l’oscurità dette leggi rendevano possibile ogni arbitrio.
Tutto questo sistema era coperto dalle giustificazioni di carattere religioso approntate dalla Chiesa. Come il diritto al dominio di qualsiasi signorotto era giustificato da una pretesa investitura divina, cosi le peggiori atrocità commesse sul corpo dell’imputato erano giustificate identificando il delitto col peccato ed affermando la conseguente necessità di “purificare” il reo.
Contro una simile situazione erano già insorti altri autori, prima del Beccaria; particolare risonanza avevano avuto i molti volumi del Montesquieu su Lo spirito delle leggi, pubblicati per la prima volta nel 1748, nei quali si trattava anche del diritto penale. Nessuno, però; aveva saputo dipingere le atrocità del sistema, abbattere i tentativi di giustificazione, additare i nuovi principii, con la forza e l’incisività di Cesare Beccaria.
L’antitesi tra il vecchio e il nuovo balza viva da tutto il testo dell’opera. Al cupo misticismo medioevale si oppone una concezione utilitaristica, che vede il delitto come un turbamento del sistema di convivenza degli uomini e le pene come un mezzo per impedire tale turbamento e permettere ai cittadini di vivere liberi e sicuri. Le pratiche conseguenze di tali principii sono riassunte nelle parole della conclusione, che l’Assemblea Nazionale francese riportò quasi testualmente nell’art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino: “perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi”.
L’affermazione rivoluzionaria del valore della personalità umana è sintetizzata nella frase del capitolo XXVII: “Non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l’uomo cessi di essere persona e diventi cosa”.
ln tal modo, mentre la morale religiosa tendeva a giustificare le crudeltà di un sistema ormai putrido, la morale utilitaristica di Cesare Beccaria, largamente influenzata dalle correnti materialistiche dell’illuminismo, esprimeva le profonde esigenze umane di quanti soffrivano sotto il giogo del regime feudale; proprio per il sito profondo senso di umanità egli, trattando di alcuni delitti, seppe tratteggiarne l’ origine reale, posta nella miseria e nell’ingiustizia, ed aprì quindi la strada alla ricerca veramente scientifica delle cause dei reati.
Contro la parola di giustizia che veniva dallo scritto del Beccaria reagirono i tiranni e, in modo particolarmente duro e ufficiale, la Chiesa. La Sacra Congregazione dell’Indice colpi il trattato con il suo decreto del 3 febbraio 1766 ed ancora oggi l’ultima edizione dell’“Indice” lo pone fra i libri proibiti.
Eppure Cesare Beccaria non era un rivoluzionario. Il suo libro non si rivolgeva alle grandi masse, ma ad un ristretto ambito di intellettuali. Egli credeva che le riforme del sistema feudale potessero essere realizzate da principi illuminati. Né la cosa deve destare stupore: nella situazione italiana, in cui le peggio angherie erano commesse proprio dai piccoli tiranni locali, era facile pensare che la lotta dell’assolutismo monarchico per l’accentramento del potere potesse assumere un contenuto progressivo.
Neanche il temperamento di Cesare Beccaria era quello di un rivoluzionario. Di fronte alle accuse rivoltegli di irreligiosità e di sovversivismo egli sente la necessità di discolparsi e, nell’introduzione, aggiunta dopo la prima edizione apparsa anonima, dice ripetutamente di non aver mai voluto offendere né i potenti né la religione, ma dichiara: “Si tosto che questi principii (politica e religione) vengano confusi, non v’è speranza di ragionare bene nelle materie pubbliche”.
Chi sa se egli si rendeva pienamente conto del profondo significato rivoluzionario di questa affermazione! Certo non avrebbe mai sospettato che la stessa frase sarebbe stata sempre ripetuta, in seguito; da quanti non hanno ritenuto incompatibile accettare un’ideologia religiosa e contemporaneamente lottare contro le ingiustizie e i privilegi, da chiunque fossero difesi.





