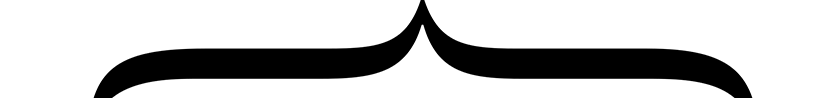Un aereo vola sopra il cielo di New York e si schianta contro il Word Trade Center. Il nuovo millennio, per la comunità internazionale, è stato inaugurato da una serie di immagini che potrebbero essere tratte dai film apocalittici del cinema americano. Quei film, sospesi tra disastri ambientali e invasioni aliene, avevano preparato il nostro immaginario: ci avevano abituati a esplosioni, grattacieli in fumo, metropoli in macerie.
 Quelle immagini, in un qualche modo, ci avevamo messo nelle condizioni di fare i conti con la deflagrante eccedenza dell’attentato dell’11 settembre. Un evento, si potrebbe cinicamente osservare, spettacolare e sublime, tanto che il compositore Karlheinz Stockhausen – non senza ricevere feroci critiche – lo definì “la più grande opera d’arte possibile nell’intero cosmo”.
Quelle immagini, in un qualche modo, ci avevamo messo nelle condizioni di fare i conti con la deflagrante eccedenza dell’attentato dell’11 settembre. Un evento, si potrebbe cinicamente osservare, spettacolare e sublime, tanto che il compositore Karlheinz Stockhausen – non senza ricevere feroci critiche – lo definì “la più grande opera d’arte possibile nell’intero cosmo”.
Siamo oggi nel pieno di quel millennio che ha spettacolarizzato anche il più brutale degli eventi e lo vediamo chiaramente in queste settimane di guerra in Ucraina. Lo ha scritto qualche giorno fa la semiologa Giovanna Cosenza su “Il Fatto quotidiano”. Dagli studi televisivi, dove uno stato di allerta perenne sembra sempre sul punto di tradire eccitazione e in fondo contentezza per l’ennesima e tragica breaking news, ai reportage montati con accompagnamenti musicali pensati per suscitare emozione – gli stessi che ritroviamo negli spot o nelle scene drammatiche nelle serie televisive –, la realtà finisce per confondersi con la fiction e le immagini dall’Ucraina perdono il potere di bucare il velo della nostra attenzione. O meglio: ci avvincono in quanto tele-spettatori, ma non ci coinvolgono nella nostra qualità di attori. D’altro canto, proprio il prefisso tele– rimanda all’idea della distanza e lo schermo – la grande superficie in cui oggi tutto si mostra, si commenta, si dà – reca in sé l’idea della “protezione”. Schermo totale, come una buona crema solare.
 È chiaramente una questione di punti di vista. Come ha osservato Francesca Mannocchi, “abituarsi alla guerra” è un’esperienza assai diversa se a viverla sono coloro che il conflitto lo subiscono o coloro che – al sicuro – lo guardano. Se per noi spettatori l’abitudine è assuefazione, per chi vive sotto le bombe l’abitudine è il tentativo vitale di trovare una nuova normalità. Allo stesso modo, ciò che per noi “tele-spettatori” prende le sembianze macabre dell’entertainment, per l’occhio dei civili protagonisti “la guerra è davvero molto poco ‘cinematografica’: ha le sembianze di una costante lotta contro la dimensione più elementare della propria sopravvivenza, fatta di cibo e riscaldamento”.
È chiaramente una questione di punti di vista. Come ha osservato Francesca Mannocchi, “abituarsi alla guerra” è un’esperienza assai diversa se a viverla sono coloro che il conflitto lo subiscono o coloro che – al sicuro – lo guardano. Se per noi spettatori l’abitudine è assuefazione, per chi vive sotto le bombe l’abitudine è il tentativo vitale di trovare una nuova normalità. Allo stesso modo, ciò che per noi “tele-spettatori” prende le sembianze macabre dell’entertainment, per l’occhio dei civili protagonisti “la guerra è davvero molto poco ‘cinematografica’: ha le sembianze di una costante lotta contro la dimensione più elementare della propria sopravvivenza, fatta di cibo e riscaldamento”.
Allora, come scrive Andrea Braschayko su “Valigia Blu”, “c’è urgente bisogno di riscoprire la sofferenza umana che la guerra porta con sé; una cosa sempre più difficile nell’epoca in cui la guerra è in diretta su Telegram e poi rielaborata nei salotti televisivi”. Se, come fa notare Romano Madera, “la guerra è una delle più vendibili forme di intrattenimento, meglio delle serie dei gialli, che solletica le nostre lugubri passioni e stordisce la potenziale introiezione del lutto”, come destarci da quella fruizione acritica, come allenare l’empatica, come sentire che quella contabilità delle vittime è fatta di uomini e donne, no stuntman ma vite in carne ed ossa?
Sono domande che abbiamo il dovere di farci al centesimo giorno di guerra. Sappiamo, infatti, quanto rapidamente si produca assuefazione, quanto rapidamente si perda interesse, quanto rapidamente quel moto spontaneo e traboccante di solidarietà si trasformi in indifferenza, se non addirittura in fastidio.
 Due, potremmo dire, sono gli scogli da superare: da un lato, il senso di impotenza. L’idea che ci sia una sproporzione incolmabile tra l’insignificanza di quel che possiamo e l’enormità degli eventi, dalla guerra al cambiamento climatico. Ne parlava già Hans Jonas a proposito dello scacco cui va incontro il principio di responsabilità. Dall’altro, quel modo vischioso che ci avviluppa al quotidiano, quel surfare tra notizie shock e spot, seguendo la corrente, senza mai metter fuori la testa per prendere fiato e distanza critica.
Due, potremmo dire, sono gli scogli da superare: da un lato, il senso di impotenza. L’idea che ci sia una sproporzione incolmabile tra l’insignificanza di quel che possiamo e l’enormità degli eventi, dalla guerra al cambiamento climatico. Ne parlava già Hans Jonas a proposito dello scacco cui va incontro il principio di responsabilità. Dall’altro, quel modo vischioso che ci avviluppa al quotidiano, quel surfare tra notizie shock e spot, seguendo la corrente, senza mai metter fuori la testa per prendere fiato e distanza critica.
Per paradosso quel che forse ci manca è proprio la distanza: distanza che non è distacco o disinteresse, ma capacità di guardare le cose da una prospettiva che non ci schiacci sull’attimo, sull’ultimo titolo sensazionalista, sull’ultima polemichetta da trend topic.
Quella distanza, che è insieme ricerca di nitidezza e adesione partecipe, può darcela la storia come tentativo di riscattare una temporalità che si è via via atrofizzata sotto dettatura della cronaca, offrendo chiavi di lettura che ricostruiscano nessi e processi di lungo periodo.
Proviamo a farlo in questo speciale, a partire dall’idea che la storia costituisca un grande terreno di incontro e negoziazione delle molteplici posizioni che compongono la società e che devono animare la cittadinanza, soprattutto in direzione di un pensiero e di un patto per il “dopo”, da costruire anche grazie al prisma della storia.
Guardata con prospettiva storica, questa guerra ci dà sicuramente modo di stigmatizzare l’uso politico che Vladimir Putin sta facendo del passato recente, come osserva Giulia Lami; ma consente all’Europa anche un momento di autocoscienza. Come dice Andrea Ruggeri, “l’idea di un’Europa distante dalla violenza, continente che si credeva ormai parte di una storia pacifica, viene infranta dalla forza storica di eventi che credevamo facessero parte del passato. Ci eravamo illusi in un futuro irenico e ignoravamo un presente violento. Siamo rimasti disorientati dalla riscoperta del conflitto dopo che per anni nel discorso pubblico in Italia ed Europa avevamo utilizzato parole e neologismi che evitassero di menzionare l’uso della forza, sebbene fossimo diretti attori – anche di violenza – in contesti di guerra”.
Per una bibliografia sintetica
#Invezione tradizione
- Norman Davies 2011: Vanished Kingdoms: The History of Half-Forgotten Europe.
- Anne-Marie Thiesse La création des identités nationales Éditions du Seuil, 1999, (traduzione inglese : The Creation of National Identities Europe, 18th-20th Centuries).
- Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.
- Eric Hobsbawm Nazionalismo. Lezioni per il XXI secolo (curato da Donald Sassoon).
- Charles Tilly, The Formation of National States in Western Europe, 1975.
- Charles Tilly, Coercion, Capital, and European States.
#conflitto russo-ucraino
- G. Lami, Storia dell’Europa orientale. Da Napoleone alla fine della prima guerra mondiale, Mondadori Education, Milano-Firenze, 201.
- G. Lami, Ucraina 1921-1956, Cuem, Milano, 2008.
- G. Cella, Storia e geopolitica della crisi ucraina, Carocci, Roma, 2021.
- A. Zafesova, Navalny contro Putin, Roma, Paesi edizioni, 2021.
- Memorial Italia (a cura di), Ucraina. Assedio alla democrazia. Alle radici della guerra, Corriere della Sera, Milano, 2022.
#storia e guerre
- Michael Howard, War in European History, Oxford University Press, Oxford 2009.
- Michael Howard, The Invention of Peace and the Reinvention of War, Profile Books, London 2002.
- Stathis Kalyvas, The Logic of Violence in Civil War, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
- David Armitage, Civil Wars. A History in Ideas, Yale University Press, Yale 2018.
- Lawrence Freedman, The Future of War. A History, Penguin, London 2017.
#nazione come ordigno ideologico
- Cammarano, I civili come nemici, “Mentepolitica”, 27-4-2022.
- Herling, P.G. Zunino (a cura di), Nazione, nazionalismi ed Europa nell’opera di Federico Chabod, Firenze, Olschki, 2002.
- Hermet, Nazioni e nazionalismi in Europa, Bologna, Il Mulino, 1997.
- E.J. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismi dal 1780, Torino, Einaudi, 2002.
- Zweig, Il mondo di ieri. Ricordi di un europeo, Milano, Mondadori, 1946.
History Lab: quattro seminari internazionali online sulla piattaforma zoom

Perché raccontare la Storia oggi? A cosa serve?
Almeno per un buon motivo e cioè quello di trovare un intreccio e un filo tra storie dal basso, le storie collettive e storia pubblica.
È dunque necessario costruire storie che prestino attenzione a quei soggetti che spesso la storia l’hanno fatta, ma poi se la sono sentita raccontare da altri ovvero coloro che spesso sono raffigurati come «spettatori di storia».
Rispetto a una visione discriminante della storia, noi ne proponiamo invece una partecipata e collettiva e per ciò riteniamo che occorra recuperare le voci emarginate per dare spazio alle esperienze e ai percorsi diversi.
Quale modello di relazioni stiamo costruendo? Dopo due secoli, stiamo tornando all’”Europa del Congresso di Vienna“?
Ne parliamo in un ciclo di quattro seminari internazionali, quattro History Lab, a cui è possibile assistere attraverso piattaforma Zoom, che affronteranno queste tematiche nel lungo periodo a partire da questi interrogativi.