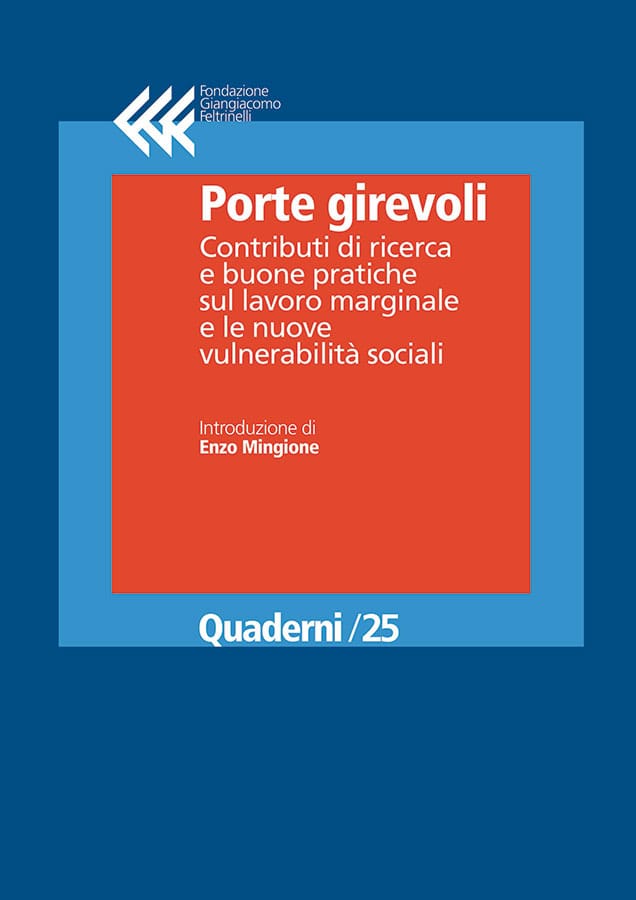Scrivo queste righe nei giorni più drammatici della pandemia covid-19 e delle conseguenti trattative in sede europea per la messa a punto di un piano di azione concordato per affrontare le conseguenze economiche e sociali che ne derivano. Semplificando, si starebbero fronteggiando due schieramenti: uno favorevole alla piena condivisione dei costi delle misure emergenziali, uno che invece vi si oppone, facendo leva sui rischi (e, quasi, la “immoralità”) di farsi carico dei debiti dei paesi “meno virtuosi”.
Cosa c’entra questo con la ricorrenza del cinquantesimo anniversario dello Statuto dei lavoratori? Pare che la posizione più intransigente nei negoziati sia quella dell’Olanda, che minaccia di veto qualsiasi opzione che preveda una qualche forma di mutualizzazione delle spese. È opinione comune che si tratti di un paese economicamente “virtuoso” e quindi che, tutto sommato, non abbia tutti i torti; al più, si fa appello allo spirito solidale.

Questa opinione risulta in realtà paradossale se si considera la spietata concorrenza fiscale che l’Olanda compie nei confronti degli altri Paesi europei: basti pensare che la famiglia Agnelli, non certo secondaria nella storia dell’Italia moderna, controlla tutte le proprie attività tramite la finanziaria Exor, società olandese. Quello dei Paesi Bassi è solo un esempio (certo, reso più grave dal fatto che i due Paesi in oggetto siano entrambi membri dell’Unione Europea) di un sistema economico internazionale basato su una concorrenza – anche – finanziaria sostanzialmente priva di regole, che, nelle sue varie articolazioni (investimenti all’estero, offshoring, ecc.) ha effetti non limitati alla diretta sottrazione di risorse alla fiscalità generale. Si può infatti dire che il regime (quasi) globale di piena libertà di movimento dei capitali ha alterato e continua ad alterare il terreno di gioco in cui si determina il patto sociale, indebolendo in maniera sistematica una delle componenti, quella del lavoro. E lo Statuto dei lavoratori può essere considerato, prima di tutto, un’articolazione del patto costituzionale italiano: non a caso, nessuna delle forze parlamentari espresse voto contrario al momento della sua approvazione.
In queste poche righe, vorrei mettere in evidenza alcune ragioni a sostegno di quanto appena affermato, espandendo una riflessione condotta in altra sede, qui tralasciando però di fare cenno a quelli che possono essere invece, secondo letteratura ed esperienza storica, i possibili effetti economici positivi dei movimenti di capitale: non di questo si occupa questo scritto. In primo luogo, occorre notare come queste note non riguardano solamente i movimenti che, per semplicità, potremmo definire “puramente finanziari” e che hanno un orizzonte temporale breve, ma anche i cosiddetti investimenti diretti esteri, che hanno per loro natura una maggiore rigidità e rimangono quindi più a lungo nel Paese di destinazione. Se è difficile negare che i potenziali spostamenti massicci dei primi, che si muovono istantaneamente da un Paese all’altro, generino un “ricatto” di instabilità macroeconomica che condiziona pesantemente l’attività di governo (attraverso le cosiddette fughe di capitali), va sottolineato che un simile ricatto si verifica anche nel caso dei secondi. E si tratta di un ricatto che riguarda principalmente i lavoratori. Infatti, la sola possibilità “astratta” di spostare gli investimenti conferisce ai datori di lavoro una credibile ed effettiva minaccia nei confronti dei lavoratori e dei sindacati che li rappresentano: in poche parole, o questi accettano salari più bassi, o le imprese trasferiranno la produzione all’estero. Questo avviene, si noti bene, anche senza che si verifichi realmente il trasferimento della produzione. Anche il comportamento dei governi si modifica di conseguenza: è noto come i regimi di protezione del lavoro si siano fortemente indeboliti nei Paesi OCSE negli ultimi 30 anni. Sono le statistiche dell’Organizzazione stessa a testimoniarlo.
Ma non è questo l’unico canale attraverso cui il regime di piena libertà dei capitali dispiega i suoi effetti. Infatti, quanto più è facile spostare capitale all’estero, tanto più i gorverni saranno incentivati i governi a perseguire politiche che aumentino il tasso di rendimento degli investimenti entro i confini nazionali. Questa dinamica è in effetti al centro anche del dibattito sui cosiddetti eurobond (adesso coronabond), essendo centrale nell’allargarsi dello spread rispetto ai titoli di Stato tedeschi, sui quali si dirottano i capitali in caso di turbolenza. La fragilità economico-finanziaria del nostro Paese fa sì che governi ed elettori siano particolarmente sensibili alla clava ideologica, e sostanziale, secondo la quale dovremmo votare in modo da assecondare il giudizio de “i mercati”, soprattutto in occasione di grandi shock economici. Infatti, con buona pace di chi pensa di vivere in un mondo sottoposto alla pressione di onde di immigrati che si insinuano in ogni faglia aperta nei nostri confini, in realtà i lavoratori, e con essi gli immigrati, hanno una mobilità estremamente inferiore rispetto ai capitali. Il lavoro, in quanto meno mobile, tende ad assorbire la maggior parte dei costi degli shock che si abbattono sulle economie nazionali: da qui, le raccomandazioni all’austerità e alla necessità di sacrifici per rendere il nostro Paese attraente per i capitali stranieri e non far lievitare il costo del finanziamento del debito; politiche che avrebbero dovuto condurci fuori dalla crisi, e che in questa ci hanno avvitato più che ogni altro Paese europeo, lasciando sul percorso un lavoro sempre più povero e meno tutelato. Il capitale può muoversi con più facilità da un Paese all’altro, alla ricerca di scenari economici più favorevoli (in una sorta di “migrazione economica” ampiamente tollerata, anzi: incoraggiata dalle istituzioni che regolano il sistema globale).
Così, come si diceva in apertura, è di nuovo la politica fiscale a mutare in conseguenza a questo differenziale di mobilità tra capitale e lavoro: la fiscalità dello Stato, che è chiaramente correlata con la capacità di spesa dei governi, si basa, in termini generici, sulla possibilità di tassare ciò che sta all’interno dei confini nazionali. Ancora una volta, sarà il carico fiscale applicato al lavoro a crescere, essendo questo fattore meno mobile: anche questa è un’ipotesi che trova riscontro nell’evoluzione dei regimi fiscali degli ultimi decenni. Peraltro, anche quando il carico fiscale sul lavoro non aumenta in termini assoluti, la stessa dinamica può “giocare d’anticipo” ed erodere la spesa sociale, date le minori entrate da imposte sul capitale, con effetti analoghi sugli standard di vita dei lavoratori. È quindi lecito aspettarsi che politiche che favoriscono una maggiore mobilità dei capitali siano associate a tagli alla spesa pubblica e minori deficit di bilancio pubblico, elementi che di per sé possono operare una pressione al ribasso sui salari. Per esempio, quando rendono il salario dei dipendenti pubblici stagnante o in diminuzione relativa, riducendo così il potere contrattuale dei lavoratori (o dei sindacati che li rappresentano) anche nel settore privato.
Le dinamiche illustrate tendono inoltre ad autoalimentarsi, secondo un tipico andamento beggar-thy-neighbour, per cui un governo cerca di adottare misure favorevoli ai capitali nel tentativo di incentivare l’afflusso proveniente da altri Paesi, che saranno perciò spinti a misure ancor più favorevoli, e così via. Purtroppo, come si diceva, il quadro comunitario europeo non fa eccezione e la concorrenza fiscale e in termini di diritto del lavoro è pratica usuale tra gli Stati membri.
È stato detto da più parti che l’attuale pandemia sarà occasione di una ripartenza su basi diverse: che occorre ripensare il sistema, i nostri orizzonti di sviluppo, cambiare la globalizzazione, restituire dignità al lavoro e ridurre le disuguaglianze. Secondo la ricostruzione qui brevemente illustrata, la globalizzazione influisce sulla distribuzione del reddito soprattutto attraverso i suoi effetti sulla posizione negoziale di lavoro e capitale. Probabilmente, la piena libertà nei movimenti di capitali è la più determinante delle regole del gioco entro le quali si muovono i contratti nazionali tra le componenti sociali. Anzi, è forse la regola del gioco per eccellenza della globalizzazione (ne ha d’altra parte accompagnato la nascita, se pensiamo a quanto diverso era in questo ambito il regime di Bretton Woods), dato che gli altri due pilastri teorici del sistema internazionale contemporaneo, libertà di movimento delle persone e delle merci, sono al più solo parzialmente promossi e rispettati. Ciò che preoccupa, allora, è che la questione della regolamentazione dei movimenti di capitali non sia al centro dell’agenda di riforma. E che non lo sia stata in tutti questi anni, neppure a seguito dell’ultima grande crisi prima dell’attuale, dalla quale, in realtà, non siamo usciti. Dovrebbe quindi essere priorità del sindacato e delle forze politiche che si preoccupano delle condizioni dei lavoratori: sarebbe lo strumento più adeguato ad attualizzare e ridare fiato anche ad altre battaglie storiche, come la necessaria difesa di un baluardo di civiltà quale è lo Statuto dei lavoratori. Con il sospetto, tuttavia, che le battaglie perse, come quella sull’Articolo 18, siano state perse anche perché essenzialmente di retroguardia. Non sarebbe di retroguardia, invece, promuovere la tutela del lavoro e della giustizia sociale attraverso la limitazione di rendite e profitti, la cui quota, sul totale del reddito e della ricchezza mondiale, si è andata espandendo senza ostacoli negli ultimi decenni, a spese di chi, invece, nel frangente attuale, con ancor più urgenza sente sulla propria pelle l’insostenibilità di regole sempre più inique.
Scarica la fonte
Massimo Roccella, Lavoro subordinato e lavoro autonomo, oggi
“Quaderni di sociologia” n. 46/2008, pp. 71-112. Clicca qui