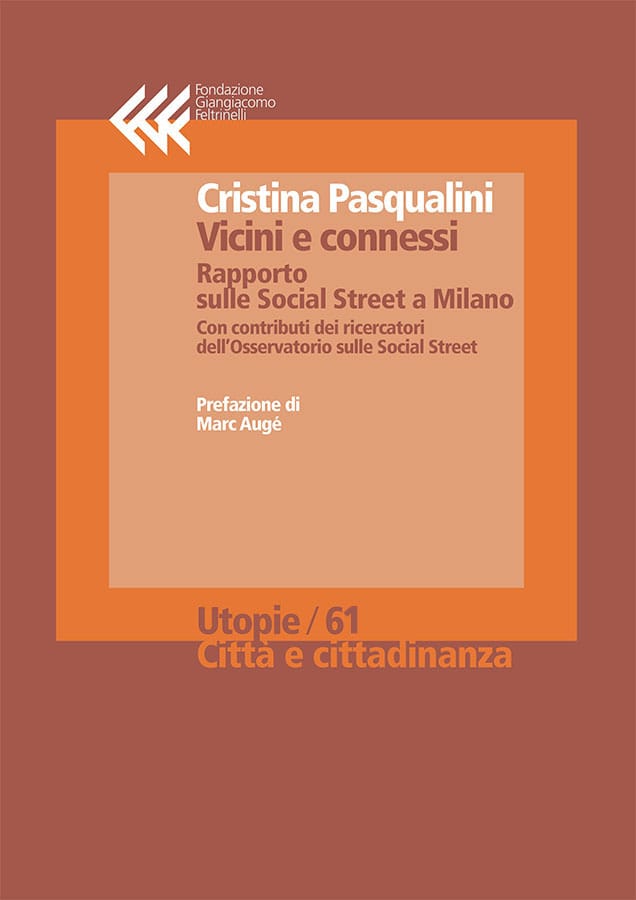Con oltre 5 milioni di stranieri regolarmente presenti (Idos, 2018), dei quali il 70% “a tempo indeterminato” (perchè comunitari o con permesso di lungo periodo), l’immigrazione in Italia è ormai un fenomeno strutturale e consolidato. A questi si aggiunge una popolazione più fluttuante e in parte potenzialmente ‘temporanea’ costituita dai richiedenti protezione internazionale, assai più ridotta (c.a. 180 mila, secondo l’ultimo rapporto della fondazione Migrantes) ma talmente mediatizzata e strumentalizzata negli ultimi anni da essere comunemente percepita come “l’unica” immigrazione presente. Questi nuovi arrivi, comunque, alimentano solo in minima parte le diversità e pluralità che già da tempo caratterizzano gran parte delle città italiane, grandi o piccole che siano, soprattutto del centro-nord ma sempre più anche nel mezzogiorno.
Eppure il fenomeno continua ad essere letto, presentato, percepito e trattato – complici i toni sempre allarmistici dei media (vedi l’ultimo rapporto Carta di Roma) e i martellanti proclami di partiti e movimenti populisti che in modo palesemente strumentale fanno degli immigrati il capro espiatorio di problemi ben più complessi – come una perenne emergenza e, in quanto tale, da trattare con misure straordinarie. Dal decreto Maroni del 2008 (poi convertito nella L.38/2009) che ha dato il vialibera ai Sindaci di emettere ordinanze – spesso permeate di razzismo e classismo – al “nobile” fine di garantire decoro e pubblica sicurezza, al DASPO urbano, ai Centri di Accoglienza Straordinaria per i richiedenti asilo, le questioni legate all’aumento dell’immigrazione, della diversità e pluralità sono politicamente affrontate come emergenze e spazialmente confinate in ambiti periferici.
Nell’Italia contemporanea, gran parte dei luoghi percepiti nell’immaginario colettivo come ‘periferie’ sono infatti quelli dove ci sono “tanti”, “troppi” immigrati: che ci vivono e/o che ne fanno uso (per incontrarsi, per vendere o acquistare prodotti etnici, per passare il tempo libero). Quartieri o singoli edifici caratterizzati da un progressivo degrado (fisico, economico e/o sociale) e dal conseguente declino del valore immobiliare, dai quali chi poteva permetterselo se ne è andato, hanno lasciato numerosi spazi vuoti –abitativi e commerciali – accessibili più di altri a chi, come gli immigrati, ha in media lavori meno retribuiti. Attenzione però: sebbene si tratti di aree con crescente percentuale di residenti stranieri, non ci troviamo quasi mai di fronte a incidenze superiori al 20 o 30%. Non sono Banlieux, e la mixité (per lo meno quella tra italiani e stranieri, se non quella tra poveri e benestanti) è un dato di fatto, pur non ‘pianificata’ ma indotta da dinamiche di mercato. Si tratta però di ‘quartieri di scarto’ dove rischi, disagi e situazioni difficili si stratificano e dove la concentrazione di vulnerabilità avvia processi cumulativi che aggravano il problema di partenza, alimentando una spirale di povertà ed esclusione socio-spaziale con alto rischio di indebolimento del tessuto sociale, segregazione dal resto della città, stigmatizzazione. All’interno di queste aree la convivenza, il vivere insieme nella differenza (Fincher, ), se non mediata, come minimo acutizza la frammentazione urbana, quando non sfocia in aperto conflitto.

Un lavoratore fa una pausa in un cantiere vicino ai nuovi grattacieli e agli hotel in costruzione a Doha
Spazialmente, queste ‘periferie’ non stanno solo ai margini delle città, nei quartieri popolari a ridosso di grandi vie di comunicazione o isolati in quel che è rimasto dei grandi sogni modernisti dell’utopia urbanistica. Sono anche nei centri storici: nelle città più grandi solitamente nei dintorni delle stazioni ferroviarie centrali, a Milano come a Firenze o Roma, ma anche Padova, Ferrara, e così via; nei centri urbani più piccoli, o nelle aree interne in declino demografico, le ‘periferie’ spesso coincidono con il cuore antico e decadente, semi-abbandonato dagli italiani per standard di vita o modelli abitativi più appetibili e individualisti (tipo la villetta a schiera) che hanno consumato suolo e svuotato il downtown.
Non solo gran parte degli immigrati economici “occupano” i vuoti lasciati dagli italiani – nel mercato abitativo come in quello del lavoro – riciclando (e perchè non dire, rigenerando?) spazi di ‘scarto’ inutilizzati e antichi o umili mestieri, ma lo stesso trend, con conseguente sovrapposizione delle due popolazioni, si rileva nel sistema di accoglienza dei richiedenti asilo. Sia gli SPRAR sia la ben più ampia costellazione di CAS, sono per lo più confinati ai ‘margini’ in periferie ‘sacrificabili’, dove tanto i problemi sono già tanti, siano esse collocate in piccoli comuni dove il bacino elettorale è ridotto (e quindi non si perdono tanti voti), siano le ‘classiche’ periferie urbane o quartieri centralissimi ma ‘degradati’. Stessa dinamica: riempimento ‘casuale’ (unplanned) di vuoti urbani, che le cooperative che lavorano nell’accoglienza riescono a reperire a basso costo: ex-caserme, ex-scuole, ex-alberghi, ex-case… per gli extra-comunitari. Un patrimonio che viene anche riqualificato, perchè fortunatamente gran parte degli enti gestori cercano di offrire standard dignitosi agli ospiti e investono parte del budget per l’accoglienza nel ripristino e manutenzione degli immobili che utilizzano. Il problema è che ciò avviene nella totale assenza di una qualche forma di pianificazione strategica. La gestione emergenziale dell’accoglienza si traduce in una folle corsa a reperire spazi, su richiesta urgente della prefettura di turno, per accogliere chi arriva e viene redistribuito sul territorio rincorrendo il buon principio dell’accoglienza diffusa su scala nazionale, che però dovrebbe essere declinato anche a livello locale con studi che valutino impatti e opportunità nel medio e lungo termine per i contesti di inserimento. In tal senso, una pianificazione strategica e partecipativa sarebbe estremamente utile per mappare, individuare e ragionare collettivamente su quali, tra i tanti immobili (pubblici o privati) disponibili, puntare per limitare conflitti e rigenerare – con progetti integrati che promuovano l’inclusione e l’intercultura – edifici dismessi che possano essere ‘restituiti’ alla città, aperti e permeabili al pubblico, al quartiere dove si trovano, alle contaminazioni ed interazioni tra le persone, magari pensando a usi e funzioni (social housing, studentati, laboratori, turismo sociale, etc.) che possano subentrare quando e se non ci saranno più migranti da ospitare, o anche coesistere fin da subito per contrastare frammentazione e ghettizzazione e favorire la mutua conoscenza, il vivere insieme nella dfferenza (Valentine, 2008).
Certo, nelle aree divenute via via più multiculurali, negli anni sono state promosse – soprattutto dal terzo settore ma anche da alcune amministrazioni più illuminate – innumerevoli pratiche per integrare, conoscere, mediare, costruire ponti, contrastare stereotipi, offrire opportunità di interazione costruttiva tra gli abitanti.
Assente ingiustificata, però, è la pianificazione urbana e territoriale (Marconi, 2014) che, a fronte dell’incalzante aumento delle diversità e della pluralità sociale e culturale in molte periferie, non ha mai saputo (o voluto) assumere alcun ruolo di rilievo – politico, prima ancora che tecnico – nel governo delle trasformazioni che il fenomeno inevitabilmente comporta sul tessuto socio-spaziale urbano, sulla civitas e sull’urbs. Pianificatori territoriali e urbanisti, che “dovrebbero saper ascoltare la società, individuare le esigenze che sollecitano alla costruzione di una città bella perché buona, perché equa, perché aperta. E a quelle esigenze dovrebbero saper dare risposte” (Salzano, 2009) sono stati per lo più assenti dal discorso pubblico sulle migrazioni. Nelle società urbane plurali, dove si moltiplicano le domande di città, e le richieste di ‘diritti’ (d’uso dei suoli, di parola, di partecipazione e di coesistenza) ci si aspetterebbe invece che fossero proprio urbanisti e pianificatori a portare avanti un significativo discorso sulla diversità, l’integrazione e la convivenza plurale (quindi anche sull’idea stessa di città, di urbanità e di civiltà urbana) assumendosi la responsabilità innanzitutto etico-disciplinare di prendere in considerazione un fenomeno tanto rilevante per il presente ed il futuro delle città, e poi sul piano tecnico-professionale di contribuire a governarlo svolgendo una delle funzioni per le quali sono più equipaggiati: quella di mediazione e sintesi tra interessi diversi e contrapposti, propri dei soggetti diversi che popolano l’ambiente urbano (Marconi, 2014). E in questo senso, il tema dell’accoglienza dei richiedenti asilo sembra tanto un’altra occasione persa.