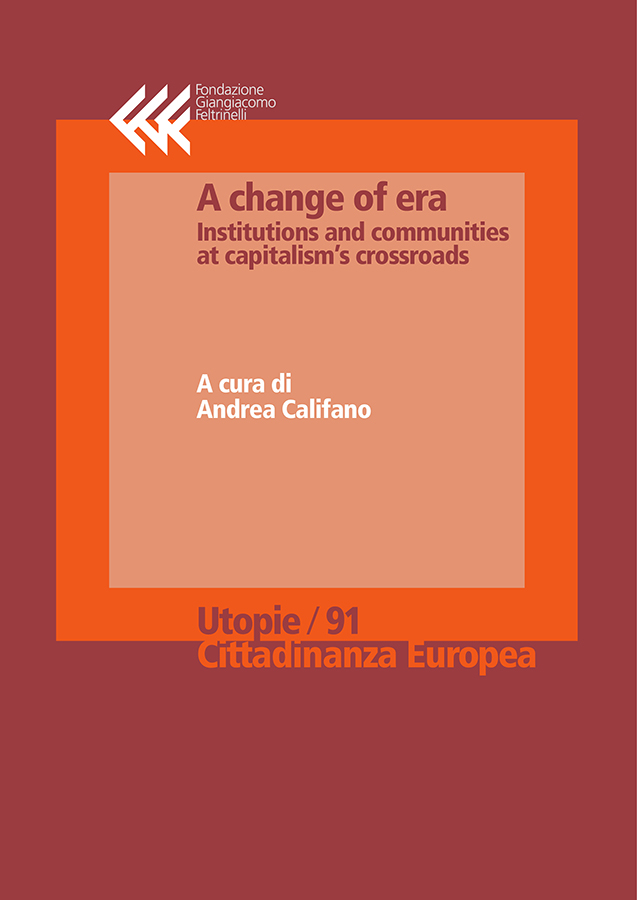Photocredits: Edward Burtynsky, courtesy Admira Photography, Coal Mine, North Rhine, Westphalia, Germany 2015
fonte: Antropocene/Mast
Quest’anno l’Earth Overshoot Day cade di 29 luglio. L’anno scorso era il 1 agosto, 20 anni fa cadeva a settembre, e prima ancora a ottobre. Da questo lunedì fino alla fine dell’anno staremo consumando risorse naturali che l’ecosistema del nostro pianeta non è in grado di rigenerare in un periodo di tempo corrispondente. Se l’attendibilità di queste statistiche può essere discutibile, ciò che non può essere messo in discussione è che il sistema globale nel suo complesso sia caratterizzato da molteplici – e sempre più gravi e pressanti – insostenibilità: forse, si può argomentare che una significativa e preoccupante novità consista nella coesistenza e coevoluzione di tendenze, di tracciati di insostenibilità, che fino ad alcuni decenni fa potevano essere considerati come alternativi.
Un lavoratore dell’Ilva di Taranto, in una bella e malinconica vignetta di Mauro Biani di alcune settimane fa, dice a un compagno: “ricordi quando dovevamo decidere tra la salute e il lavoro?”; “bei tempi”, risponde l’altro. È proprio così: gli stessi lavoratori che vivono sulla propria pelle sfruttamento, insicurezza, marginalità, povertà e, in una parola, mancanza di lavoro, sono anche costretti a vivere, a Taranto così come in mille altri posti, le conseguenze di una gestione scellerata di uno stabilimento che, per lo meno, fino a non molti anni fa, con le sue contraddizioni, aveva dato da mangiare a un territorio, segnandone la vita e la morte.
Non è l’unico caso in cui la questione ambientale diventa immediatamente (cioè subito e direttamente) questione sociale. Alluvioni e smottamenti che colpiscono le soluzioni abitative più precarie (spesso frutto di speculazioni milionarie), desertificazione che impedisce la piccola agricoltura, quartieri urbani periferici lasciati a sé stessi, nei quali traffico e smaltimento di rifiuti non rappresentano più un ipotetico incremento di un fattore di rischio per malattie che, per lo meno, arrivavano sempre più tardi (per la prima volta, invece, nel 2017 è diminuita in Italia – leggi: al sud – anche la speranza di vita alla nascita) ma concrete e pressanti difficoltà nella vita di tutti i giorni.
La cifra di questo momento storico è il disequilibrio: accanto a Places that don’t matter fioriscono città sempre più moderne, vivibili, piacevoli. All’aumento della povertà e della marginalità, sempre più rilevante anche nei Paesi più ricchi, corrisponde un aumento spropositato della ricchezza opulenta di piccole sacche di popolazione che vivono una realtà segregata e parallela. I livelli di disuguaglianze raggiunti negli ultimi lustri hanno pochi paragoni nella storia contemporanea e, come si diceva, non si tratta solo di disuguaglianze in termini di reddito o di ricchezza: chi ha di più ha generalmente anche più accesso ai servizi, vive in un ambiente più salubre, ha possibilità culturali molto maggiori, viaggia, conosce, sogna. Chi ha di meno non ha niente: sempre più privazioni, di tutti i tipi, ambientali, culturali, economiche, sociali, e nessuna prospettiva. È questo il terreno fertile sul quale nascono e si diffondono i cosiddetti populismi: rifiuto del mondo così com’è, sfiducia in ogni alternativa proposta da élite sempre più screditate. Apertura di credito a chiunque proponga di fare piazza pulita, senza badare ai mezzi impiegati. Senza contare infine chi ha perso ogni fiducia in chiunque si candidi a gestire la situazione: il trend dell’astensione nei Paesi industrializzati è il vero allarme democratico dei nostri giorni, indice che la marginalità sociale si è fatta marginalità politica e che il disinteresse verso le forme democratiche è a livelli crescenti e mai visti nella storia recente.
Questo contrasto paradossale si lega ad altri paradossi: tra questi, il fatto che quest’aumento di privazioni avviene in concomitanza con un sempre maggiore sviluppo delle forze produttive, in contemporanea a una rivoluzione industriale che aprirebbe sempre maggiori possibilità di emancipazione umana, che già dovrebbe imporre un 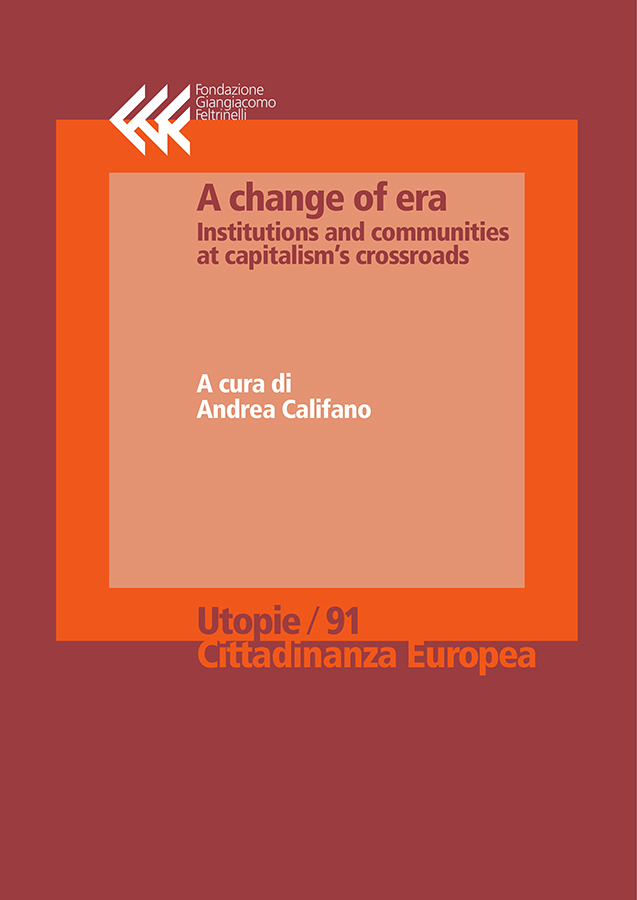 cambio di paradigma, anche teorico: dall’economia della scarsità all’economia dell’abbondanza, come sostiene Marcio Pochmann nell’introduzione di A change of era: Institutions and communities at capitalism crossroads. Infatti, il paradosso è quello di un progresso tecnico impressionante e accelerato, per molti versi scisso da un progresso sociale e culturale. Una sorta di liberazione in principio che non corrisponde a una liberazione di fatto, ricordandoci ogni momento che ogni rivoluzione tecnologica è un processo del tutto politico. Proprio questo può essere considerato il filo conduttore del volume citato: i contributi si interrogano su come gestire il cambiamento. Su come evitare che questo venga subito, che altro non vuol dire se non lasciare che sia chi domina lo status quo a imporre i contorni del processo agli have-nots. Quali cambiamenti istituzionali bisogna cercare, quale può essere il ruolo delle “comunità resistenti”. Che indirizzo devono e possono dare gli attori pubblici? To invest, to regulate e to enable sono le coordinate che scandiscono il volume e l’analisi e che definiscono la possibilità di gestire questo cambio epocale.
cambio di paradigma, anche teorico: dall’economia della scarsità all’economia dell’abbondanza, come sostiene Marcio Pochmann nell’introduzione di A change of era: Institutions and communities at capitalism crossroads. Infatti, il paradosso è quello di un progresso tecnico impressionante e accelerato, per molti versi scisso da un progresso sociale e culturale. Una sorta di liberazione in principio che non corrisponde a una liberazione di fatto, ricordandoci ogni momento che ogni rivoluzione tecnologica è un processo del tutto politico. Proprio questo può essere considerato il filo conduttore del volume citato: i contributi si interrogano su come gestire il cambiamento. Su come evitare che questo venga subito, che altro non vuol dire se non lasciare che sia chi domina lo status quo a imporre i contorni del processo agli have-nots. Quali cambiamenti istituzionali bisogna cercare, quale può essere il ruolo delle “comunità resistenti”. Che indirizzo devono e possono dare gli attori pubblici? To invest, to regulate e to enable sono le coordinate che scandiscono il volume e l’analisi e che definiscono la possibilità di gestire questo cambio epocale.
Così, tornando all’apertura di questo breve scritto, anche la questione ambientale potrà essere affrontata solo con una Trasformazione verde, con un Green new deal che attraverso l’uso congiunto di investimenti, regolazione (ovvero, imposizione di regole che mitigano la prevaricazione del più forte), e attivazione di soggetti e pratiche finora tenute ai margini o in posizione e considerazione subordinata incida nello stesso momento anche sulla questione sociale, su quella economica, culturale. Perché non continuino a essere gli have-nots a pagare il prezzo del cambio di era.