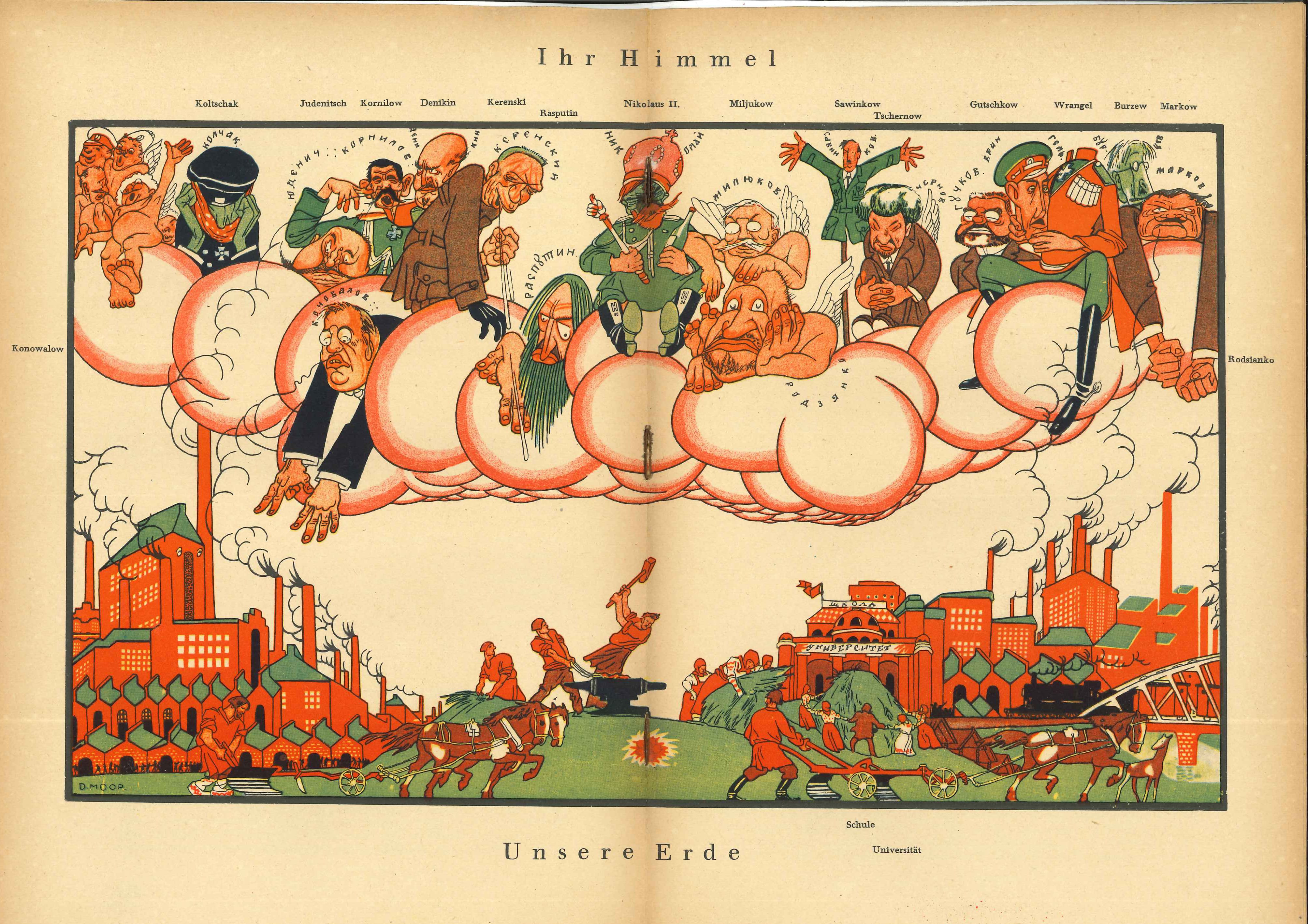credits: Jorit
“Tutto sembra crollare e disfarsi. Ogni tentativo aggregante sembra produrre il ciclo contrario. Nel mondo, nella sinistra, nella piccola provincia italiana. Così, vedere ammainare la bandiera rossa nella torre del Cremlino è stato il simbolo straziante non della morte del comunismo reale ma della disgregazione, della negazione furibonda dei valori dell’altro, del bisogno di distruzione che sostituisce la capacità di progetto”.
Così, nel dicembre 1991, Bruno Trentin – all’epoca Segretario generale della Cgil e autorevole dirigente della sinistra italiana e internazionale – commentava nei suoi diari il crollo dell’Urss, il fallimento dell’esperimento comunista e la chiusura del “secolo breve”, iniziato durante la Prima guerra mondiale con la Rivoluzione d’ottobre (B. Trentin, Diari 1988-1994, a cura di Iginio Ariemma, Roma, Ediesse, 2017, p. 257).
In quelle parole, tuttavia, segnate da angoscia e disperazione, la questione centrale non sembra essere la fine del comunismo, che gli osservatori più attenti consideravano ormai inevitabile da parecchio tempo; in gioco, invece, vi era una prospettiva ancora più ampia e lacerante, vale a dire “l’eclisse della sinistra” (cfr. Bruno Trentin e l’eclisse della sinistra. Dai diari 1995-2006, a cura di Andrea Ranieri e Ilaria Romeo, Roma, Castelvecchi, 2020).
Qualche tempo dopo, nell’agosto 1992, Trentin aggiungeva la seguente considerazione, altrettanto amara:
“Tutte le ideologie sopravvissute, dal riformismo al comunismo, […] sono destinate ad essere unicamente assolutorie e giustificatorie di comportamenti politici concreti completamente avulsi dal progetto originario che le ha viste nascere” (Diari, p. 307).
Il “progetto originario” era ovviamente quello di Marx, presentato nel Manifesto del partito comunista del 1848 (definito da Engels, nel 1890, “il programma comune di molti milioni di lavoratori di tutti i paesi, dalla Siberia alla California”), e poi sviluppato nelle opere successive. Citando un saggio di Corrado Malandrino (Socialismo e libertà, pubblicato da Angeli nel 1990), Trentin concordava pienamente sul fatto che “la rivoluzione era per Marx […] sinonimo di emancipazione umana e di federalismo integrale” (ivi, p. 469). Tuttavia, con il passare del tempo, di fronte a un pensiero complesso e non esente da contraddizioni, i marxisti iniziarono a interpretare il marxismo concentrandosi quasi esclusivamente sulla conquista dello Stato; un limite, questo, già emerso quando Marx era ancora in vita (come mostrava la sua Critica del programma di Gotha), ma che si diffuse dopo la sua morte, divenendo una sorta di dogma con l’affermazione del leninismo, specie dopo il 1917, quando si assistette in modo chiaro alla “separazione del momento del potere dal momento del progetto” (ivi, p. 440).
Anche il Pci, nato nel 1921 con la scissione dal Psi, durante e dopo il ventennio della repressione fascista e dell’epopea antifascista aveva continuato sulla medesima strada;
“la stessa riflessione di Gramsci – avrebbe scritto più tardi Trentin nel suo libro più importante – e alcune tra le sue più feconde intuizioni […] sono rimaste quasi imprigionate dalla deriva statalista ed elitaria […] che ha pervaso gran parte della sinistra di derivazione marxista” (La città del lavoro. Sinistra e crisi del fordismo, Milano, Feltrinelli, 1997, p. 181).
Dalla “via italiana al socialismo” di Togliatti al “compromesso storico” di Berlinguer, il progetto di trasformazione radicale della società era apparso spesso subordinato all’imperativo della conquista prioritaria del potere politico; fino a scadere – nell’ultima fase del Pci – in comportamenti mossi soltanto da logiche di schieramento e da obiettivi elettorali. Occorre precisare, peraltro, che il giudizio severo di Trentin non mirava a criticare il solo mondo comunista, ma anche l’universo socialista e socialdemocratico, italiano ed europeo, anch’esso orientato a imporre dall’alto politiche semplicemente redistributive.
Per questo, sul finire degli anni Ottanta, in particolare dopo la caduta del Muro di Berlino, la crisi definitiva del comunismo e la fine del Pci spinsero Trentin – anche di fronte alla deriva socialista in atto, segnata dal malaffare – a cercare altrove le radici identitarie e progettuali di una nuova sinistra, autonoma e unitaria.
Il suo punto di osservazione privilegiato, al vertice della Cgil, da sempre caratterizzata dalla contaminazione tra differenti culture del lavoro, gli permise di elaborare un’operazione culturale ambiziosa e lungimirante, necessaria per avviare un’efficace svolta politica: non più l’aggancio alla Rivoluzione d’Ottobre e alla (sola) esperienza comunista, ma una sorta di “ritorno alle origini”, alle straordinarie innovazioni introdotte dalla Rivoluzione francese nel 1789, a quei valori di libertà, uguaglianza e fraternità che anche altri intellettuali stavano ripensando e rilanciando proprio nell’anno del bicentenario (cfr. Alberto Martinelli, Michele Salvati, Salvatore Veca, Progetto 89, Milano, Saggiatore, 1989).
Il disegno di Trentin si basava su tre parole-chiave.
La prima era “programma”: la necessità, cioè, di elaborare un progetto politico autonomo, che fosse allo stesso tempo concreto e condiviso, credibile e verificabile, basato non in modo ossessivo sul “problem solving” ma su un approccio costruttivo di “problem setting” (Diari, p. 283); soprattutto, un progetto che non fosse espressione di un’élite, ma che scaturisse dal confronto serrato, quotidiano, con il principale referente della sinistra, il mondo del lavoro.
La seconda parola era “diritti”: il programma, infatti, doveva porsi l’obiettivo di rivendicare e ottenere una sfera sempre più ampia di diritti universali, individuali e collettivi; tra questi, il più importante era proprio il diritto al lavoro, considerato il primo dei diritti sociali di cittadinanza, lo strumento decisivo con cui le persone possono realizzarsi.
La terza parola, infine, era “solidarietà”: difficilmente, infatti, un programma del genere, basato sulla universalità dei diritti, si sarebbe potuto realizzare senza un patto solidale generale, che coinvolgesse anche (e soprattutto) gli “esclusi” e tutti i soggetti più deboli, dai giovani precari agli anziani soli, dai disabili agli immigrati.
A partire dalla Conferenza di programma della Cgil, tenuta a Chianciano nell’aprile 1989, dove Trentin lanciò la formula del “sindacato dei diritti, del programma e della solidarietà”, fino al Congresso confederale di Rimini dell’ottobre 1991, egli si spese affinché il suo progetto di “rifondazione” della sinistra si radicasse dapprima nel sindacato, per poi allargarsi ad altri attori sociali e politici.
Quella scommessa, tuttavia, non ha prodotto risultati rilevanti sul piano pratico, specie a livello di partito. Anzi, l’evidente sproporzione tra lo sforzo intellettuale compiuto e i modesti effetti prodotti finì per prostrare Trentin sul piano fisico e psicologico. Eppure, a trent’anni dalla fine del Pci, il valore culturale e politico di quel tentativo così generoso, lineare nel metodo e innovativo nei contenuti, resta esemplare.
“Da quando esiste – ha scritto in modo efficace Nadia Urbinati su “la Repubblica” (La parola sinistra e la bussola dei diritti, 31 marzo 2015) – la Sinistra si è proposta come una forza che parteggia per quella parte di società che rappresenta bisogni più universali ed è per questo sorgente di diritti”.
La lezione di Trentin può essere ancora decisamente attuale.