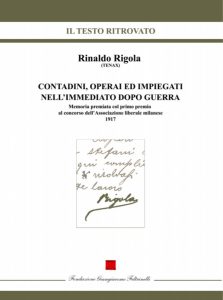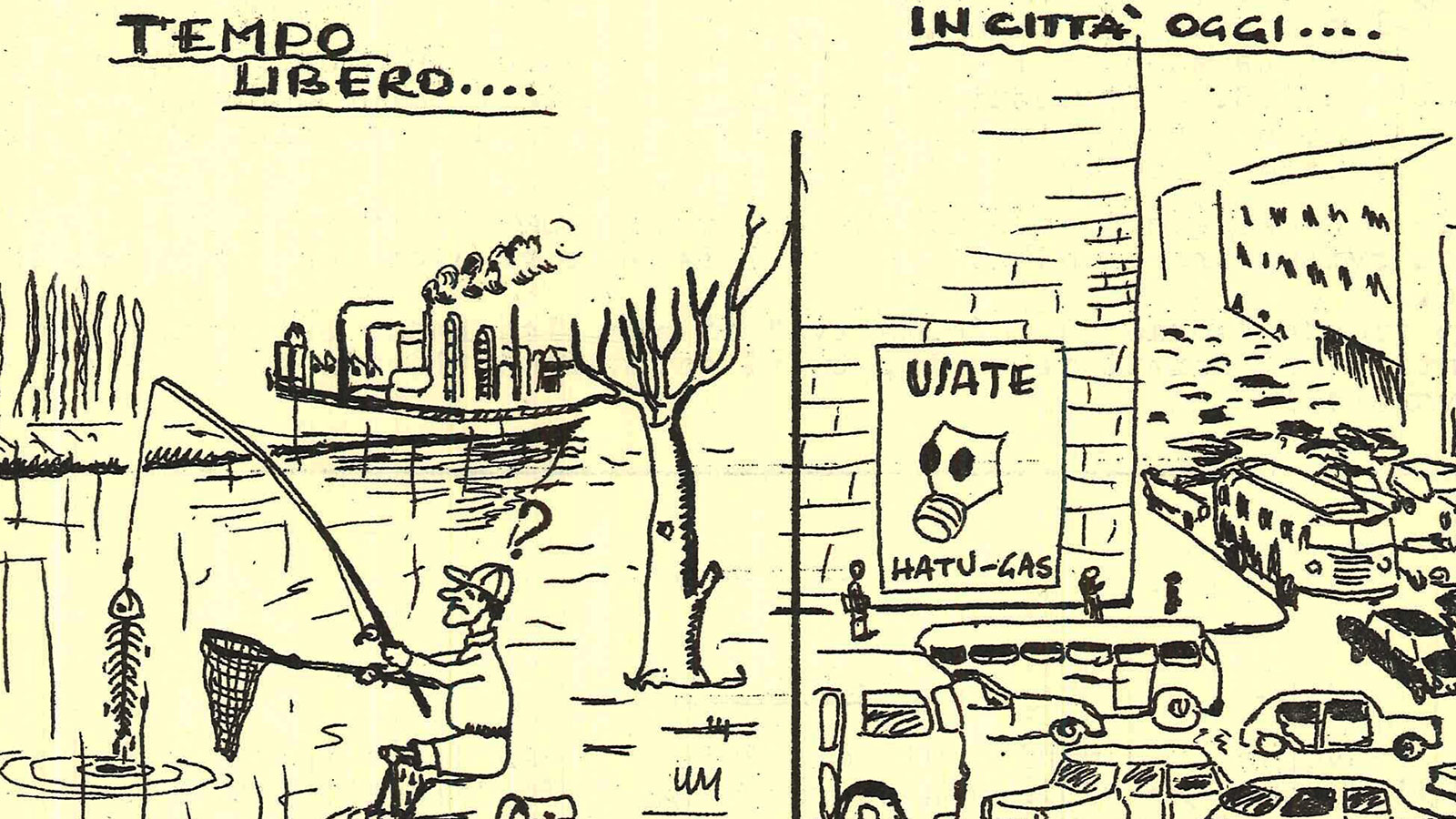Cent’anni fa, nell’estate del 1920, in un’Italia ancora stremata dalle conseguenze della Grande guerra e agitata da acutissime tensioni sociali, gli operai metalmeccanici scesero in lotta per ottenere migliori condizioni di lavoro, orari più contenuti e aumenti salariali. Non era certo la prima volta dopo la fine del confitto mondiale: non erano mancate né conquiste significative, prima fra tutte quella d’orario di otto ore, né sconfitte brucianti, come quella subita dagli operai della FIAT dopo il cosiddetto “sciopero delle lancette” dell’aprile del 1920, in cui la posta in gioco era quella delle regole della disciplina in fabbrica. Ora, facendo tesoro anche di quella sconfitta, si trattava di consolidare e possibilmente migliorare i risultati raggiunti durante la fase “alta” della lotta.
Il 13 agosto gli imprenditori ruppero le trattative con il sindacato, e la FIOM rispose con forme di ostruzionismo che rallentavano la produzione. Il 31 la Confindustria reagì decretando la serrata e chiudendo gli impianti: al che all’inizio di settembre oltre 400.000 lavoratori occuparono le officine in tutta Italia, spesso – in particolare a Torino – presidiandole con le armi e mandando avanti la produzione. La situazione raggiunse l’apice della tensione, ma il governo presieduto da Giovanni Giolitti non intervenne. Tra il 10 e l’11 settembre gli “stati generali” del movimento operaio italiano, ossia i vertici della Confederazione generale del lavoro e del Partito socialista, si riunirono e, a larga maggioranza, demandarono al sindacato la gestione della lotta, scegliendo così di ridimensionarla a vertenza di lavoro ed escludendo che essa potesse essere la scintilla per scatenare la rivoluzione. Il 19 settembre, con la mediazione del governo Giolitti, venne firmata un’intesa che accoglieva buona parte delle richieste sindacali e prevedeva la costituzione di una commissione paritaria avente il compito di formulare proposte legislative per il controllo operaio della produzione.
L’impatto di quelle settimane fu fortissimo nell’opinione pubblica italiana: in realtà però è difficile – un secolo dopo – vedervi un momento cruciale in cui si giocò il destino della storia del paese. L’occupazione delle fabbriche non fu in realtà “l’assalto al cielo” del proletariato italiano, l’occasione rivoluzionaria mancata per l’insipienza – che pure si fece pesantemente sentire -dei suoi gruppi dirigenti. Non fu, insomma, un evento del quale un esito diverso avrebbe potuto invertire il corso del processo storico. Il punto più alto della tensione rivoluzionaria nelle officine era già stato toccato nella primavera del 1920, quando la classe operaia aveva subito le sue prime sconfitte: ora la posta in gioco dello scontro era il consolidamento delle conquiste già ottenute, e l’occupazione degli stabilimenti più una forma di lotta difensiva, pensata come risposta alla serrata, che l’espressione di una forma di potere alternativo. La crisi dello Stato liberale – e con essa dell’apparato coercitivo borghese – era senza dubbio profonda, ma non vi fu in realtà un solo giorno in cui il governo desse la sensazione di aver perso il controllo della situazione, tanto più che l’impreparazione sia politica sia – ancor più – militare delle forze rivoluzionarie era tale da impedire che gli equilibri di potere potessero essere rovesciati.
La forte valenza simbolica di cui l’occupazione delle fabbriche si caricò subito, e che mantenne quasi intatta per oltre sessant’anni, fu dunque, come vide lucidamente Paolo Spriano già nel 1964, il risultato di una duplice mitizzazione: da una parte, quella negativa affermatasi nella pubblicistica fascista, che ne accentuava l’immagine di caos e di violenza per giustificare la provvida reazione che due anni dopo avrebbe “rimesso le cose a posto”, dall’altro quella positiva, «che ingigantiva i termini dell’occasione rivoluzionaria colorandola di romantiche nostalgie».
In questa seconda memoria influì certo significativamente la formazione “ordinovista” della parte più importante di quello che divenne il gruppo dirigente comunista nel 1924. Era stato il gruppo dell’”Ordine Nuovo” di Gramsci, Togliatti e Terracini (con Tasca invece molto più riluttante) a teorizzare la costruzione un potere alternativo – fondato sull’organizzazione dei consigli espressi da tutti i lavoratori, anche i non sindacalizzati, nel cuore stesso della produzione capitalistica – come momento decisivo della rottura rivoluzionaria. Ma nei giorni decisivi gli ordinovisti furono lasciati soli, non meno dal partito che dal sindacato, né del resto la loro proposta aveva sufficiente forza propulsiva per innescare la rivoluzione in tutta Italia.
Poteva finire diversamente? I termini del compromesso raggiunto con l’intesa del 19 settembre erano in realtà notevolmente vantaggiosi per i lavoratori: e l’apertura abilmente concessa da Giolitti all’istituzione di forme di “controllo operaio” sulla produzione in qualche rifletteva l’idea di quella rifondazione dello Stato borghese in termini “corporatisti” (secondo l’espressione di Charles Maier) che non era estranea probabilmente alla cultura politica di uomini come Rigola o come lo stesso Turati.
Alla base di questa idea era uno scambio in forza del quale il consenso dato dal sindacato al sistema democratico-parlamentare avrebbe dovuto essere compensato da un suo peso proporzionale sulle decisioni delle politiche aziendali e di quella economica generale, nonché sulla gestione del mercato del lavoro. Alcune conquiste raggiunte nel 1919 potevano far credere che anche in Italia questa strada – peraltro poi sboccata ovunque in un vicolo cieco – non fosse impercorribile. Ma nel 1920 in Italia non esistevano assolutamente più le condizioni per una soluzione di questo genere.
Anche nell’ipotesi di una pacificazione riuscita dei conflitti di fabbrica – molto irrealistica, data l’attitudine prevalente nel mondo imprenditoriale – restava irrisolto il nodo di una tensione sociale esplosiva nelle campagne, che avevano ancora un peso determinante nell’economia del paese: e fu di lì che divampò la violenza dell’incendio fascista. Nella situazione di oggi, pressati dai suoi imperativi per molti aspetti drammatici, si può anche essere tentati di riflettere sull’esito dell’occupazione delle fabbriche come su un’occasione di confronto, in gran parte mancato, su un modo condiviso di uscire positivamente da una crisi. Ma il rischio sarebbe quello di riproporre capovolto un mito: trasformando quello della rivoluzione in quello della riforma mancata.
Scarica qui le risorse digitali su questo tema:
Scarica le fonti da l’Ordine Nuovo:
L’Ordine Nuovo, Sincadati e consigli, 11 ottobre, 1919
L’Ordine Nuovo, Soviet e consigli di fabbrica, 3 aprile, 1920
L’Ordine Nuovo, Il consiglio di fabbrica, 5 giugno, 1920