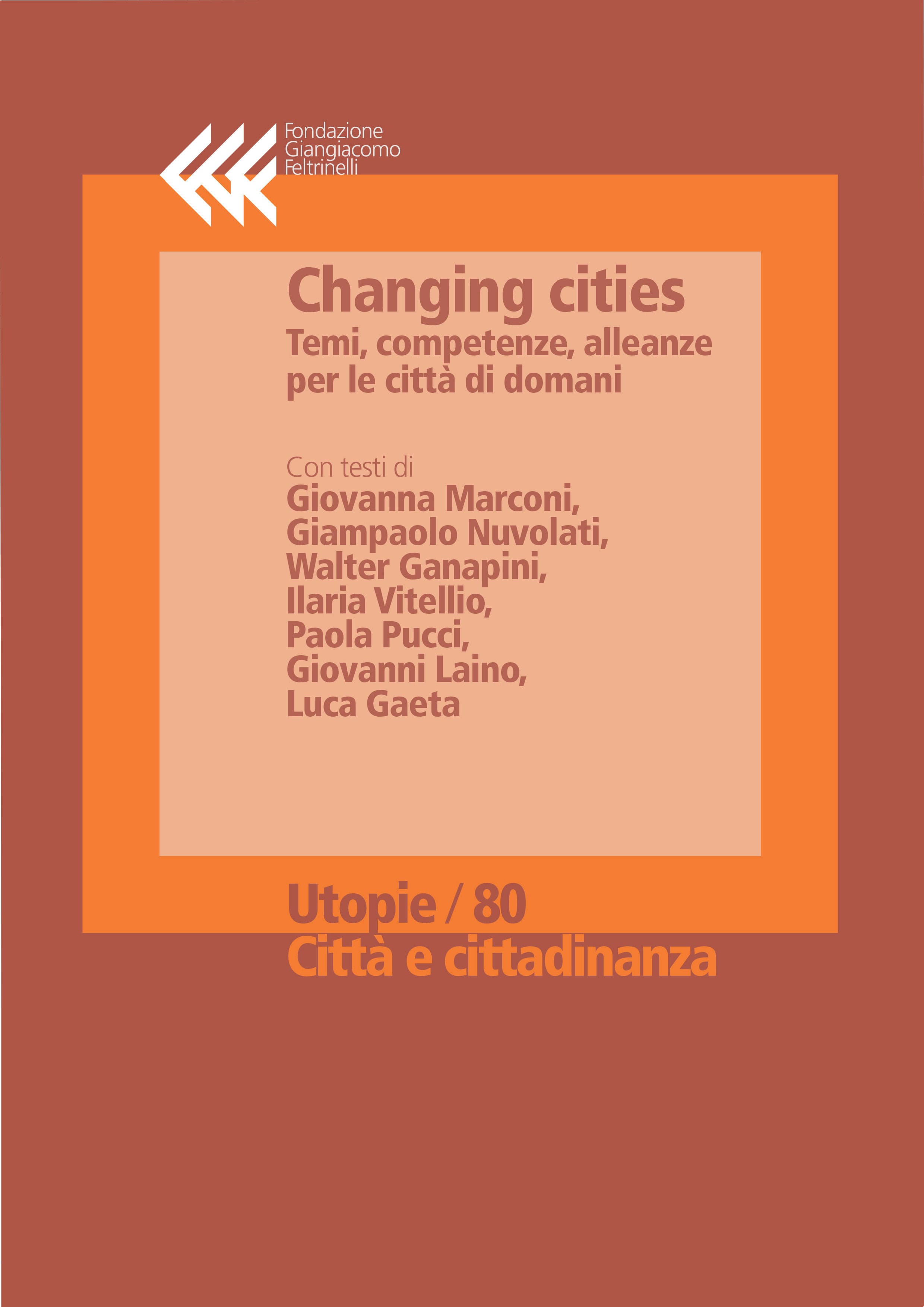Pubblichiamo qui un estratto del saggio di Nicola Capone “Vulnerabilità/relazione: come si cura la città?” pubblicato nel volume Atlante delle città. Nove (ri)tratti urbani per un viaggio planetario.
In che cosa consiste l’abitare? Per rispondere, nel breve spazio di questo scritto, vorrei ricorrere a un testo poco conosciuto di Ivan Illich, dove associa l’uso all’abitare. L’uso – spiega – è strettamente legato all’abitare perché l’uso “dispone”.
Per spiegare questa sua associazione prende come esempio il nido degli uccelli. La sua architettura è costituita raccogliendo rametti dall’ambiente circostante, creando in tal modo uno spazio che diventa il suo luogo di vita, che non coincide esclusivamente nel suo nido.
Si tratta di un luogo risultato di una conoscenza profonda dello spazio circostante, dove le distanze sono la misura esatta del vivere, un luogo “separato” ma in profonda connessione con ciò che è “esterno”. A partire da questa separatezza, gli uccelli instaurano uno scambio continuo tra il “dentro” e il “fuori”, attraverso il quale si svolge tutta la loro vita.
Un nido è sempre installato in uno spazio vissuto, sia esso un albero o il tetto di una casa.
Guardando all’esperienza abitativa italiana, Illich scorge negli “usi civici” la forma più vicina all’annidarsi.
Questa forma del risiedere – che alla fine degli anni Settanta veniva recuperata in molte regioni d’Italia e ancora oggi è un punto di riferimento – si muove lungo il solco tracciato da un’antica tradizione in cui la pratica dell’abitare e del curare lo spazio
di vita prevaleva sull’idea predatoria del prendere possesso esclusivo di un luogo e delle risorse utili al sostentamento.
Le abitazioni, lungo questa tradizione, erano costruite con il legno di un vicino bosco e le pietre dei muri di contenimento di un vecchio terrazzamento.
Quando quella casa cadeva in disuso, le pietre e il legno venivano riutilizzate per riparare un muro a secco, per riallineare il recinto di un gregge, per costruire e alimentare un forno e così via. La vita di quegli esseri umani era come quella dei lombrichi che si nutrono della terra: la lavorano ma, nel mentre, la fertilizzano.
Riflettendo su questo, Illich scrive: “Quando in questa nostra tarda età del cemento armato la gente riprende gli usi civici, spesso è molto difficile incontrare le parole con le quali si può dire quello che si fa.
Questa è la grande difficoltà.
È quindi necessario rimontare al passato remoto per trovare le parole che nettamente indichino l’azione conviviale. Perché la ripresa degli usi civici inevitabilmente spezza il vetro, l’acciaio e il cemento nel quale lo sguardo, la tecnica e la legge del mondo classico hanno trovato il loro mausoleo; le parole del passato più prossimo, le parole del periodo classico non sono in armonia con quello che si vuole dire. Bisogna saper ascoltare le risonanze basse che vibrino in armonia con questa riconquista dell’uso civico – e forse la parola greca oikodomìa è una di quelle”.
In questo termine risiede una grande potenzialità esplicativa ed evocativa. Oikodomìa è una parola formata da òikos – casa nel senso materiale del termine – e domeìn. È su questo secondo termine che l’autore invita a porre l’attenzione. Innanzitutto, perché permette
una valida alternativa al nesso òikos-nomìa.
Non si tratta di amministrare o gestire l’oikos o, detto in termini urbanistici, non bastano gli standard e i servizi sociali per creare l’abitato. Non è il nomein l’elemento germinativo e costitutivo dell’abitare, e non lo sono nemmeno i regolamenti edilizi e le numerose
norme urbanistiche. Piuttosto è il domèin (il ben costruire) che fa dell’òikos il luogo dell’abitare.
Va però chiarito che la radice domèin non equivale a domus, che notoriamente è tradotto con “dominato” – da cui dominus, ossia signore di uno spazio. Illich sostiene che domeìn ha un altro significato, che si è perso nel tempo e che vale la pena recuperare.
Domèin significa saper costruire. Oikodomeìn/ecodomia sta per “arte del ben costruire la casa”, l’arte di “fare proprio” un posto. Ecodomìa, allora, diventa una categoria utilissima, perché ci permette di cogliere la radice ultima dell’abitare, che consiste nell’arte di costruire la casa, che – come l’annidarsi degli uccelli – è il risultato di un processo di apprendimento continuo, un processo in cui viene tramata la rete di relazioni vitali con il vivente e con lo spazio circostante e i suoi elementi costitutivi.
Se queste relazioni vengono meno, lo spazio risulta alienato e noi scivoliamo in una “migrazione interiore” in cui iniziamo a nutrire quella nostalgia propria di chi vive di assenza di luoghi, perché proviamo l’angoscia di chi è stato sradicato e deterritorializzato.
Viviamo “appartati” in “appartamenti” anonimi e alienanti.
Occorre allora essere consapevoli che la “territorialità umana” ha a che fare con la sopravvivenza sociale e culturale, oltre che fisica. È un’urgenza. È una questione di vita o di morte. Prendere dimora ci consente di costruire quell’intimità a partire dalla quale
possiamo godere del mondo, perché è a partire dalla “separatezza”, sapientemente costruita, che possiamo sentire bisogno del mondo e desiderarlo.
Come scrive Franco La Cecla: “il dimorare è la manifestazione del nostro essere separati, ma è anche la felicità di questa condizione (la felicità del limite, della ‘fatica’ dell’adattamento, della sovranità e sottomissione dell’essere autoctono, dell’essere di ‘qualche parte’”.
L’abitare, allora, è fare “mente locale”, è rendersi conto del mondo, è “il mondo circostante sedimentato a tal punto in noi da consentire alla mente di scambiarsi con la superficie del mondo ‘frequentato’”.
Tra l’altro, è proprio a partire dall’abitare, inteso come “ambientamento”, che si costruisce lo spazio pubblico, che è lo spazio di riconoscimento per eccellenza; ma allo stesso tempo lo spazio pubblico è un supporto necessario senza il quale la tensione a insediarsi si annichilisce nella segregazione individuale.
Lo spazio pubblico, potremmo dire, è il “prendere posto” di una collettività, il “farsi spazio” di una pluralità di soggetti, è la costruzione di un mondo in comune, che permette di stare insieme in virtù della differenza che ci costituisce. La sfera pubblica – come
scrive Hannah Arendt – “ci riunisce insieme e tuttavia ci impedisce, per così dire, di caderci addosso a vicenda.
Ciò che rende una società di massa così difficile da sopportare non è, o almeno non è principalmente, il numero delle persone che la compongono, ma il fatto che il mondo che sta tra loro ha perduto il suo potere di riunirle insieme, di metterle in relazione e di separarle”.
Allora, essere espulsi dalla realtà urbana o segregati in una parte di essa, significa minare alla base la possibilità di una dimensione collettiva e relazionale della città.
La “città pubblica” viene meno e con essa viene a mancare la possibilità di una città “abitata”.
“La vita umana in quanto è attivamente impegnata in qualcosa”, insiste Arendt, “è sempre radicata in un mondo di uomini e di cose fatte dall’uomo che non abbandona mai o non trascende mai del tutto. Cose e uomini costituiscono l’ambiente di ogni attività umana, che sarebbe priva di significato senza tale collaborazione; tuttavia questo ambiente, il mondo in cui siamo nati, non esisterebbe senza l’attività umana che lo produce, con la fabbricazione delle cose; che se ne prende cura, con la coltivazione della terra che lo
organizza, mediante l’istituzione di un corpo politico.
Non potrebbe esistere vita umana, nemmeno quella degli eremiti nelle solitudini, senza un mondo che, direttamente o indirettamente, attesti la presenza degli altri esseri umani”.
Per queste ragioni, almeno da mezzo secolo si parla di “diritto alla città” che – come ci ha indicato Henry Lefebvre – consiste nel “rifiuto a lasciarsi escludere dalla realtà urbana da parte di un’organizzazione discriminatoria e segregativa”.21 Diritto alla città può significare, allora, che tutti e tutte abbiamo il diritto a co-produrre lo spazio urbano, a tessere cioè quella rete di relazioni nella quale possiamo imparare a “stare” al mondo come esseri viventi in un mondo vivente.
Un’ecologia delle relazioni multispecie, dove non si vive semplicemente “con” o “malgrado” gli altri esseri viventi, ma in cui ci riconosciamo “implicati” gli uni agli altri e alle altre, esseri umani e non-umani, dove impariamo a “sentire” l’alterità che siamo e dinanzi alla quale re-stiamo continuamente esposti. Un fare mondi, che è sempre un esercizio collettivo, un agire con le altre creature, un con-divenire, un con-fare, una “simpoiesi” – come direbbe la filosofa della scienza Donna Haraway – in cui determinante è il primato ontologico della relazione sui singoli enti, per cui le creature non precedono mai le loro relazioni.
“Come in permacultura le specie compagne – le commensali della terra – portano avanti forme di recupero parziale, lavorano la terra nella terra, creano rifugi multispecie, imparano le une dalle altre a partire dalla materialità situata dei problemi che affrontano: nessuno vive ovunque; tutte vivono da qualche parte. Niente è connesso a tutto, tutto è connesso a qualcosa”.