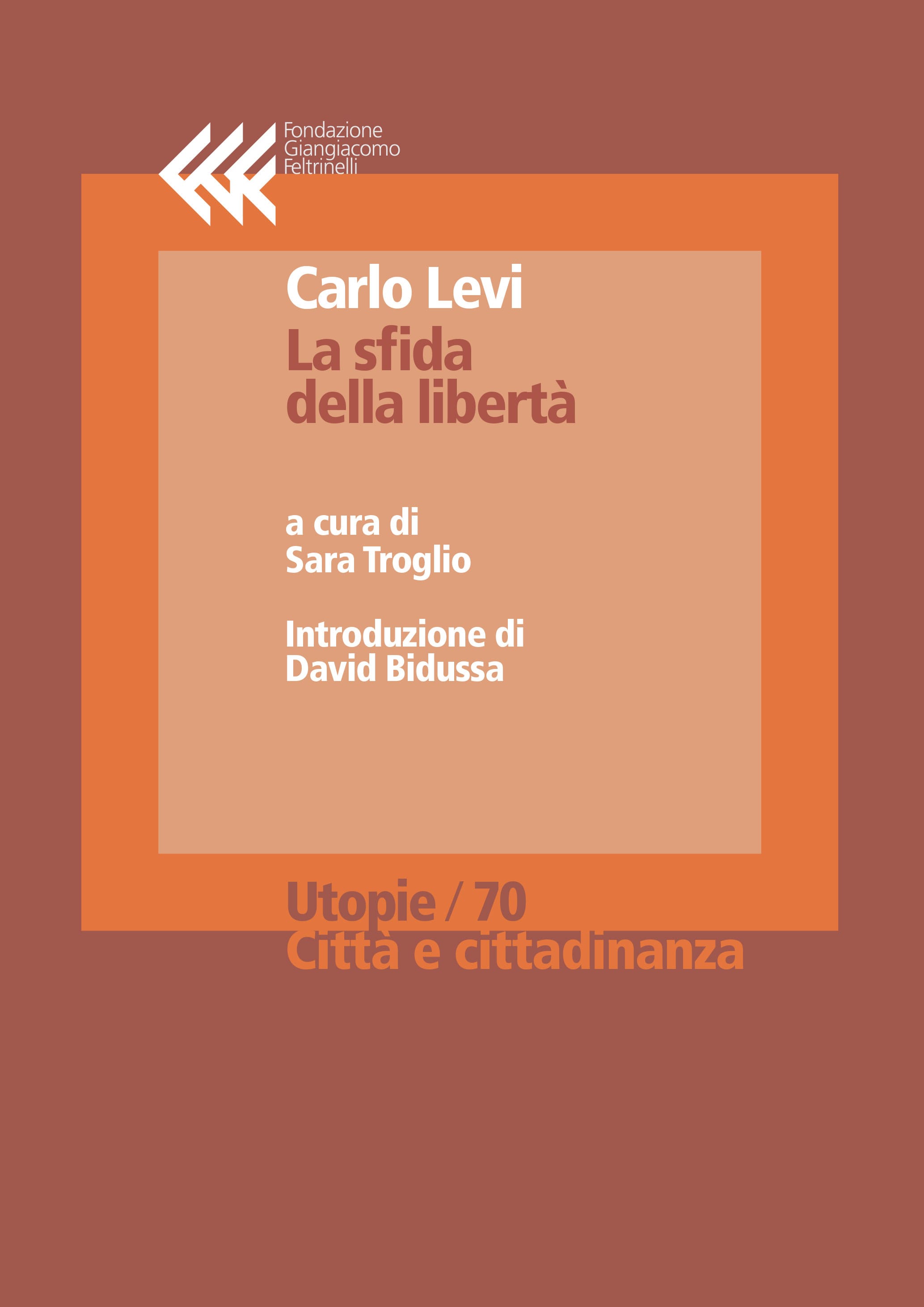Prima settimana di reclusione forzata: 7 giorni, 168 ore, 10.068 minuti, che in valore assoluto sono notevoli, ma in quello relativo alle bolle in cui siamo precipitati diventano impressionanti.
La sospensione ci ha obbligati a ripensare il tempo, il modo in cui lo viviamo e lo riempiamo, a re-imparare la lentezza, la frenata, “l’oro invisibile delle giornate”[1] ma anche la fatica della troppa vicinanza, la noia della stasi imposta e un sentore sottile, mefitico, che si insinua nelle cellule e ci fa temere l’altro, il fuori, il domani.
Mai come adesso, isolati nell’incertezza assoluta, siamo stati vicini al nostro limite, obbligati a considerarlo con sguardo lucido, oggettivo, forte della responsabilità del capire, del non smettere di chiederci come e perché, rispondendo, possibilmente, con atti creativi di rigenerazione.
Mentre scrivo dovrei trovarmi dall’altra parte del mondo, a condurre una ricerca-azione sulla gioventù post-apartheid, sulla sua quotidiana frequentazione dei confini negli spazi dell’abitare, di come si prova a superarli.
R., che non mi ha vista arrivare in aeroporto, mi ha scritto allarmato, confidandomi la sua angoscia per la diffusione del virus in Sud Africa. Stupidamente, gli ho consigliato quanto qualche settimana fa non avrei auspicato a me stessa: “Stay home” e lui ha replicato “You know Joburg’s life, Pao. I need to be out there in town to survive”.
R. ha 35 anni, viene da un distretto rurale dello Zimbabwe e da 15 vive come immigrato irregolare a Johannesburg, arrabattandosi tra lavoretti di vari tipo accomunati unicamente dal muoversi, dall’andare a cercare nuovi potenziali clienti o soci, dal non perdere il contatto con l’esterno. Da oltre metà della sua vita, la sua esistenza dipende dal costante tentativo di uscire dall’isolamento.
Ci penso, dal mio rifugio modesto ma sicuro che guarda a un profilo di mare, che avevo dentro gli occhi anche ieri mentre sentivo P., tra le voci protagoniste di un corto recentemente girato sui ciclo-fattorini a Milano. Lasciato il lavoro di rider, che lo stressava per il ritmo frenetico, e trovato un impiego da operaio più prossimo alla sua precedente professione, P. si è di recente trasferito in una città toscana. Non ha fatto in tempo ad arrivare, che il Decreto #iorestoacasa è diventato attuativo, così lui a casa ci è rimasto davvero, senza lavoro né garanzia di riassunzione alcuna. Ora rimpiange il mestiere di rider, “almeno mi renderei utile a chi non può uscire e ha bisogno di qualcosa”.
Più fortunato è C., anni di assistenza ai nostri anziani fino all’ultimo respiro e ora tuttofare in un hotel stellato. L’albergo non riceve clienti in questi giorni ma i gestori hanno deciso di tenerlo aperto, così C. ogni mattina vi si reca armato di guanti e mascherina, presidia l’edificio deserto, ci mangia e ci dorme.
Mi ha scritto: “Sento che qualcosa va storto. La mia famiglia mi dice sempre ‘ritorna in Sri Lanka’ ma non voglio fuggire dall’Italia. É il Paese che stava cercando di migliorarmi, posso lasciarlo ora che si trova in questa situazione?”.
10.068 minuti, 168 ore, 7 giorni d’”isolamento connesso”, in cui la giostra spenta dell’umore si confronta con lo sconquasso dei riti quotidiani, delle sicurezze date per garantite e sperimentiamo, tutti, la precarietà, quella che una maggioranza di non-visti, lontani e vicini, vive ogni giorno per intere esistenze. C’è voluto un paradosso per farci carico, con la salute, del bene di tutti, per interrogarci sul senso della collettività, per ripensare la parola “noi”.
Saremo capaci, quando finalmente la primavera sarà tornata e noi fuori “a ballare da far luce”[2], di declinarla al futuro?
1 Il riferimento è all’ultima poesia di Mariangela Gualtieri “Nove marzo duemilaventi”;
2 Citazione da un’intervista di Diego Bianchi a Francesco Guccini riportata nel servizio di Propaganda del 13/03/2020, ”Mi prometti che quando finisce tutto andiamo a ballare?”. Qui il trailer.