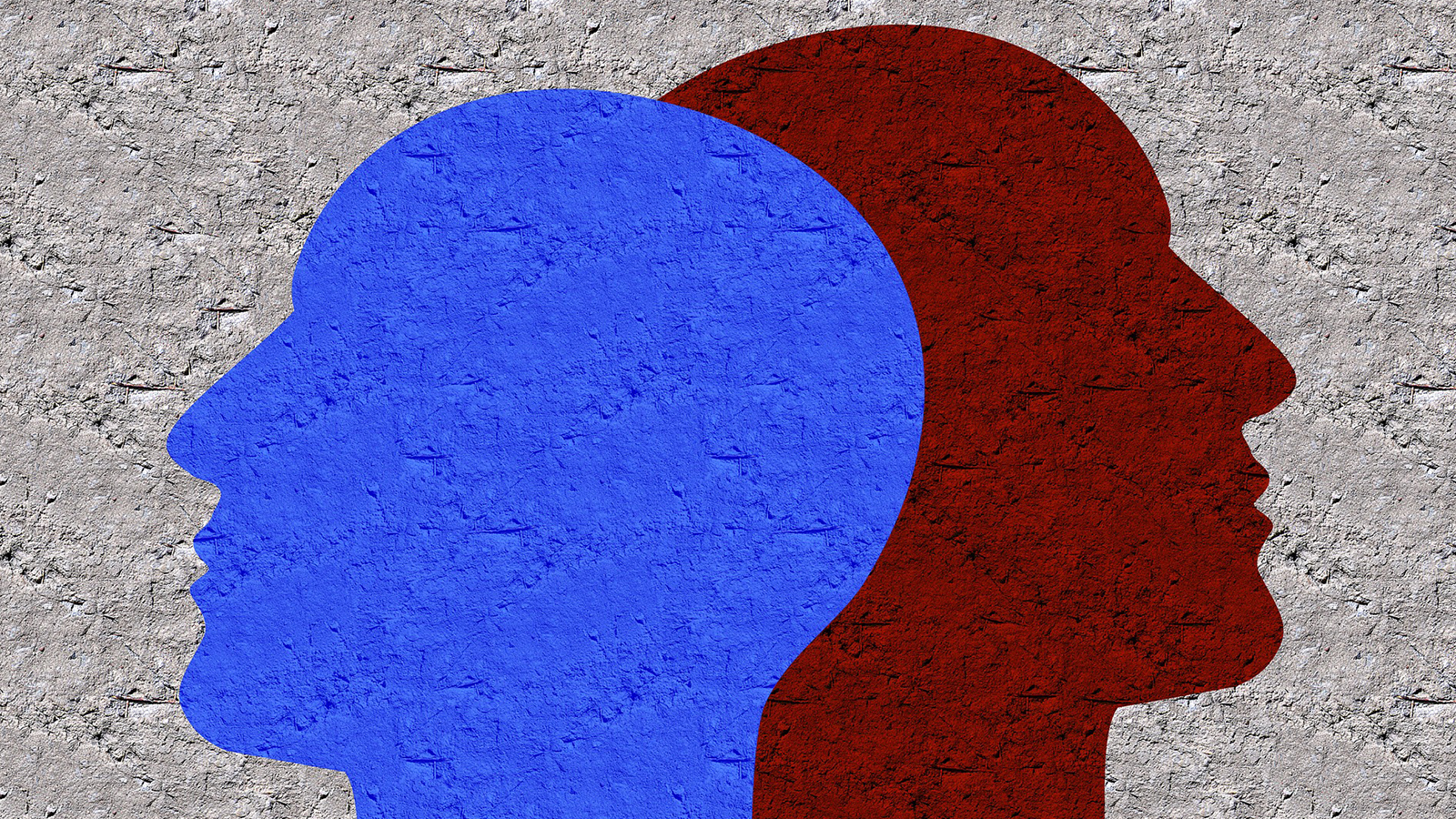Proponiamo qui come un’anticipazione un estratto del saggio di Luca Baldissara “Vice or Virtue. On Social Conflict in the Age of Postdemocracy” che sarà pubblicato nell’Annale Thinking Democracy Now curato da Nadia Urbinati.

Negli ultimi trenta/quarant’anni, il conflitto non è scomparso, ma è sembrato mutare profilo e ruolo. Sino al decennio Settanta, nel conflitto avevano convissuto la dimensione politica e di riconoscimento – con l’obiettivo di ampliare la cittadinanza democratica, estendere i confini dei diritti sociali, partecipare alle scelte di governo – e quella distributiva, dove una più equa distribuzione della ricchezza non solo consentiva migliori condizioni di vita, ma anche di estendere e rafforzare la domanda interna, quindi di consolidare la produzione e lo sviluppo. Dopo di allora, la prima dimensione appare svanire, nel contesto dell’egemonia neoliberista viene a rappresentare un insopportabile costo economico della democrazia[1]; la seconda permane e si trasforma in un contrattualismo che dapprima rafforza l’estendersi del consumo di massa (negli anni Ottanta), poi (nel trentennio successivo, con fasi alterne, sino ad oggi) è progressivamente costretta a spartire risorse sempre più scarse, che contengono il potere d’acquisto, o, meglio, lo garantiscono in modo vieppiù ineguale. Al punto che, nell’odierna società, chi ha di più ha sempre di più, mentre l’esteso ceto medio, base sociale dello sviluppo economico e democratico del secondo dopoguerra, rischia di impoverirsi rapidamente, trovandosi costretto a vestire il gilet jaune, proponendosi come protagonista di un conflitto che non ha per obiettivo l’inclusione, ma la non-esclusione, in cui si scende per strada e si protesta per non scivolare fuori dai confini della società dei consumi[2]. Che sia la fine della modernità, della storia bisecolare (1789-1989) della cittadinanza e della democrazia inclusive? 
I conflitti sociali, si è detto, non sono del tutto scomparsi, anche se indebolita e trasformata in profondità appare la classe di riferimento, la classe operaia (ma solo nell’Europa occidentale, ché ad Est, in Sudafrica, in America latina, in Cina, in India, essa si è irrobustita, alimenta lotte nei luoghi di lavoro, accumula un potenziale di mutamento sociale e politico che nei prossimi anni potrebbe riservarci molte sorprese). Le proteste contro il neoliberismo e la guerra promosse dalla rete del cosiddetto World Social Forum (le principali a Seattle 1999, Davos 2000-2001, Porto Alegre e Genova 2001, Firenze 2002, Atlanta 2007, Detroit 2010) mostrano che si mantiene vivo uno sforzo di rinnovare la prospettiva del conflitto sociale, “di lottare contro la concentrazione della ricchezza, la proliferazione della povertà e delle ineguaglianze e la distruzione della nostra terra”, di opporre “resistenza a un sistema che è fondato sul patriarcato, il razzismo e la violenza, che privilegia gli interessi del capitale sui bisogni e le aspirazioni dei popoli”[3]. La contestazione del neoliberismo si emancipa dai tradizionali soggetti politici della sinistra, che pure continuano a prendervi parte, e tenta di riunire sotto l’eterogeneo ombrello alter-mondialista le critiche all’imperialismo, allo sfruttamento ambientale, al razzismo, agli effetti della globalizzazione finanziaria. Tale contestazione spesso si innesca in reazione a crisi economico-finanziarie (il fallimento della Enron e la crisi finanziaria Argentina, 2001, la crisi dei mutui subprime e la bancarotta della Lehman Brothers Holdings negli Usa, 2007-2008), che conducono alla nascita di movimenti di protesta come Occupy Wall Street (2011), diffusosi anche al di fuori degli Usa. Altre volte è collegata a specifiche questioni economico-sociali che accendono la protesta (l’innalzamento delle tasse universitarie in Gran Bretagna, 2010, le leggi sul lavoro in Italia e Francia, 2014-2017, la privatizzazione della SNCF in Francia, 2018), oppure ad un tentativo di contestare le politiche di austerità nella dimensione europea con uno sciopero generale simultaneo in Europa (novembre 2012). E non mancano neppure le esperienze politiche di nuovi partiti della sinistra sociale (da Podemos in Spagna a Syryza in Grecia), e della notevole mobilitazione a sostegno della candidatura del socialdemocratico Bernie Sanders nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016; oppure di esperienze volte a riscoprire valori ed esperienze storicamente di sinistra, come quella del municipalismo e dell’autonomismo (l’Europa delle città del sindaco di Barcellona Ada Colau).
Ma se questa indiscutibile effervescenza d’un lato indica il persistere della necessità e del rinnovarsi delle forme di opposizione sociale, dunque di conflitto, dall’altro lato si rivela non priva di ambiguità, destinate talora a rafforzarsi in fasi di rapporti di forza sfavorevoli e di sconfitte politiche (si pensi alle torsioni dell’autonomismo catalano, a taluni sviluppi regressivi del movimento no-global, ai tentennamenti populistici dei partiti della nuova sinistra sociale). In effetti, la visione conflittuale della democrazia si scontra oggi con diversi problemi, almeno tre dei quali varrà la pena di evidenziare. Il primo riguarda lo spazio della protesta: il neoliberismo ha imposto come terreno d’azione l’ambito transnazionale (si pensi al peso ed al ruolo mondiale della finanza) ed ha depotenziato progressivamente i centri del potere nazionale (lo stato-nazione otto-novecentesco), spazio nel quale il movimento operaio – i sindacati, i partiti politici, le rappresentanze parlamentari – si era legittimato come protagonista dei conflitti per l’estensione della cittadinanza. Il tentativo neoliberista di abbattere le barriere spaziali ha corrisposto al disegno di indebolire qualsivoglia forma di limitazione del potere e di controllo dei processi di accumulazione. Il moltiplicarsi delle lotte sociali nei luoghi determinati della produzione e del consumo (ieri gli stati, oggi le città, ad esempio) per raggiungere specifici obiettivi non è attualmente in grado di intaccare l’egemonia nello spazio (il mercato mondiale, le reti di circolazione del capitale finanziario). In fondo, potremmo sostenere che la risposta alla crisi degli anni Settanta è stata la deterritorializzazione della produzione poiché il movimento dei lavoratori, riuscendo a controllare una rete di luoghi, stava intaccando lo spazio del potere e degli interessi del blocco storico dominante. Quest’ultimo ha quindi prodotto nuovo spazio (il globale) al fine di non solo di mantenere il proprio potere, ma anche di svincolare il profitto dalle politiche redistributive degli stati e di elaborare un’ideologia capace di egemonia culturale (fondata sulla libertà di circolazione di capitali, merci, lavoratori; sulla globalizzazione del modello di consumo; sulla tendenziale omogeneizzazione dei luoghi e degli stili di vita). Non potrà dunque esservi un nuovo conflitto inclusivo e di riconoscimento senza ingaggiare una battaglia per il controllo dello spazio.
In secondo luogo, gli odierni movimenti sono diversamente connotati sul piano sociale rispetto a quelli che avevano individuato la classe lavoratrice come protagonista, sono orfani di un attore politico interprete delle istanze di rappresentanza e riconoscimento, nonché guida del mutamento sociale. La solidarietà di classe è stata infatti la grande risorsa identitaria della politica nella modernità europea. Ma l’eclissi del fordismo e la precarizzazione del lavoro sembrano aver reso la struttura sociale talmente complessa da rinunciare a definirla, prima ancora che a governarla e mutarla, figuriamoci a rappresentarla politicamente. Il logoramento della rappresentazione di classe della società da una parte ha condotto a mettere in discussione il lavoro come fondamento dell’identità e dell’emancipazione sociale, dall’altra ha favorito il successo dell’individualismo, o forse è meglio dire del primato degli individui riuniti nel grande e indistinto bacino del ceto medio. Che è stato vezzeggiato e corteggiato a cavallo tra XX e XXI secolo, descritto come oppresso dallo Stato e dalla fiscalità, indefesso lavoratore e strenuo difensore della libertà d’impresa e del diritto di proprietà. Tranne che oggi è il ceto medio ad apparire come la vittima predestinata della globalizzazione, dunque disposto a scendere in strada, protestare e lottare come mai ha osato. Ed ecco che si alza la voce di chi si propone di proteggerlo con un sovranismo che riprende e rielabora l’altra grande risorsa identitaria della politica europea, il nazionalismo (contro l’Europa dei tecnocrati, contro l’immigrazione, contro i paesi produttori a basso costo come la Cina). Non potrà dunque esservi un conflitto intorno al diritto di cittadinanza ed ai diritti sociali senza rimettere al centro la questione del lavoro, senza un’adeguata analisi della struttura e articolazione in gruppi sociali, senza una ricomposizione sociale del soggetto politico del mutamento.
Infine, in relazione a quanto appena osservato, va notato che nei movimenti sociali odierni le forme dell’azione e le parole d’ordine sono spesso politicamente confuse, accostano ambiguamente elementi della tradizione politico-culturale sia della sinistra che della destra. Non è in realtà una novità assoluta, alle origini del fascismo – senza per ciò dire che viviamo un’analoga fase storica – questo fenomeno si è già osservato. L’eclettismo della politica è spesso l’espressione del disordine teorico ed analitico in momenti di profonda e intensa trasformazione, di cui si stenta a comprendere il senso di marcia. Ciò significa che è legittimo supporre che una scrematura progressiva delle rappresentazioni politiche si farà strada col procedere del mutamento sociale. Ma significa anche che senza l’elaborazione di una teoria critica adeguata all’attuale conformazione sociale difficilmente si potrà realizzare un nuovo conflitto politico e sociale teso al rafforzamento della democrazia.
[1] S. Brittan, The Economic Consequences of Democracy, Temple Smith, London 1977.
[2] Che la finanziarizzazione dell’economia fosse destinata a gravare pesantemente sui ceti medi, «poiché solo un piccolo gruppo scelto di ciascuna popolazione nazionale può ripartirsi i profitti della borsa e dell’intermediazione finanziaria», era quanto osservava, in riferimento agli Usa, K. Phillips, Boiling Point. Republicans, Democrats and the Decline of Middle-class Prosperity, Random House, New York 1993, p. 197.
[3] Manifesto del Social Forum Mondiale approvato a Porto Alegre, 2002.