Mauro Calamandrei, Nixon non dormire, “L’Espresso”, 26 ottobre 1969, per la rassegna Dal no alla guerra in Vietnam al no alla guerra contro i Curdi: sul ruolo delle dimostrazioni popolari e sulle debolezze delle istituzioni
Nell’ufficio di George Gallup a Princeton c’è un grande grafico con una scritta: “Ritenete che sia stato un errore inviare truppe statunitensi nel Vietnam?”. Una linea tratteggiata indica i no, una continua i sì; infine una terza linea composta di punti registra che nell’agosto 1965 i sì erano appena il 24 per cento, e i no il 62 per cento. Ma da allora la linea tratteggiata dei no è scesa, quella continua dei sì è salita finché nell’ultimo sondaggio coloro che consideravano l’intervento americano erano il 58 per cento. Se calcoliamo che un altro 10 per cento è costituito da incerti, quelli che condividono l’opinione di Nixon (“Il Vietnam è l’ora più luminosa dell’America”) sono soltanto il 32 per cento. Se il presidente nei mesi scorsi avesse studiato più attentamente il grafico, non avrebbe coltivato l’illusione che il “moratorium”, la “pausa” della settimana scorsa sarebbe una ragazzata senza importanza e non sarebbe rimasto tanto sorpreso dal numero e dalle dimostrazioni delle dimostrazioni.
Per la verità il “moratorium” ha superato anche le previsioni degli ideatori e degli organizzatori. Perfino un teorico delle “iniziative dal basso” come Dick Goodwin non si aspettava che tanti bancari ed agenti di borsa fossero disposti a sospendere il lavoro, a indossare fasce nere al braccio e alternarsi a leggere i nomi dei 40mila americani morti nel Vietnam. E neppure Sam Brown, il giovane stratega della “crociata dei bambini” di Eugene McCarthy e di questo “moratorium”, aveva sperato che il 15 ottobre ci sarebbero state le prime dimostrazioni per la pace in centri notoriamente conservatori come Duluth, nel Minnesota o che in un paesotto rurale come Beauclaire nel Wisconsin più di 500 persone avrebbero marciato nel cuore della notte sotto una pioggia invernale con in testa il figlio del segretario alla Difesa Laird.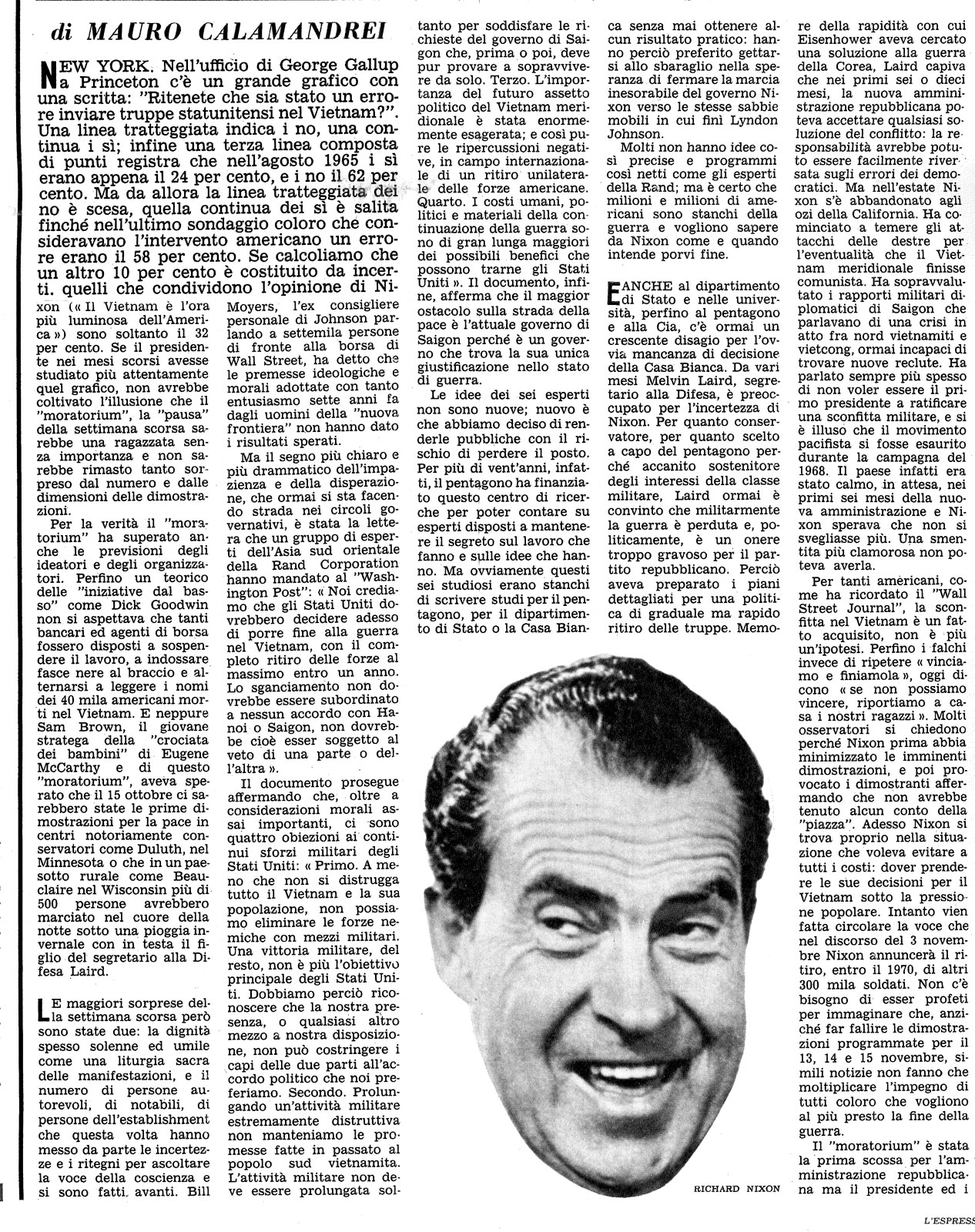
Le maggiori sorprese della settimana scorsa però sono state due: la dignità spesso solenne ed umile come una liturgia sacra delle manifestazioni, e il numero di persone autorevoli, di notabili, di persone dell’establishment che questa volta hanno messo da parte tutte le incertezze e i ritegni per ascoltare la voce della coscienza e si sono fatti avanti. Bill Moyers, l’ex consigliere personale di Johnson a settemila persone di fronte alla Borsa di Wall Street, ha detto che le premesse ideologiche e morali adottate con tanto entusiasmo sette anni fa dagli uomini della “nuova frontiera” non hanno dato risultati sperati.
Ma il segno più chiaro e più drammatico dell’impazienza e della disperazione, che ormai si sta facendo strada nei circoli governativi, è stata la lettera che un gruppo di esperti dell’Asia sud orientale della Rand Corporation hanno mandato al “Washington Post”: “Noi crediamo che gli Stati Uniti dovrebbero decidere adesso di porre fine alla guerra in Vietnam, con il completo ritiro delle forze al massimo entro un anno. Lo sganciamento non dovrebbe essere subordinato a nessun accordo con Hanoi o Saigon, non dovrebbe cioè esser soggetto al veto di una parte o dell’altra”.
Il documento prosegue affermando che, oltre a considerazioni morali assai importanti, ci sono quattro obiezioni ai continui sforzi militari degli Stati Uniti: “Primo. A meno che non si distrugga tutto il Vietnam e la sua popolazione, non possiamo eliminare le forze nemiche con mezzi militari. Una vittoria militare, del resto, non è più l’obiettivo principale degli Stati Uniti. Dobbiamo perciò riconoscere che la nostra presenza, o qualsiasi altro mezzo a nostra disposizione, non può costringere i capi delle due parti all’accordo politico che preferiamo. Secondo. Prolungando un’attività militare estremamente distruttiva non manteniamo le promesse fatte in passato al popolo sudvietnamita. L’attività militare non deve essere prolungata soltanto per soddisfare le richieste del governo di Saigon che, prima o poi, deve pur provare a vivere da solo. Terzo. L’importanza del futuro assetto politico del Vietnam meridionale è stata enormemente esagerata; e così pure le ripercussioni negative, in campo internazionale di un ritiro unilaterale delle forze americane. Quarto. I costi umani, politici e materiali della continuazione della guerra sono di gran lunga maggiori dei possibili benefici che possono trarne gli Stati Uniti”. Il documento, infine, afferma che il maggior ostacolo sulla strada della pace è l’attuale governo di Saigon perché è un governo che trova la sua unica giustificazione nello stato di guerra.
Le idee dei sei esperti non sono nuove; nuovo è che abbiamo deciso di renderle pubbliche con il rischio di perdere il posto. Per più di vent’anni, infatti, il pentagono ha finanziato questo centro di ricerca per poter contare su esperti disposti a mantenere il segreto sul lavoro che fanno e sulle idee che hanno. Ma ovviamente questi sei studiosi erano stanchi di scrivere studi per il pentagono, per il dipartimento di Stato o la Casa Bianca senza mai ottenere alcun risultato pratico: hanno perciò gettarsi allo sbaraglio nella speranza di fermare la marcia inesorabile del governo Nixon verso le stesse sabbie mobili in cui finì Lyndon Johnson.
Molti non hanno idee così precise e programmi così netti come gli esperti della Rand; ma è certo che milioni e milioni di americani sono stanchi della guerra e vogliono sapere da Nixon come e quando intende porvi fine.
E anche al dipartimento di Stato e nelle università, perfino al pentagono e alla Cia, c’è ormai un crescente disagio per l’ovvia mancanza di decisione alla Casa Bianca. Da vari mesi Melvin Laird, segretario alla Difesa, è preoccupato per l’incertezza di Nixon. Per quanto conservatore, per quanto scelto a capo del pentagono perché accanito sostenitore degli interessi della classe militare, Laird ormai è convinto che militarmente la guerra è perduta e, politicamente, è un onere troppo gravoso per il partito repubblicano. Perciò aveva preparato i piani dettagliati per una politica di graduale ma rapido ritiro delle truppe. Memore della rapidità con cui Eisenhower aveva cercato una soluzione alla guerra di Corea, Laird capiva che nei primi sei o dieci mesi, la nuova amministrazione repubblicana poteva accettare qualsiasi soluzione del conflitto: la responsabilità avrebbe potuto essere facilmente riversata sugli errori dei democratici. Ma nell’estate Nixon s’è abbandonato agli ozi della California. Ha cominciato a temere gli attacchi delle destre per l’eventualità che il Vietnam meridionale finisse comunista. Ha sopravvalutato i rapporti militari diplomatici di Saigon che parlavano di una crisi in atto fra nordvietnamiti e vietcong, ormai incapaci di trovare nuove reclute. Ha parlato sempre più spesso di non voler essere il primo presidente a ratificare una sconfitta militare, e si è illuso che il movimento pacifista si fosse esaurito durante la campagna del 1968. Il Paese infatti era stato calmo, in attesa, nei primi sei mesi della nuova amministrazione e Nixon sperava che non si svegliasse più. Una smentita più clamorosa non poteva averla.
Per tanti americani, come ha ricordato il “Wall Street Journal”, la sconfitta nel Vietnam è un fatto acquisito, non è più un’ipotesi. Perfino i falchi invece di ripetere “vinciamo e finiamola”, oggi dicono “se non possiamo vincere, riportiamo a casa i nostri ragazzi”. Molti osservatori si chiedono perché Nixon prima abbia minimizzato le imminenti dimostrazioni, e poi provocato i dimostranti affermando che non avrebbe tenuto alcun conto della “piazza”. Adesso Nixon si trova proprio nella situazione che voleva evitare a tutti i costi: dover prendere le sue decisioni per il Vietnam sotto la pressione popolare. Intanto vien fatta circolare la voce che nel discorso del 3 novembre Nixon annuncerà il ritiro, entro il 1970, di altri 300mila soldati. Non c’è bisogno di esser profeti per immaginare che, anziché far fallire le dimostrazioni programmate per il 13, 14 e 15 novembre, simili notizie non fanno che moltiplicare l’impegno di coloro che vogliono al più presto la fine della guerra.
Il “moratorium” è stata la prima scossa per l’amministrazione repubblicana ma il presidente ed i suoi consiglieri si comportano ancora come se l’America di oggi fosse come quella degli anni Cinquanta. Essi temono ancora le reazioni di destra, concepibili solo in epoca maccartista, e tentano perfino di resuscitare lo spauracchio del comunismo. Il 14 ottobre Nixon fece dire al vicepresidente Spiro Agnew che i dimostranti dovevano rifiutare pubblicamente il messaggio di solidarietà del primo ministro nordvietnamita Pham Van Dong, altrimenti sarebbero diventati strumenti del comunismo. Sembra che il governo non riesca a capire che durante gli anni Sessanta l’elettorato è profondamente cambiato, la società americana ha acquistato una fisionomia che rende inutili le tecniche politiche di quindici o vent’anni fa.
L’attorney general John Mitchell, il vicepresidente Agnew e gli altri esponenti della destra possono piangere quanto vogliono sulla mancanza di patriottismo delle nuove generazioni e rimpiangere i bei tempi quando il dipartimento della giustizia preparava le liste nere. Ma il clima politico americano ormai è cambiato profondamente. Il processo contro i leader delle dimostrazioni alla convention democratica non ha diminuito la passione polemica dei giovani che vogliono dare un volto diverso alla loro America.
Questa è un’epoca in cui alla Casa Bianca sarebbe indispensabile un presidente vigoroso, un attivista. Governare con un Congresso controllato dal partito d’opposizione non è mai facile; ma Harry Truman dimostrò che un presidente non ha paura di farsi nemici, può mantenere il controllo della vita politica tenendo stretti legami con l’opinione pubblica. La crescente impazienza dell’elettorato nei confronti di Nixon deriva dalla sensazione che non solo egli non ha un programma per chiudere la guerra nel Vietnam, ma non fa nulla neanche negli altri settori della vita pubblica. “Chi ha paura del fuoco, non entri in cucina”, diceva Truman quando era presidente. “È una massima che Richard Nixon dovrebbe far scrivere sulle pareti del suo studio”, ha detto un senatore democratico.









