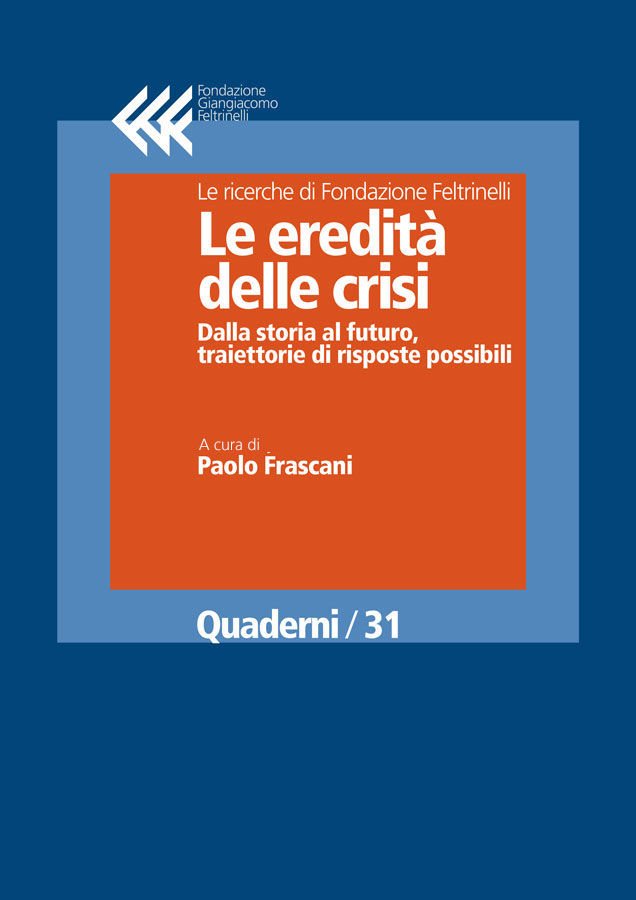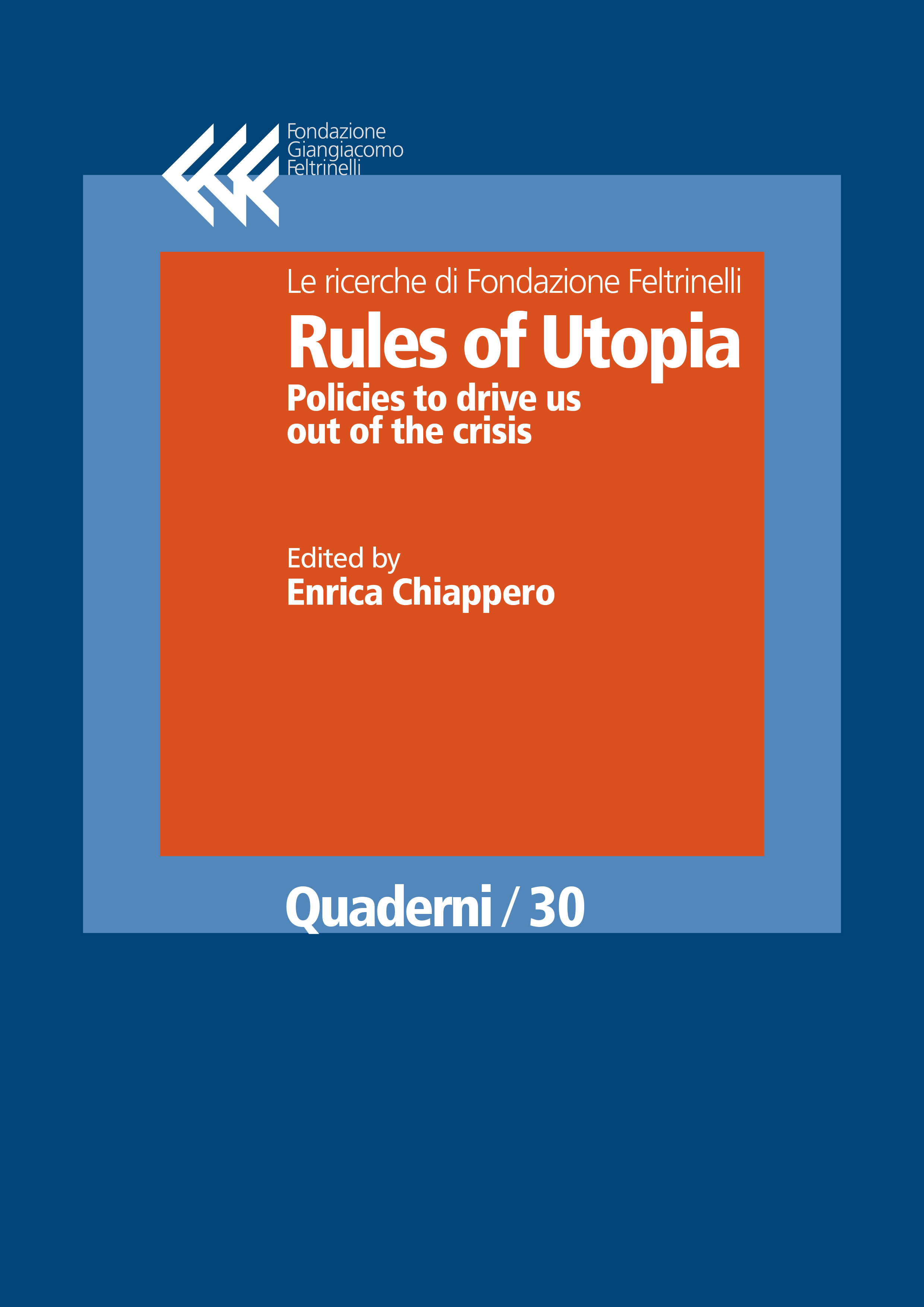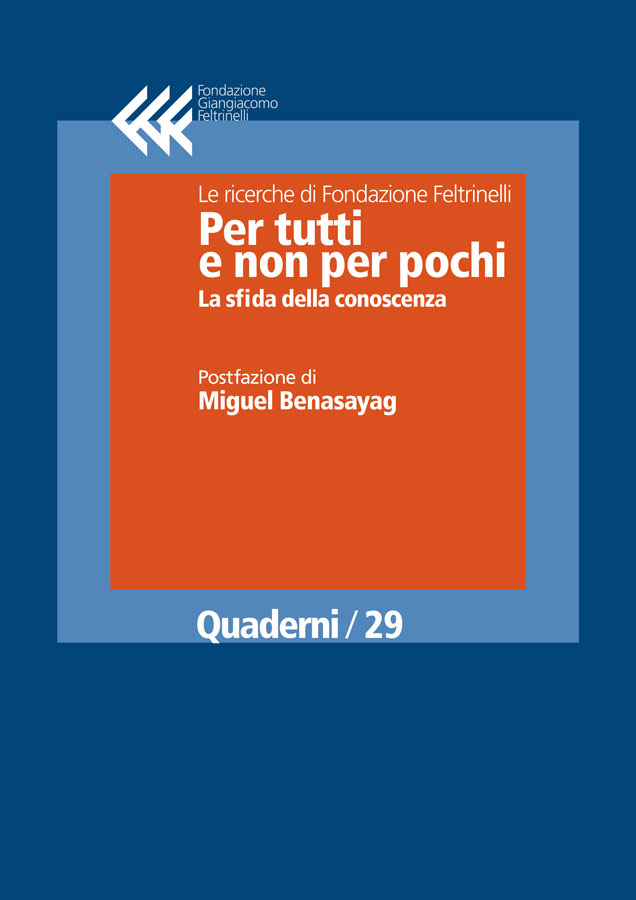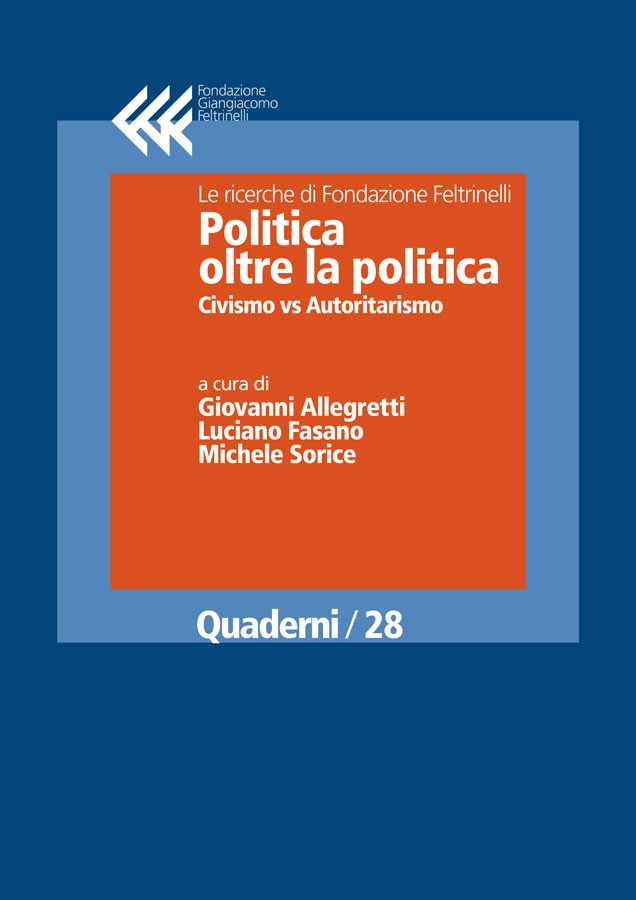Pubblichiamo qui un estratto del saggio di Roberta Garruccio pubblicato nel volume Le eredità delle crisi a cura di Paolo Frascani ed edito da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli), disponibile su tutti gli store online 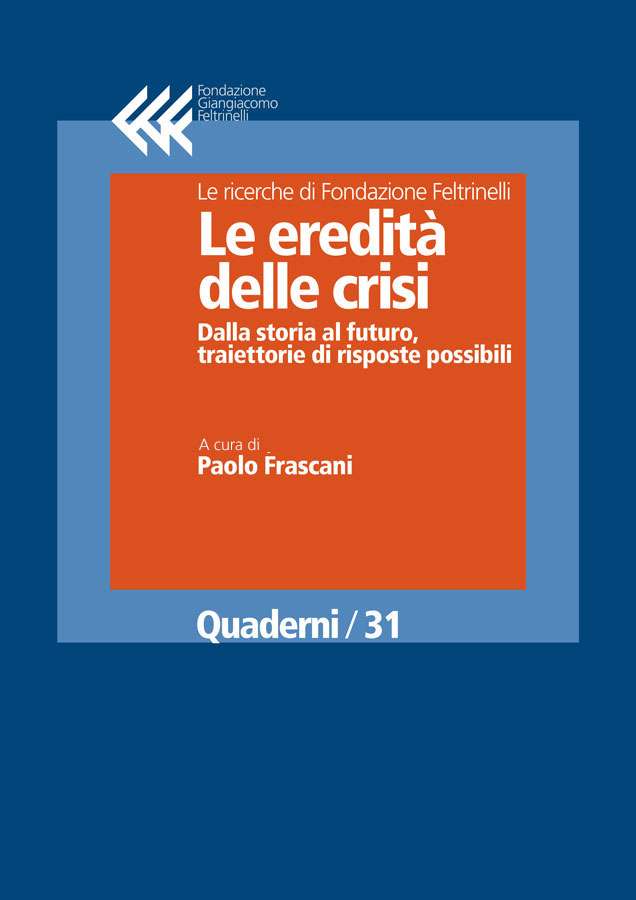
La deindustrializzazione ci interessa perché si presenta non come una fluttuazione ciclica, ma come una discontinuità strutturale che sta seduta su una intera cascata di processi e transizioni economici, tecnologici, geostrategici, politici e culturali rispetto ai quali le società dei paesi sviluppati non hanno ancora trovato un punto di appiglio e di equilibrio.
La deindustrializzazione ci interessa perché i rischi distributivi e di dumping sociale (ossia l’impatto pesantissimo in termini di distribuzione del reddito tra paesi e dentro i paesi) generati congiuntamente dalle tecnologie itc, dai grandi accordi multilaterali e dalle unioni monetarie a partire dagli anni ’90 sono stati sottovalutati a lungo, eppure è da subito che hanno iniziato a presentare il conto. La deindustrializzazione implica infatti meccanismi di generazione e distribuzione del reddito che sono nuovi e quindi forme di disuguaglianza inedite: nell’Unione Europea, la componente intra-nazionale della disuguaglianza misurata in termini reali è in aumento sin dal 2003, e nel 2015 è arrivata a pesare il doppio di quella internazionale.[1] Questa “divergenza locale” è insomma la tendenza macroeconomica speculare alla “convergenza globale”.
La deindustrializzazione ci interessa perché il suo impatto non si limita a presentarsi come de-manufacturing, ma si sostanzia in un nuovo e generalizzato senso di vulnerabilità e incertezza sociale che pesa anche più della disuguaglianza. Essa comporta un mutamento molto ampio nell’ambito delle relazioni di lavoro, con la caduta della partecipazione sindacale e più in generale con difficoltà crescenti di contrattazione sotto la minaccia della delocalizzazione, e con una polarizzazione della qualità del lavoro e dei redditi da lavoro: «una voragine nuova tra […] impieghi stabili, ben remunerati e gratificanti e […] lavori non qualificati, incerti, malpagati e frustranti»,[2] in cui sono due i fattori che giocano: il livello di istruzione e le competenze effettive della forza lavoro (poiché richiedono livelli di istruzione alti, le nuove tecnologie sono particolarmente divisive dentro il tessuto sociale) e il grado di istituzionalizzazione del nuovo mercato dei servizi.
Proprio in contrasto con il fatto che per tutto il ‘900 è stato il settore industriale a rappresentare l’epicentro della legislazione protettiva del lavoro, ciò che si osserva in molti paesi europei è la sua profonda ridefinizione giuridica e di nozione condivisa. Tanto il sistema della protezione sociale quanto la regolazione del mercato del lavoro affondano le loro origini in quel ciclo del capitalismo che sui due lati dell’Atlantico ha concorso allo sviluppo dell’industria, all’emergere della questione operaia, alle conquiste delle classi lavoratrici in termini di diritti. Dopo gli anni ’90, quei sistemi regolativi sono stati oggetto di una decisa torsione, con riforme che il mondo dell’impresa interpretava come chiave della competitività e il sindacato subiva come definitiva rottura del compromesso sociale di epoca fordista e senza esser più in grado di contrastarne la dinamica globale.
Nei paesi più ricchi, la deindustrializzazione si è associata più in generale all’aumento dello spettro di fattori di vulnerabilità sociale, spettro nel quale rientrano anche le toxic legacies di molti luoghi ex-industriali e in cui confluiscono standard di vita declinanti per le classi medie, una quota rilevante della disoccupazione operaia, della nuova occupazione discontinua e precaria nei servizi, lo stesso fenomeno dei “poveri che lavorano”, stili di vita autodistruttivi.
Negli Stati Uniti in particolare, questa vulnerabilità sociale ha fatto registrare un aumento significativo della mortalità e della morbilità dei maschi bianchi con basso titolo di studio: si tratta di un fenomeno che viene ora studiato a fondo perché è la prima volta da un secolo che la mortalità nella fascia di età 25-65 anni ha ripreso a crescere.[3] Al centro dell’attenzione sono le cosiddette deaths of despair: l’impennata dei tassi di suicidio e dei decessi legati all’abuso di alcol e droghe (legati a stati mentali che spingono a comportamenti autodistruttivi) è diventato drammaticamente vistosa proprio dove l’economic distress legato alle trasformazioni strutturali si è più manifestato: i grandi centri urbani più colpiti dal ritiro dell’industria, come Chicago, Baltimora, Detroit, con una sovra-rappresentazione nei middle class suburbs, o regioni come il Midwest, il New England, la regione degli Appalachi. Niente di nuovo nella diffusione di eroina e cocaina e in generale delle sostanze illegali derivate dall’oppio, ma a partire dagli anni ’90 la novità è invece rappresentata dalla crescita nei consumi degli oppioidi sintetici sotto forma di farmaci da prescrizione.[4] Si tratta di analgesici, sedativi, antidepressivi che hanno generato dipendenze, misuso prolungato fuori da ogni indicazione medica, che in vent’anni hanno lasciato una scia di morti per overdose maggiore per numero delle morti registrate tra i soldati americani nella seconda guerra mondiale, in quella di Corea e in quella del Vietnam sommate insieme. È una connessione lassa quella individuata tra l’impatto della deindustrializzazione su alcune specifiche aree degli Usa, le death of despair, la crisi degli oppioidi, ma è una connessione che sta calamitando crescente attenzione: molti progressisti la leggono come causalmente legata al crescere della disuguaglianza;[5] altri più cautamente vi vedono giocare tendenze sociali più complesse (e tra queste il collasso della classe operaia bianca americana, il declino del tasso di occupazione e quindi le patologie che accompagnano questo declino); altri ancora si sono applicati a cercare correlazioni tra le mappe delle death of despair contea per contea e i pattern di voto per Donald Trump durante la campagna per le presidenziali 2016. [6]
Lo slittamento tettonico delle trasformazioni economiche che la rivoluzione digitale e la svolta liberista ha trascinato con sé non ha avuto impatto solo sulla sicurezza del posto di lavoro, ma ha prodotto nel tempo una stagnazione salariale che perdura da almeno due decenni, una netta contrazione della partecipazione maschile al mercato del lavoro (il che a sua volta impatta sulle relazioni tra i generi, sul tasso dei divorzi, su quello della violenza domestica), un generale processo di disembeddedness – vecchia categoria polanyana – che ha aumentato l’isolamento sociale, liquefatto molte comunità locali e ha ridotto il loro controllo sulle policy che le riguardano.
La deindustrializzazione ci interessa perché siamo nel lungo domani della crisi finanziaria del 2007-2008. La cosiddetta Grande Recessione ha esacerbato le tensioni che la globalizzazione andava scaricando sui principi di sovranità nazionale e di democrazia rappresentativa già dal decennio precedente. E in quello successivo ha intensificato la scossa sui processi di “recessione democratica” o di “deconsolidamento della democrazia rappresentativa”.[7] Questi si sono manifestati più vistosamente quando, nel nostro continente, agli effetti della crisi che ha lasciato un tasso mediano di disoccupazione tra le regioni europee di almeno due punti percentuali più alto rispetto a prima del 2007 (e con ampia varianza tra paesi), si sono aggiunti quelli della crisi dei debiti sovrani (2011-2012) con le tensioni che questa accollava ai sistemi di welfare europei e proprio nel momento in cui scoppiava anche la crisi dei migranti (2015). Deflazione, disoccupazione o precarizzazione del lavoro, rallentamento economico, malessere sociale ed economico degli elettori, polarizzazione dello scontro politico, ascesa di movimenti politici estremisti, affermazione delle destre radicali e in generale una perdita di consenso dei partiti tradizionali che sembra correlata più alle variazioni nella disoccupazione che ai suoi livelli assoluti.[8] È questo il contesto largo in cui un’analisi empirica della deindustrializzazione europea va inserita.
[1] G. Ottaviano, Geografia economica dell’Europa sovranista, Laterza, Bari, 2019, pp. 77-85.
[2] D. Rodrick, Dirla tutta sul mercato globale, cit., p. 85.
[3] A. Case, A. Deaton, Mortality and Morbidity in the 21st Century, “Brookings Papers”, March 17, 2017.
[4] Il fenomeno è drammatico negli USA, anche per le peculiarità del suo sistema di assicurazione sanitaria, ma non è limitato agli USA: ricerche recenti documentano il quasi raddoppio nell’uso degli anti-depressivi tra 1990 e 2000 in Europa e una continua tendenza alla crescita in tutti i paesi ocse anche per i due decenni successivi, cfr. D.G. Blanchflower, Not Working, cit., pp. 212 ss.
[5] J. Stieglitz, When Inequality Kills, “Project Syndicate”, December 7, 2015.
[6] S. Monnat, Deaths of Despair and Support for Trump in the 2016 Presidential Election, Pennsylvanya State University, Department of Economics, Sociology and Education, “Research Brief”, April 12, 2016.
[7] M. Giugni, M. Grasso, Citizens and the Crisis: Experiences, Perceptions and Responses to the Great Recession in Europe, Palgrave-McMillan, London, 2017; L. Morlino, F. Raniolo, The Impact of the Economic Crisis on South European Democracies, Palgrave-McMillan, London, 2017.
[8] Y. Algan et al., The European Trust Crisis and the Rise of Populism, “Bookings Papers”, Settembre 2017.