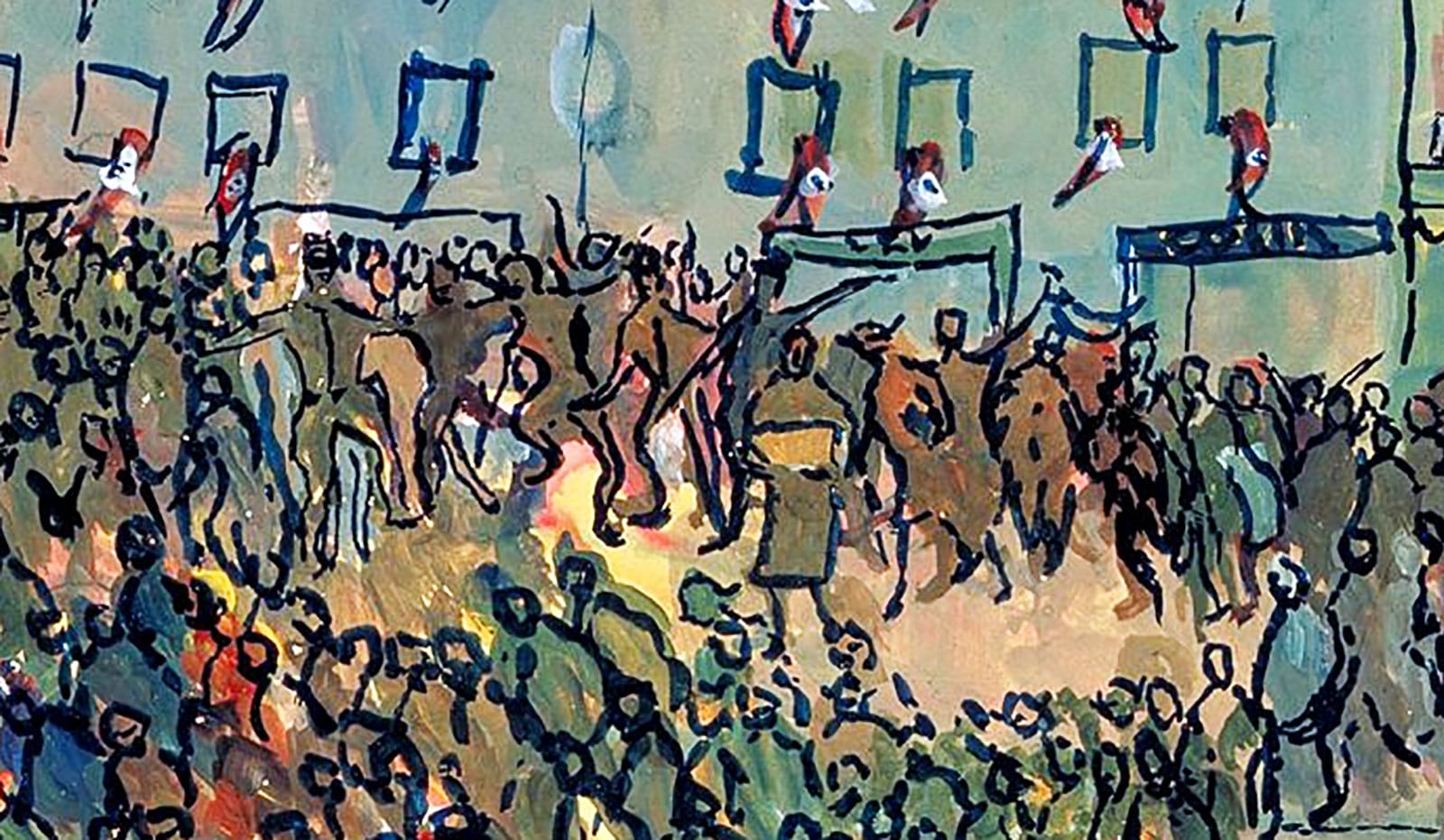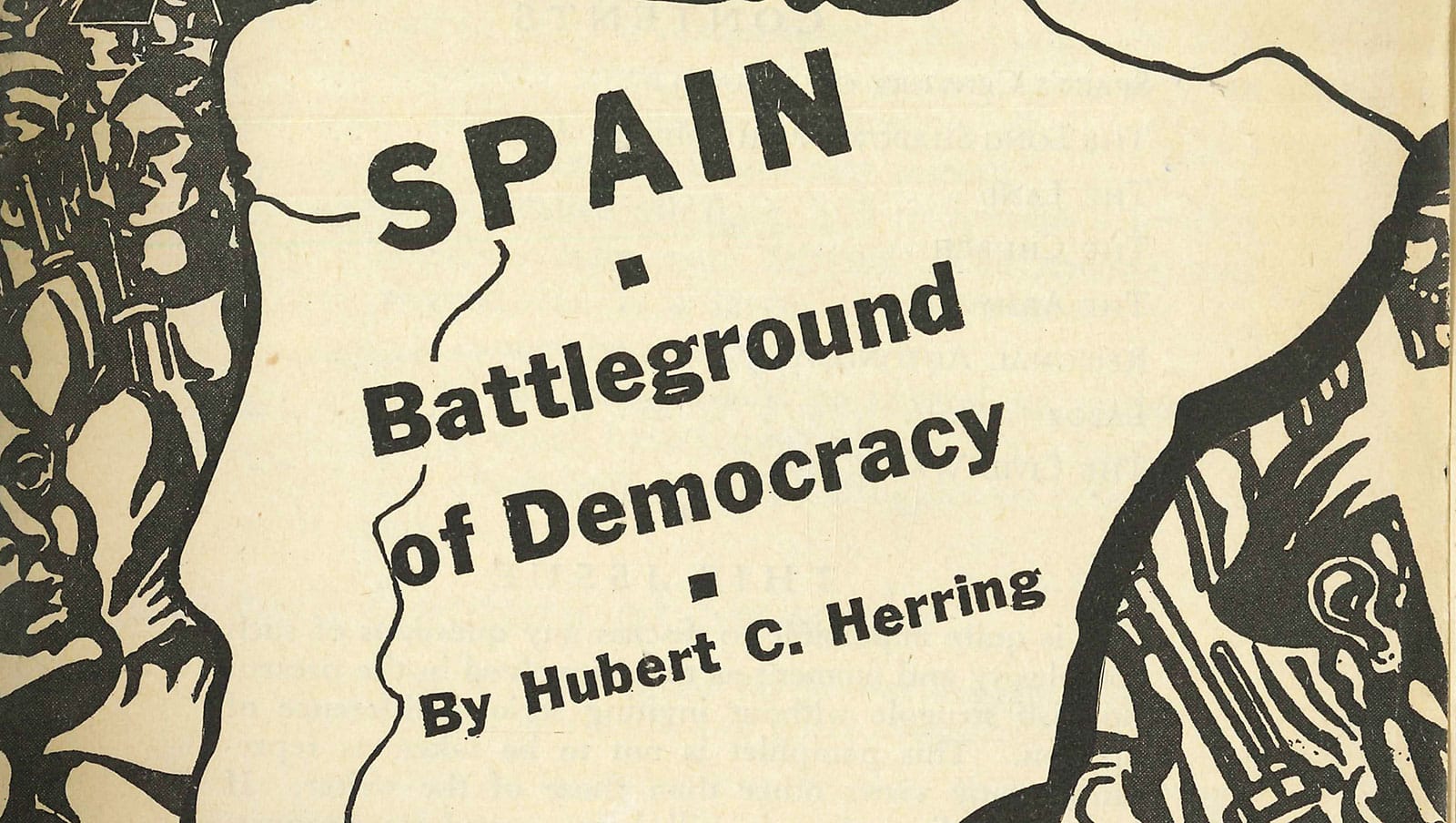Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, uscirà nelle sale cinematografiche italiane il primo documentario, diretto dalla regista Roberta Grossman, che tratta della vicenda di “Oyneg Shabes” (“La gioia del Sabato”, in yiddish). Il film, intitolato “Who will write our History?”, descrive la storia di un gruppo di ebrei, composto da giornalisti, intellettuali, capi della comunità e guidato dallo storico Emanuel Ringelblum, che, prima di essere deportati dal ghetto di Varsavia nel quale erano stati reclusi, riuscirono a seppellire un importante archivio dalla non indifferente mole: sessantamila pagine di testimonianze e annotazioni che documentano gli eventi in corso. Utilizzando documenti di archivi fotografici e video, testimonianze e scene ricostruite, il documentario è funzionale sia a ricreare la vicenda, sia a ricercare il senso dell’operazione compiuta dal gruppo.
Il punto focale della discussione sul documentario non può che vertere sui vinti e sulle scelte che hanno compiuto, in un contesto drammatico come quello del ghetto di Varsavia, rispetto a che cosa avesse dignità di essere ricordato e cosa fosse possibile anche tralasciare. Le sessantamila pagine di testimonianze ed annotazioni assumono un’importanza non eludibile nel momento in cui ne viene fatta risaltare la multivocalità: la scrittura della Storia non può prescindere dalla disamina delle testimonianze tramandate dal passato. La vicenda degli “Oyneg Shabes” tuttavia ci porta ad allargare la riflessione anche a quelle tracce del passato che sono state consapevolmente e volontariamente conservate e consegnate non già al presente – drammatico e oscuro – ma ad un futuro non conosciuto, con la speranza che sapesse ascoltarle.
In questo caso specifico, della mole documentaria relativa alla vicenda di “Oyneg Shabes” è opportuno far risaltare la molteplicità di indirizzi: soltanto in questo modo è possibile raccontare quella storia specifica senza assegnarle un indirizzo univoco ma conferendo valore a tutti i tasselli che ne compongono il racconto.
In questo film, Grossmann porta alla luce un racconto, un “pezzo di storia” ancora poco noto, che si aggiunge al mosaico di piani che compongono l’evento denominabile “universo concentrazionario nazifascista”.
L’atto al centro del racconto di Grossman ha per focus però la scrittura stessa della storia, in un rimando di specchi in cui scrivere di Storia diviene esso stesso Storia.
Questa ripetizione del termine “storia” nella doppia accezione che la lingua italiana dà al termine, “grande” e “piccola”, “personale” e “collettiva”, identifica già da sé come la creazione del racconto del passato sia un processo mai concluso in cui intervengono molteplicità di piani e agenti. Lungi dalla visione che vuole il racconto storico come una codificazione fissa ed immutabile, simile ad una somma di eventi, questa visione ci porta a riflettere sull’incredibile vitalità con cui il discorso storico muta, dialogando sempre – anche nei momenti di silenzio – con il presente. E proprio in contestazione alla volontà di silenzio delle voci della comunità ebraica da parte del Reich che la vicenda di “Oyneg Shabes” prende avvio.
La memoria storica è il risultato di una decisione intellettuale attiva, sempre rinegoziabile, di confronto su cosa conservare e cosa consegnare all’oblio. L’oblio, nella creazione della memoria storica, è importante tanto quanto il ricordo: rivela il piano su cui si è mossa la selezione, dice non dicendo quale scala di priorità è stata applicata al passato collettivo.
Ma cosa ci comunica oggi questa vicenda? La storia e il racconto storico – non sempre scevro da finalità mistificatorie – ci circondano più di quanto siamo soliti ammettere.
Com’è possibile agire oggi con la consapevolezza del ruolo del conservatore di storia? Chi abilitare al racconto, alla conservazione, cosa consegnare all’archivio, e dunque, di fatto, al domani?
Già nel 1937 Nello Rosselli, intenzionato a scrivere la storia del movimento operaio in Italia da Mazzini fino alla nascita del Partito socialista dei Lavoratori nel 1892, si era trovato di fronte ad un’enorme quantità di materiali di natura documentaria e bibliografica: la sfida, in questo caso, consisteva nel “tentativo di radunare le sparse membra”[1] per arrivare a porre su solide basi la sintesi storica sul movimento operaio al tramonto dell’Ottocento. Il rischio insito in questo tipo di operazione è quello di privilegiare alcune testimonianze del passato a discapito di altre, con il fine di cercare una precaria stabilità su un terreno estremamente scivoloso: la costruzione di un sistema di ordinamento delle fonti storiche deve rifuggire tanto dalle velleità di cronaca, quanto dall’eccesso di selettività storica. Lungi dall’indicare soluzioni definitive o assolute alla questione, resta fermo il fatto che un ”organismo”, un racconto storico, per reggersi saldamente in piedi e per riuscire a parlare al nostro presente, deve anzitutto poter contare su tutte le “membra”, le fonti storiche, di cui è composto: l’omissione o la disfunzione riguardante le seconde comporterebbe la costruzione di un racconto storico inerte, un racconto che dialoga unicamente con se stesso.
Il testo di Rosselli porta a richiamare, tra le tante, una questione dalla portata non indifferente: quali sono le modalità di lavoro degli storici, come “si lavora la storia”, quali sono i nessi fra memoria e storia, fra memoria e rimozione, attraverso quali procedure si costruisce un archivio “vivo”; la riflessione, in questo caso, non può che ruotare attorno al dibattito riguardante l’utilità della storia. “A che cosa serve la storia?”
Una domanda che, in passato, ha risuonato soprattutto in tempi bui, in tempi di crisi – quando l’attualità è arrivata a battere con forza alla porta dello studio degli storici.
Ricordiamo, ad esempio, come questo quesito avesse spinto alla riflessione – tra il 1939 e il 1940, nei mesi in cui l’Europa si immergeva nella guerra – due intellettuali, parimenti in tensione fra passato e presente: Marc Bloch e Carlo Levi. Marc Bloch prende avvio da questa domanda per scrivere il suo famoso Apologia della storia o Mestiere di storico (1940). Un anno prima, l’esule Levi nelle sue note personali riflette sul senso del passato in relazione al suo presente, come un rimando di specchi in cui, la conoscenza di ciò che è stato, diviene la lente con cui osservare ciò che è. In quanto “quello che è stato può tornare, quello che è celato riaffiorare alla coscienza, come riappaiono le spiagge al ritirarsi della marea”. (cit “Paura della Libertà” 1975, p.10)
Oggi come allora, quella domanda riecheggia nuovamente in una società che sta vedendo mutare rapidamente le coordinate con cui ha pensato se stessa ed ha “ordinato” il mondo, in cui la conoscenza del passato non è più considerata come un porto sicuro a cui attraccare per riuscire a leggere un presente sfuggente, dai contorni indefiniti e, a tratti, oscuro. Soffermandoci solo alla vecchia Europa, e al suo contesto politico contraddistinto dall’emersione dei nuove destre nazionaliste e da populismi di incerta collocazione, il discorso storico vive una scissione fra le sue componenti di Storia e di memoria. Se è pur vero che la Storia attraversa una crisi dal lato del suo studio, diffusione e conoscenza, assistiamo al contempo al sempre più frequentemente uso di retoriche politiche ammantate di rimandi storici. Memorie e mistificazioni riemergono per giustificare visioni politiche che pongono alla propria base – quando non come proprio fine – identità rigide ed immutabili. Basti considerare il frequente abuso del senso storico, il maldestro utilizzo di eventi storici – svincolandoli totalmente dal contesto entro cui avevano preso forma, per riconoscere un ampio uso improprio della storia, sempre più frequentemente piegata ad assolvere interessi personali e di parte.
Date le distorsioni presenti nell’attuale dibattito, coloro che si occupano di Storia, in tutti i suoi aspetti, non possono più eludere una domanda in particolare: è possibile dar vita ad una memoria storica e ad un racconto del passato che sia proattivo con efficacia nel tempo presente?
In questo scenario, come è possibile riportare al centro del confronto una conoscenza del passato che possa favorire una comprensione delle dinamiche del presente, invece che “giustificarle”?
La capacità di “afferrare il presente”, qualità che dovrebbe esser per eccellenza dello storico e delle storiche, lungi dall’indicarla come soluzione definitiva alle questioni emerse, è uno dei punti da cui ripartire per ridare vita a una Storia che abbia il coraggio di scendere nell’agone pubblico per contribuire ad elaborare prodotti culturali vivi e proattivi nel presente, scevri di qualsivoglia forma di mistificazione.
[1] Nello Rosselli, Di una storia da scrivere e di un libro recente, in “Rivista Storica Italiana”, 31 marzo 1937.