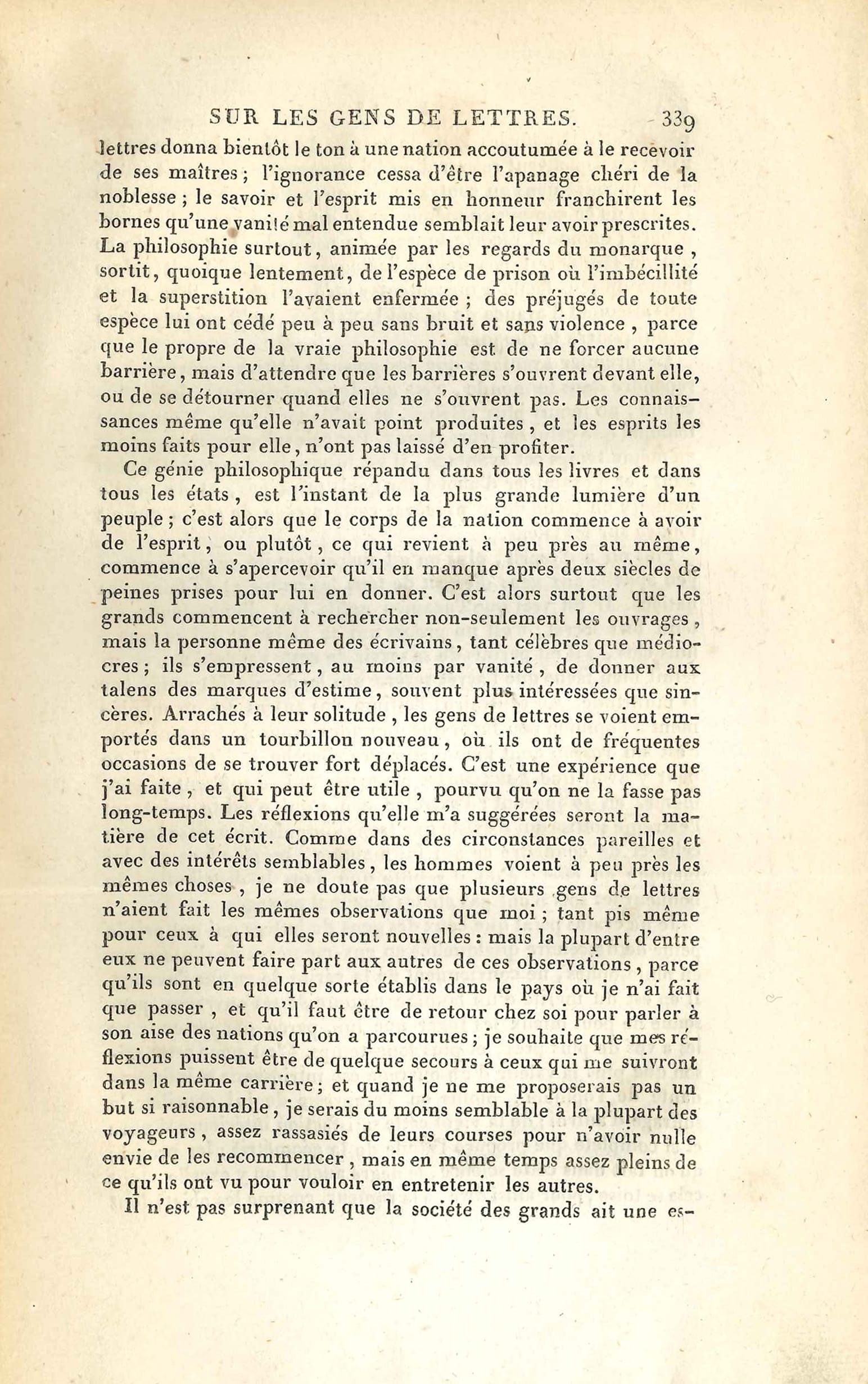La conoscenza è il mezzo per migliorare la condizione umana, per uscire dalla barbarie, ci ricorda in questo saggio Jean Baptiste D’Alembert. Come tale, il suo rapporto con il potere è soggetto a un equilibrio delicato in cui il compito di illuminare e di consigliare può essere assolto solo assumendo una postura critica nei confronti dell’autorità e coraggiosa nei confronti del dovere di ricercare la “verità”. Nello scrivere queste righe, pubblicate nel gennaio del 1753, D’Alembert ha in mente il percorso di coraggiosa emancipazione che caratterizzava la stagione dell’Illuminismo, ma anche lo spettacolo offerto alla sua epoca da schiere di intellettuali prestigiosi che nella loro collaborazione con alcuni dei monarchi più celebri del XVIII secolo hanno spesso rischiato di venir meno alla loro missione di orientamento critico, finendo per ridursi a un ruolo ancillare del potere, abbassandosi ad essere strumenti e cortigiani.
Il tema del rapporto tra conoscenza e politica, tra conoscenza e potere, si muove in queste righe nello spazio che corre tra la carica emancipatrice del sapere e il rischio che questa risorsa resti un’arma nelle mani di pochi, finendo con giustificare e moltiplicare asimmetrie e disuguaglianze.
La «luce» della ragione
Non c’è popolo che non sia rimasto a lungo nella barbarie o piuttosto nell’ignoranza, dato che non è ancora chiaro se queste due parole siano sinonimi. La nostra nazione, per un’affinità di cause, che è pericoloso spiegare quanto è facile conoscere, è rimasta sepolta per molti secoli nelle tenebre più profonde, ma non sarebbe il caso di compiangere la sua sorte se diamo retta a certi filosofi, i quali pretendono che la natura umana si corrompa a forza di lumi. Poiché il nostro secolo corrotto è nel medesimo tempo illuminato, quei filosofi giungono a concludere che la corruzione è l’effetto e la conseguenza del progresso delle conoscenze. Se fossero vissuti nei secoli che chiamiamo barbari, essi avrebbero allora considerato l’ignoranza come la nemica della virtù: il saggio che osserva con sangue freddo tutti i secoli e anche il suo, pensa che gli uomini siano pressa poco simili.
Comunque sia, il giorno è finalmente arrivato per noi; ma come la notte era stata lunga, così sono stati lunghi il crepuscolo e l’aurora di questo giorno. Carlo V, uno dei più saggi e di conseguenza uno dei più grandi principi che abbiano mai regnato, anche se meno celebrato nella storia di una moltitudine di re che sono stati solo fortunati o potenti, fece alcuni tentativi per rianimare nei suoi Stati il gusto delle scienze. Fu senza dubbio tanto illuminato da sentire, fra i disordini che agitavano il suo regno, che coltivare le lettere è uno dei mezzi più sicuri per garantire la tranquillità delle monarchie, per un motivo che può rendere al contrario questa stessa cultura nociva alle repubbliche, quando è spinta troppo lontano; il fatto è che l’attrazione che l’accompagna isola per così dire gli uomini e li rende freddi nei confronti di ogni altro oggetto. Successori, o troppo limitati o troppo dispotici, sembrarono trascurare le sagge vedute di Carlo V, ma il movimento da lui impresso continuò, anche se debolmente, fino a Francesco I, che impresse agli spiriti intorpiditi e languenti un nuovo impulso. Questo principe fu tanto ben educato da amare i dotti o almeno abbastanza abile da proteggerli, giacché talvolta, pur non amandoli, li si protegge e l’interesse o la vanità li inganna facilmente sulle vere ragioni dei riguardi che si hanno per loro. E cosi non v’è nulla che possa essere pari alla loro riconoscenza verso questo monarca: gli intellettuali, come il popolo, si sentono obbligati verso i principi per i più piccoli favori, e, ciò che è molto notevole nella storia dello spirito e del cuore umano, il titolo di padre delle lettere sembra aver contribuito a far dimenticare gli innumerevoli errori di Francesco I, più di quanto il titolo ben più rispettabile di padre del popolo non sia servito a cancellare quelli di Luigi XII. La storia sembra aver collocato il primo di questi due re sulla stessa linea del suo emulo nella gloria, Carlo V, che pur avendo molto più talento di lui, non interessò tante penne, perché lo celebrassero, e trascurò la futile vanità di essere l’idolo di alcuni dotti per l’onore, ancor meno reale e più funesto, di essere il terrore dell’Europa.
Classi sociali e monarchia di fronte alla cultura
La nobiltà francese, incline com’è a prendere ciecamente i suoi re come modelli, non mostrò per le lettere lo stesso gusto di Francesco I. Poco lontana dal tempo in cui eroi che non sapevano leggere vincevano battaglie e soggiogavano province, non conosceva altra gloria che quella delle armi; ed è questa una di quelle circostanze poco frequenti nella nostra storia, in cui la fiacchezza d’animo e il pregiudizio hanno prevalso sul desiderio di far la corte al monarca. La tendenza naturale dei cortigiani all’ignoranza si trovò molto più a suo agio sotto i re che seguirono e che furono tutti protettori poco zelanti delle lettere: non escludo nemmeno Carlo IX, autore di alcuni versi, dei quali non si sarebbe mai parlato se non fossero stati di un sovrano; e nemmeno Enrico IV che, si dice, faceva sì buona accoglienza ai dotti, ma che trattava pressa poco alla stessa maniera tutti i suoi sudditi, perché, dopo aver conquistato il regno, gli restava da assicurarsi il cuore dei suoi popoli e perciò una considerazione troppo marcata per un piccolo numero di uomini non sarebbe servita che ad allontanare la moltitudine.
Nondimeno, mentre da un lato la potenza dei re si era affermata, dall’altro quel germe di conoscenze che Francesco I aveva contribuito a far sviluppare fruttava inavvertitamente nel cuore della nazione, senza espandersi molto verso la periferia: in altri termini, né tra il popolo interamente dedito ai lavori necessari per la propria sussistenza, né tra i grandi signori abbastanza occupati nei loro ozi e nei loro intrighi.
Il secolo di Luigi XIV
Apparve infine Luigi XIV e la stima che egli testimoniò per gli intellettuali dette ben presto il tono ad una nazione abituata a riceverlo dai suoi capi; l’ignoranza cessò di essere l’appannaggio caro alla nobiltà; il sapere e l’intelligenza messi in onore superarono i confini che una malintesa vanità sembrava aver loro prescritto. La filosofia soprattutto, animata dalle attenzioni del monarca, usci, anche se lentamente, da quella specie di prigione in cui l’imbecillità e la superstizione l’avevano rinchiusa; pregiudizi di ogni specie cedettero a poco a poco dinanzi a lei, senza rumore e senza violenza, poiché è proprio della vera filosofia di non forzare nessuna barriera, ma di attendere che le barriere cadano dinanzi a lei, oppure di volgersi altrove quando non si aprono. Anche le conoscenze che essa non aveva in alcun modo prodotto e le menti meno adatte ad essa non hanno trascurato di trarne profitto.
Questo genio filosofico diffuso in tutti i libri e in tutti gli Stati è il momento della più grande illuminazione di un popolo; è allora che il corpo della nazione comincia ad avere ingegno, o piuttosto, ciò che è poi la stessa cosa, comincia ad accorgersi di non esserne privo dopo due secoli di fatiche affrontate per dargliene. È allora che i grandi cominciano a ricercare non solo le opere, ma anche la persona stessa degli scrittori, sia celebri sia mediocri; essi s’affannano, almeno per vanità, a dare ai talenti segni di stima, spesso più interessati che sinceri. Strappati alla loro solitudine, gli intellettuali si vedono trascinati in un vortice nuovo, dove frequenti sono i casi in cui essi vengono a trovarsi molto disorientati. È un’esperienza che io ho fatto e che può essere utile, purché non la si faccia per lungo tempo. Le riflessioni che essa mi ha suggerito saranno materia di questo scritto. Come in circostanze simili e con interessi simili gli uomini vedono a poco a poco le stesse cose, io non dubito che molti letterati abbiano fatto le mie stesse osservazioni; tanto peggio per coloro ai quali esse saranno nuove. Ma la maggior parte di essi non possono partecipare agli altri queste osservazioni perché essi risiedono, per dir così, nel paese per il quale io non ho fatto altro che passare. Bisogna invece essere ritornati a casa per parlare a proprio agio delle nazioni che si son percorse. Mi auguro che le mie riflessioni possano esser di qualche aiuto a quelli che mi seguiranno nella stessa carriera; e quand’anche non mi proponessi un fine cosi ragionevole, sarei almeno simile alla maggior parte dei viaggiatori, tanto stufi delle loro corse da non aver alcun desiderio di ricominciarle, ma nel medesimo tempo così pieni di ciò che han visto da voler intrattenere su di esse gli altri.
Intellettuali e potenti
Non c’è nulla di sorprendente nel fatto che le relazioni con i potenti esercitino una grande attrazione sugli intellettuali. L’utilità reale o apparente che possono trarre da un tale commercio è facile a prevedersi, mentre gli inconvenienti non possono essere conosciuti se non con la pratica di questo stesso commercio. Tale è la miseria dell’amor proprio: benché riceva spesso profonde ferite da ciò che non sembrerebbe doverlo sfiorare, benché sia molto più facile scontentarlo che soddisfarlo, si nutre più facilmente di ciò che subito lo illude, da non sospettare ciò che potrà colpirlo.
Il primo vantaggio che gli intellettuali trovano nell’entrare nel mondo è che il loro merito diviene, se non più conosciuto, almeno più celebrato, e che essi sono giudicati da un tribunale diverso da quello dei loro rivali. Per sviluppare ed apprezzare nel medesimo tempo questo vantaggio è necessario risalire più in alto ed esaminare in primo luogo su quali principi e in quale maniera si cerchi di procurare questa specie di gloria che è fondata sul talento.