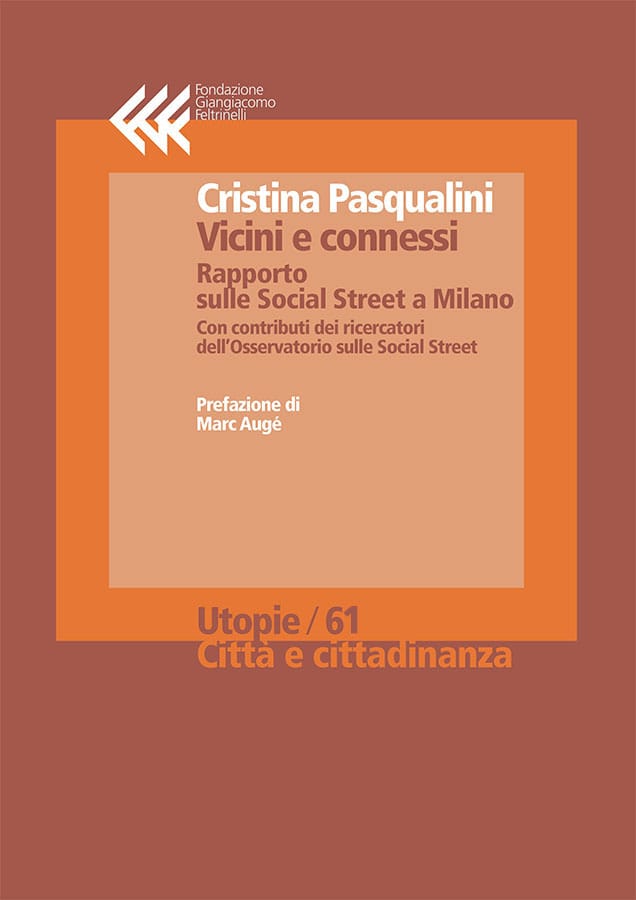Le nuove tecnologie della comunicazione hanno fatto il loro accesso nel XX secolo e si sono diffuse sino ai nostri giorni, in maniera apparentemente irreversibile, sempre più totalizzante e capillare; sono entrate prepotentemente nelle nostre vite, ridisegnando le nostre abitudini, il modo in cui facciamo esperienza del mondo, in cui entriamo in relazione con le altre persone, vicine e lontane. Rispetto alle tecnologie della comunicazione, tra le persone permangono tuttavia delle differenze dovute ad esempio al digital divide e al gap generazionale tra i nativi digitali e gli over 70, che producono e riproducono disuguaglianze, legate al loro accesso e utilizzo. Nel nostro tempo prende piede un nuovo tipo di discriminazione tra quanti partecipano alla comunicazione elettronica e quanti ne sono più o meno esclusi. La novità è che la capacità di costruire relazioni, “amicizie”, è diventato il criterio discriminante. Obama e Lady Gaga hanno milioni di amici sui social network. Saremmo tentati di distinguere due forme di solitudine: quella tradizionale – a sua volta ambivalente perché può essere ricercata così come si cerca la calma e la possibilità di ritrovare se stessi, o temuta, quando viene imposta attraverso l’isolamento – e le nuove solitudini legate alla pratica sistematica e illusoria di quelle che chiamiamo reti sociali, che può portare all’alienazione e alla nevrosi [Augé 2017].
La nozione di rete sociale riassume le contraddizioni della situazione attuale. L’uomo è un animale simbolico e ha bisogno di relazioni inscritte nello spazio e nel tempo: ha cioè bisogno di “luoghi” in cui la sua identità individuale possa costruirsi a contatto e a confronto con gli altri. Il fascino esercitato dai mezzi di comunicazione elettronici ne è la prova, ma il loro ideale di ubiquità e istantaneità è contrario all’apprendimento della relazione tra individui, che ha bisogno invece di tempo e spazio.
Davanti a ciò che è percepito come una spersonalizzazione delle relazioni sociali e alla comparsa di nuove forme di isolamento e solitudine, le relazioni umane sono spettacolari. In un certo senso passiamo il nostro tempo a cercare di fare dei luoghi. La grande città ci fornisce quotidianamente punti di riferimento temporali, sia quelli della grande storia, che commemoriamo a intervalli regolari, sia quelli della nostra storia personale: una geografia intima si mescola così alla struttura collettiva della città. Le due cose si ricongiungono in alcuni luoghi, per esempio nelle piazze pubbliche, che in Italia sono da sempre luogo di incontri e di scambio di opinioni. Creiamo quotidianamente abbozzi di luoghi, seppur effimeri o superficiali: al caffè dell’angolo, dal panettiere, nei negozietti del quartiere. I ragazzi si incontrano nei grandi spazi dei centri commerciali. In tal modo è impossibile stabilire liste assolute di luoghi e di non luoghi nel senso empirico del termine: tutto può diventare un luogo. È senza dubbio questa la ragione per cui alcuni, quali che siano le loro motivazioni, tentano di creare dei nuovi luoghi, in una modalità ludica ed effimera (i villaggi vacanza) o in maniera più stabile (alcuni pensionati francesi vanno a stabilirsi vicino al mare in Marocco o in Portogallo). Mirano a creare dei nuovi legami, delle nuove forme di relazione in un ambiente propizio. Questi modelli di utopie realizzate sono le eterotopie di cui parlava Foucault.
Nonostante le illusioni diffuse dalle tecnologie della comunicazione (dalla televisione a internet), noi viviamo là dove viviamo. L’ubiquità e l’istantaneità restano delle metafore. L’importante con i mezzi di comunicazione, è di prenderli per quello che sono: dei mezzi capaci di facilitare la vita, ma non di sostituirsi ad essa. Da questo punto di vista, la missione da compiere è immensa. Si tratta di evitare che la sovrabbondanza delle immagini e dei messaggi dia lungo a nuove forme di isolamento. Per frenare tale deriva, ormai evidente, le soluzioni saranno necessariamente spaziali, locali, insomma politiche, nel senso più ampio del termine. Come conciliare nello spazio urbano il senso del luogo e la libertà del non luogo? È possibile ripensare l’insieme della città e il dettaglio dei suoi alloggi? Una città non è un arcipelago. L’illusione creata da Le Corbusier di una vita incentrata sulla casa e sull’unità di abitazione collettiva ha prodotto le “stecche” delle nostre periferie, rapidamente disertate dai negozi e dai servizi che avrebbero dovuto renderle vivibili. In esse è stata trascurata la necessità della relazione sociale e del contatto con l’esterno.
Al centro di queste città la vita è intensa, la piazza pubblica resta un luogo di incontro, si circola in bicicletta, ed è naturale ritrovarsi in mezzo ai grandi luoghi storici. Un altro esempio riguarda la vita di quartiere, ad esempio in un arrondissement parigino e non solo. La vita di quartiere è quella che si può osservare per la strada, nei negozi, nei caffè [Augé 2015]. A Parigi, in cui da molti anni la città risulta sempre più difficile, è su scala ridottissima che si percepiscono quei fragili legami che resistono al disincanto: le conversazioni al banco del bistrò, gli scherzi scambiati tra una persona anziana e una giovane cassiera al supermercato, le chiacchiere dal droghiere tunisino sono tutte forme modeste di resistenza all’isolamento che sembrerebbero provare che l’esclusione, la chiusura in se stessi e il rifiuto dell’immaginazione non sono una fatalità [Augé 2014].
La città ideale guarda al locale, perché è nel locale che le relazioni sociali sono reali/concrete/tangibili nella loro bellezza, diversità e complessità, senza tuttavia dover necessariamente rinunciare alla libertà a cui siamo abituati quando attraversiamo i non-luoghi o chattiamo e navighiamo in Rete.
Se è vero che le persone hanno bisogno di luoghi, le social street sono una risposta nuova e innovativa che va esattamente in questa direzione: “addomesticare i luoghi, renderli familiari”.
Una social street nasce dal desiderio dei residenti in una strada spenta e a-sociale di ricercare e creare nel territorio – in forma non individuale ma partecipata e collettiva – punti di incontro, ossia luoghi, dove incontrarsi, conoscersi, fare cose assieme, aiutarsi. Le social street sono nuovi-luoghi [Augé-Pasqualini 2016]: in origine sono strade fisiche anonime, abitate da sconosciuti, in cui le persone iniziano a conoscersi e frequentarsi e progressivamente assieme trasformano il territorio/il vicinato in un nuovo-luogo, in un luogo sociale, ricco di relazioni personali. Per raggiungere questo obiettivo, le social street si sono dotate di gruppi su Facebook, il social network più utilizzato al mondo, che svolge la funzione di connettore e facilitatore. A differenza delle comunità online in cui le relazioni tra gli individui sono sempre in potenza, nei gruppi Facebook delle social street le relazioni sono sia promesse di relazioni che, per alcuni, anche relazioni calde e familiari. Perché far parte di una social street vuol dire incontrarsi online ma possibilmente anche offline, sia nel social network che in strada. Le social street sono strade comuni, che a partire da Facebook, senza risolversi in esso, tornano ad essere vissute intensamente da chi ci abita, recuperando una sorta di dimensione comunitaria che fa sentire le persone a casa, parte di/appartenenti a/meno sole.
Esperienze come le social street possono forse apparire troppo complesse, impegnative, utopistiche, per pochi, per giovani. In realtà è un dato di fatto che le social street esistono, funzionano e sono uno strumento per molti. Il lavoro di ricerca realizzato dall’Osservatorio sulle Social Street offre una lettura approfondita e rigorosa di questo fenomeno e mostra da un lato il bisogno forte e radicato antropologicamente nelle persone di luoghi e di viverli e, dall’altro, un nuovo modo di farlo, attraverso la Rete.
Cristina Pasqualini ha intuito ben presto che il fenomeno delle “social street” fosse importante e foriero di speranze per il futuro. Il mondo si urbanizza e i termini “globalizzazione” e “urbanizzazione” sono molto vicini all’essere sinonimi. In questo contesto, tutti gli sforzi per lottare contro le forme di solitudine e di anonimato che si manifestano in città sono i benvenuti.
Gli abitanti delle “social street”, dal momento che hanno stabilito relazioni sociali facendo ricorso agli strumenti della comunicazione, utilizzano questi ultimi come mezzi, in modo legittimo ed efficace, e preservano la dimensione simbolica dello scambio. Avendo colto prima del tempo questo aspetto, Cristina Pasqualini ha sviluppato una ricerca pioneristica su ciò che, un domani, potrebbe essere considerato come una rivoluzione pacifica, ma radicale, della società.